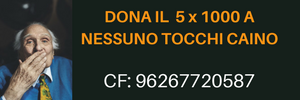02 Gennaio 2013 :
Percorriamo Kabwe Road, la strada che dalla capitale dello Zambia Lusaka porta in Tanzania, per arrivare al carcere di massima sicurezza di Mukobeko. Un centinaio di chilometri di asfalto grigio che attraversa un paesaggio piatto di terra rossa e che a tratti è costeggiato da giacaramba, splendidi alberi i cui rami estesi, cosparsi di fiori viola, sembrano aver catturato leggere nuvole colorate.
L’autista ci spiega che “kabwe” vuol dire sassolino, probabilmente in memoria dell’attività estrattiva di piombo, zinco e rame avviata nei primi del Novecento dagli inglesi e i cui scarti di lavorazione, ammassati senza regole sul terreno o gettati nell’acqua, fanno dell’omonima cittadina, caduta in disgrazia con la recente chiusura delle miniere, uno dei luoghi più inquinati al mondo.
Il degrado è palpabile quando la attraversiamo prima di prendere una strada laterale sterrata che ci porta dritti al penitenziario di massima sicurezza: una specie di fortino costruito negli anni ’50 coi muri bianchi e un grande portone di legno che cerco di fotografare ancora prima di scendere dalla macchina provocando la reazione degli agenti.
A differenza dei miei compagni di viaggio, il Senatore Radicale Marco Perduca e Mariarita Levato dell’ambasciata italiana, per me è la seconda volta che varco questa soglia oltre la quale scopri una concentrazione di essere umani e un carico di dolore che non hai mai visto al mondo. Avevo già messo piede a Mukobeko nel 2004 in occasione di un’altra missione di Nessuno tocchi Caino senza che avessimo però avuto la possibilità di incontrare i detenuti condannati a morte. Che questa volta abbiano autorizzato una visita anche nel braccio della morte, è già un piccolo segno di cambiamento in questo Paese.
Una scritta nera sopra la porta indica l’ufficio dell’officer in charge, una piccola stanza quadrata con una scrivania per il capo e una lavagna appesa al muro su cui sono segnati col gesso i numeri della sofferenza quotidiana di questa struttura costruita dagli inglesi oltre mezzo secolo fa. I posti regolamentari, circa 400, sono quelli di allora, ma nel frattempo i detenuti sono diventati 1.771, ammassati in due dormitori e un braccio della morte: 1.159 condannati definitivi e 236 in attesa di giudizio, 104 condannati a vita e 271 condannati a morte, 2 con pena commutata. Il sovraffollamento affligge tutte le prigioni del Paese, 53 edifici del periodo coloniale concepiti per ospitare 5.000 persone e che oggi “tollerano” la presenza di 16.000 detenuti. I 1.800 agenti di custodia in servizio in tutto il Paese sono assolutamente inadeguati e impotenti di fronte alla catastrofica situazione delle carceri zambiane. Nelle condizioni igienico sanitarie e nella promiscuità di strutture così fatiscenti, malattie come la malaria, la tubercolosi, la scabbia e l’Aids la fanno da padrone, e non perdonano.
Ad alleviare un po’ il carico di pene e sofferenze nelle prigioni ci hanno pensato gli ultimi Presidenti con le loro periodiche commutazioni delle pene. Primo fra tutti Levy Mwanawasa, il Presidente più buono della storia dello Zambia. Cristiano battista di sentimenti abolizionisti, durante tutto il suo mandato, si è rifiutato di firmare i decreti di esecuzione e ha commutato numerose condanne a morte. “La pena di morte è contro i miei principi e voglio assolutamente abolirla,” aveva detto appena eletto. “Le persone non possono essere mandate al macello come fossero polli, e finché sarò Presidente non firmerò alcun ordine di esecuzione. Non voglio essere il capo dei boia.” L’ultimo massiccio atto di clemenza del Presidente Mwanawasa è dell’agosto 2007, quando ha rimesso in libertà 823 detenuti e commutato in ergastolo le condanne a morte di 97 prigionieri, decongestionando un po’ diverse prigioni del Paese. Inoltre, si era rivolto alle autorità penitenziarie perché venissero liberati anche i detenuti che avevano osservato buona condotta e quelli più malati.
Lasciamo la saletta della lavagna e, superata una zona di transito dipinta d’azzurro, accediamo attraverso un grande cancello a un’area all’aperto, dove un secondo e più piccolo cancello ci viene spalancato su uno spazio assolato grande come un campo da calcio. Al centro del cortile alcuni detenuti giocano a pallone e alzano un polverone che nella luce accecante crea una nebbia fitta dalla quale si intravedono capannelli di carcerati ai margini del campo. Costeggiando il muro di cinta vi è una sequenza di costruzioni. La prima è un piccolo edificio a un piano che dovrebbe essere il centro clinico come conferma la scritta sul muro. “Al momento è chiuso,” ci dicono le guardie e non insistiamo per vederlo.
Sul lato opposto all’entrata ci sono due blocchi di dormitori, edifici a un piano costituiti da sei cameroni divisi a metà da un lungo corridoio buio. Entriamo nel primo e il colore turchese dei muri attenua l’impatto con la dura realtà del carcere. L’odore di urina ed escrementi ci assale in modo nauseabondo. Il silenzio è assoluto nelle celle, svuotate prima della nostra visita nel vano tentativo di renderle frequentabili. In un camerone rettangolare che sarà stato di 10 metri per 5 sono accatastati per terra un numero spropositato di materassi. Dopo il turchese e il bianco divenuto ormai grigio delle pareti mi appare verso l’alto una terza fascia di colore marrone, che a guardare meglio è costituita da una fitta coltre di scarafaggi. Il bagno in fondo alla stanza è un bugigattolo di circa due metri quadrati con un buco alla turca e un rubinetto fissato al muro sotto il quale un secchio di plastica rossa pieno di un’acqua grigia e schiumosa funge da sciacquone.
Nella stanza, ci dicono, dormono 51 detenuti. Mi pare una sfida alle leggi della fisica che può essere vinta ogni notte solo grazie a un perfetto gioco di incastri dei corpi che per occupare meno spazio sono costretti a giacere sui fianchi e con la testa di uno dove l’altro ha i piedi.
Quando usciamo all’aperto alcuni detenuti fuori dal polverone della partita sono accovacciati attorno a dei grandi sassi su cui hanno messo a essiccare pezzi di animali: pesciolini, ali di non saprei dire quale volatile, interiora, insetti e bocconi di misero cibo che i parenti hanno portato nei giorni di colloquio.
Proseguiamo verso l’area dei laboratori e della cucina. Nella stanza dei computer, piuttosto buia, sei computer e quattro stampanti sono poggiati su tavoli di legno consumati dal tempo. Ci sono due ragazzi intenti a scrivere. La cucina è uno stanzone più luminoso con al centro quattro grandi bollitori d’acciaio. E’ qui che si prepara il pasto base e, temiamo, anche l’unico dei carcerati di Mukobeko: una specie di polenta a base di tapioca oppure fagioli, riso e pesce fritto. Alcuni detenuti stanno lavando il pavimento e quando usciamo vediamo l’acqua insaponata scorrere a rivoli lungo il muro esterno del fabbricato.
Poco più avanti, attraverso un varco in una barriera di rete metallica, entriamo nell’area di massima sicurezza del carcere, un edificio di due piani fatto di due blocchi separati da un cortile interno. In quest’area sono rinchiusi anche i condannati a morte.
Ogni braccio ha dodici celle con un ballatoio che corre lungo tutto il secondo piano. Ogni cella misura solo due metri e mezzo per due e si suppone ospiti solo uno o due detenuti. Fatti i conti, dovrebbero starci 48 o al massimo 96 persone. Ma i condannati a morte presenti oggi a Mukobeko sono 271 e, quindi, ne hanno sistemati cinque o sei per cella con solo due materassi da condividere. Nella prima cella, piccolissima, i due materassi stesi a terra ci stanno a mala pena in lunghezza e il detenuto che incontriamo ci dice, avvilito, che anche nelle celle più grandi la situazione è proporzionalmente la stessa se non addirittura peggiore. Non ci sono servizi igienici né impianti di ventilazione. “Improvvisiamo delle latrine tagliando contenitori di plastica da due litri e mezzo o cinque litri, per i bisogni. È traumatico.” Durante il giorno i detenuti del braccio della morte vengono fatti uscire dalle loro celle ma lo spazio a loro disposizione è di solo tre metri per trenta di lunghezza.
Nel cortile sterrato tra i due padiglioni scorre un rivolo di acqua putrida che ci accompagna verso l’uscita da questo girone dell’inferno in terra.
Nella stanza del funzionario di turno che passiamo a salutare, incontriamo Herman Mvola, un uomo di 54 anni, accusato nel 1985 di omicidio ed entrato in carcere nel 1987. Ci racconta la sua storia con voce mite. In quasi un quarto di secolo passato a Mukobeko, ha visto andare al patibolo 26 compagni di sventura: 18 nel 1989 quando comandava ancora Kenneth Kaunda, il padre della patria al potere dai giorni dell’Indipendenza; gli altri 8 sono stati impiccati tutti lo stesso giorno di gennaio del 1997, quando era Presidente Frederick Chiluba. Poi è arrivato Mwanawasa e la forca si è fermata. La sua condanna a morte è stata commutata in ergastolo insieme a quelle del 2005 ed Herman è ancora riconoscente per la grazia ricevuta. Anche se il Presidente buono non c’è più, lui spera in una scarcerazione definitiva e confida nel suo successore, Rupiah Banda, che ha fin qui dimostrato di voler seguire la stessa linea di giustizia temperata dalla clemenza.
Lontano ormai dal carcere di massima sicurezza, incontriamo Peter Kunda, un uomo che ha vissuto per 27 anni all’ombra della forca di Mukobeko. Fino al 21 novembre del 2007, quando il Presidente gli ha concesso la grazia. Ora parla appassionatamente contro la pena capitale: “nessun criminale, non importa quanto incallito possa essere, merita di essere impiccato”. “Abbiamo appreso il Diritto dai nostri insegnanti coloniali. Ma i nostri antichi colonizzatori non impiccano più la gente nei loro Paesi. Perché dovremmo continuare a farlo noi?”
Tutti i parlamentari che abbiamo incontrato nel corso della missione sponsorizzata dall’Unione Europea hanno espresso la loro personale contrarietà alla pena capitale, ma l’opinione pubblica nutre sentimenti diversi. E’ in corso da anni un processo di revisione costituzionale che, dopo ampie consultazioni nel Paese, ha fatto emergere un orientamento al suo mantenimento. Spetta al Parlamento l’ultima parola sul testo definitivo della nuova carta fondamentale da sottoporre poi a referendum.
Non so se e quando lo Zambia abolirà la pena di morte. So solo che noi europei che nell’era coloniale abbiamo esportato in Africa anche la “civiltà” di punizioni come quelle corporali e patiboli come la forca del tutto ignoti nel continente, abbiamo oggi il dovere di aiutarli a liberarsi di quelle pene e di quei patiboli. E a liberarsi non solo della pena di morte ma anche della pena di una vita da scontare in luoghi ai limiti dell’umanità come il carcere di Mukobeko.