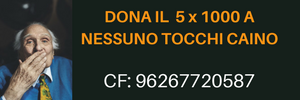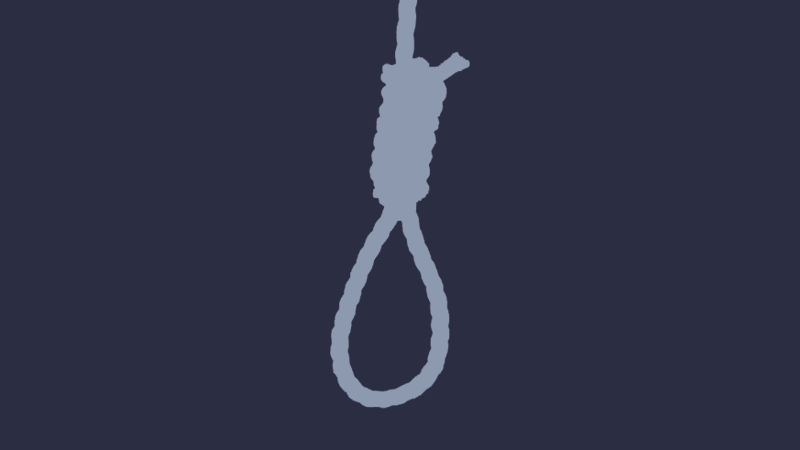02 Gennaio 2013 :
Prefazione al Rapporto 2012, di Sergio d'Elia, Segretario di Nessuno tocchi Caino
Nella “terra delle mille colline” come è conosciuto il Ruanda, la capitale Kigali è il modello plastico dell’intero Paese, coi suoi sali-scendi da montagne russe che mettono a dura prova il motore e i freni delle macchine. Le strade ben illuminate, gli alberi di palma perfettamente allineati e le aiuole senza un filo d’erba fuori posto, testimoniano della rinascita economica e civile di un Paese divenuto in pochi anni uno dei più puliti, ordinati e sicuri dell’Africa.
Ma è soprattutto nel settore della Giustizia che è stato compiuto il capolavoro di civiltà e di efficienza, un vero e proprio miracolo in un Paese che nel 1994 ha conosciuto la versione contemporanea più terribile della vicenda millenaria di Caino e Abele. L’invidia degli Hutu nei confronti dei Tutsi sembra trarre origine dallo stesso tempo e dallo stesso tema della Bibbia. Come Abele i Tutsi avevano bestiame, come Caino gli Hutu lavoravano nei campi.
Per la verità, Hutu e Tutsi hanno condiviso in pace la stessa terra per secoli, fino al 1916, quando i coloni belgi sono arrivati con le loro forche e i loro pregiudizi. Hanno trovato i Tutsi più alti e più belli degli Hutu e hanno deciso che erano anche più forti e intelligenti. Quando mezzo secolo dopo se ne sono andati, hanno lasciato un Paese diviso dalla razza e dall’odio. L’odio nei confronti di chi aveva bestiame e potere era già esploso nei massacri dei Tutsi del 1959, del 1963 e del 1992. Il massacro del ‘94 doveva essere quello della soluzione finale. In soli cento giorni, nell’indifferenza e nel silenzio complice della comunità internazionale, un milione di Tutsi, un quinto della popolazione del Ruanda, è stato sterminato dagli Hutu, maggioranza nel Paese. Li hanno presi casa per casa e cacciati per giorni nei campi di fagioli, di tè, caffè e canna da zucchero o nei boschi dove si erano nascosti. Li hanno massacrati, stuprati e mutilati a colpi di machete. Li hanno bruciati vivi nelle loro case, nelle scuole e perfino nelle chiese dove si erano rifugiati.
Se i giustamente critici sul trattamento dei delitti e delle pene nel proprio Paese sapessero cosa è riuscito a fare il Ruanda dopo il genocidio, si asterrebbero dalla falsa e offensiva retorica comparativa che gli fa dire con non chalance della propria amministrazione della giustizia: “è peggio che in Ruanda”.
Il miracolo giudiziario ruandese si chiama Gacaca (pronuncia gachacha), che letteralmente significa “prato” o “erba”, in riferimento ai luoghi aperti e partecipati dove un tempo si riuniva la gente del villaggio per risolvere piccole o grandi controversie individuali.
La mattanza del ‘94 non aveva risparmiato giudici, procuratori e cancellieri: i primi ridotti da 758 a 244, i secondi da 70 a 12, i terzi da 631 a 137. Le corti ordinarie ruandesi hanno cominciato a trattare i casi legati al genocidio nel 1996 e dopo cinque anni erano riuscite a definirne solo 6.000. Nello stesso periodo, il Tribunale Penale Internazionale stabilito dall’ONU ad Arusha (Tanzania) per giudicare i crimini commessi in Ruanda aveva trattato solo 6 casi. A questo ritmo ci sarebbero voluti più di 100 anni per decidere il destino solo dei 120.000 detenuti che nel 2001 erano ancora in attesa di giudizio in carceri fatiscenti, dove 10.000 persone erano già morte dal 1994.
Nel 2002, per risolvere la difficile situazione dei processi pendenti e delle carceri sovraffollate che rischiava di sopraffare il Ruanda, è stato recuperato, riformato e codificato il metodo tradizionale di giudizio e riconciliazione delle corti Gacaca. Nel 2001, più di 250.000 giudici, la maggioranza dei quali Hutu, sono stati eletti dalle loro comunità in circa 11.000 giurisdizioni. Le prime udienze delle corti si sono tenute nel marzo 2005 in alcune zone pilota e, l’anno dopo, in tutto il Paese. La scena consueta mostra nove giudici che siedono su un lungo tavolo di legno davanti agli abitanti del villaggio. Al centro del prato compare l’imputato che racconta la sua versione dei fatti. Poi tocca alle vittime sopravvissute al genocidio, ai parenti degli uccisi e ai testimoni oculari dire la loro. In una settimana, i giudici devono decidere i crimini di cui l’imputato è responsabile e la pena che si merita. Il condannato ha diritto a un processo di appello davanti a una corte Gacaca di grado superiore e, nel caso, a una revisione del processo.
Il 18 giugno, dopo dieci anni di attività, le corti Gacaca hanno concluso la loro missione e il rapporto finale sul loro operato è stato consegnato dal Ministro della Giustizia Tharcisse Karugarama al Presidente della Repubblica Paul Kagame in una cerimonia solenne che si è svolta alla Camera dei Deputati. Siamo stati invitati ad assistere come Nessuno tocchi Caino, che nel 2007 ha conferito al Presidente Kagame il Premio “L’abolizionista dell’Anno”. La scelta di principio, nel senso anche di principiare, di iniziare col dare luogo e forma a tribunali e a processi è stata di per sé un fatto di primario valore giuridico che va riconosciuto al sistema della Gacaca. La decisione, poi, di abrogare la pena di morte è stata un atto dallo straordinario valore simbolico, con il quale il Ruanda ha emblematicamente inteso spezzare la catena perpetua dell’odio e della vendetta, superare la logica aberrante del machete e della forca.
Il bilancio della giurisdizione Gacaca è senza precedenti: in sette anni hanno trattato quasi due milioni di casi, la maggioranza dei quali relativa a reati contro la proprietà e circa 640.000 a omicidi e mutilazioni commessi nel corso del genocidio. La stragrande maggioranza degli indagati è stata assolta o condannata a pene alternative alla detenzione e, alla fine, anche le Nazioni Unite hanno riconosciuto che i processi Gacaca erano “ben lungi dall’essere” una forma di giustizia popolare e sommaria, come i puristi del diritto li avevano subito bollati.
“Il sistema Gacaca ha avuto le sue imperfezioni, ma i suoi critici non offrivano valide alternative che potessero fornire i risultati di cui avevamo bisogno”, ha detto il Presidente Kagame alla cerimonia di chiusura dei tribunali Gacaca, il cui operato – ha fatto notare Kagame – è incomparabile all’operato del Tribunale Penale Internazionale, che in diciassette anni ha trattato una novantina di casi a un costo di 1 miliardo e 700 milioni di dollari, mentre i Gacaca, con quasi due milioni di casi trattati in dieci anni di vita, sono costati poco più di 48 milioni di dollari. Il sistema Gacaca, ha continuato il Presidente, “ha sfidato ogni ruandese a praticare introspezione e ricerca interiore, il che ha portato a dire la verità e alla giustizia, alla guarigione e alla riconciliazione del Paese”.
Chiusa l’esperienza delle corti Gacaca, nelle carceri rimangono ora 37.000 detenuti per reati legati al genocidio, ma non è raro incontrare nelle strade di Kigali, impegnati in lavori di ordinaria manutenzione, detenuti in attesa di giudizio che si riconoscono dall’uniforme rosa, detenuti condannati in via definitiva vestiti di arancione e condannati ai lavori di pubblica utilità con la tuta blu.
Gli archivi della giurisdizione Gacaca sono un patrimonio prezioso dell’umanità da preservare e tramandare, tanto sono zeppi di storie che raccontano di un immenso dolore, ma anche di una ritrovata unità, fiducia e riconciliazione tra Hutu e Tutsi. Come la storia che all’apertura della cerimonia di Kigali hanno raccontato Alice Mukarurinda ed Emmanuel Ndayisaba, una superstite del genocidio del ‘94 e il suo aggressore.
Diciotto anni dopo, i ricordi di Alice sono ancora freschi. L’11 aprile, i soldati Hutu e gli uomini della milizia Interahamwe (quelli che lottano insieme), addestrati a combattere con machete e pistole, hanno attaccato la città di Nyamata e appiccato il fuoco alla grande chiesa dove si erano rifugiati i Tutsi. Alice era riuscita a fuggire prima insieme al marito e alla figlia Fanny di nove mesi, mentre la madre e due sorelle sono arse vive insieme ad altre cinquemila persone. Prima si sono nascosti nei campi intorno al fiume Akagera tra piante di fagioli e alberi di banane e quando gli Hutu hanno incendiato i campi hanno vagato tra le paludi nascondendosi tra le canne. Il marito è scappato da una parte e lei dall’altra. Gli Interahamwe l’hanno scoperta il 29 aprile, le hanno strappato la bambina dalle braccia e l’hanno tagliata in due con un colpo secco di machete. Poi si sono accaniti su di lei. Le hanno mozzato una mano, conficcato una lancia nella spalla e l’hanno colpita in testa con una mazza costellata di chiodi. “Se ne sono andati quando pensavano che fossi morta.” Dopo cinque giorni passati tra la vita e la morte, si è svegliata nella palude circondata da cadaveri mangiati dai cani. Il marito l’ha trovata lì. Lo avevano gettato in un pozzo, ma si era salvato. “Dov’è la mia bambina?”, è la prima cosa che ha chiesto. “Dobbiamo andare a seppellirla”, le ha risposto. Ma i massacri erano ancora in corso e non c’era un posto per farlo come si deve, così l’hanno solo coperta. Il cruccio di Alice è che non riesce ancora oggi a darle una degna sepoltura, perché non se la sente di tornare alla palude.
Prima del genocidio, Emmanuel Ndayisaba era un operaio metallurgico e cantava nel coro di una chiesa avventista. E’ stato reclutato dai soldati Hutu ed è andato con loro in una casa dove si nascondevano i Tutsi. L’hanno circondata ed Emmanuel è entrato dentro armato di machete. C’erano quattordici persone rannicchiate sul pavimento e le ha uccise tutte, compresa una donna con il suo bambino in braccio. Ha anche ucciso un uomo che conosceva bene: era il suo vicino di casa. “L’ho fatto perché volevo avere una mucca, non pensavo che ne avrei mai posseduta una in tutta la mia vita”, ha spiegato Emmanuel, a riprova della banalità del male. Dopo averne uccisi quattordici, Emmanuel non aveva più paura e, il giorno dopo, è andato di nuovo insieme ai soldati a scovare i Tutsi di casa in casa. Ha trovato un uomo e l’ha ucciso. Il terzo giorno, in un altro posto, ha ucciso un’altra madre e il suo bambino. Il quarto giorno, è andato a caccia di Tutsi nelle paludi di Nyiragongo e lì ha visto per la prima volta Alice. Le ha tagliato una mano e sfregiato il viso. Alice è stata l’ultima persona che ha preso a colpi di machete, poi Emmanuel ha smesso di uccidere e tagliare. “Ero tormentato dalle grida e dai volti delle persone che avevo massacrato.” Alcuni li aveva visti davanti al coro nella chiesa avventista. “Come ho fatto a uccidere le stesse persone per le quali cantavo?”
Dopo che il Fronte Patriottico Ruandese ha posto fine al genocidio formando un nuovo governo, nel 1996 Emmanuel è andato davanti a un giudice e ha detto quello che aveva fatto. Lo hanno messo in prigione insieme al padre in una cella dove i detenuti erano stipati uno sull’altro come in un sacco di fagioli. Emmanuel è uscito sette anni dopo, grazie alla clemenza concessa a tutti quelli che avevano confessato. Il padre non aveva collaborato con i giudici ed è morto in carcere per malattia.
La seconda volta che Emmanuel ha visto Alice è stata nel 2003, quando ha aderito a un’associazione chiamata Ukuri Kuganze (la verità prima di tutto), composta da sopravvissuti e autori del genocidio. Insieme, hanno preso un pezzo di terra e l’hanno coltivata, hanno allevato il bestiame e costruito case per gli orfani del genocidio. Alice non si ricordava più il suo viso. Emmanuel, invece, la faccia di Alice ce l’aveva ben impressa nella mente, ma non aveva idea di come avvicinarsi a lei. “Avevo paura, ogni volta che i nostri occhi si incontravano, volevo scappare.”
Un giorno, Emmanuel ha portato al campo birra di sorgo e patate dolci. Ha cotto le patate sulla griglia, ha preso quella più grande e l’ha data ad Alice. Si è fatto coraggio, l’ha chiamata in disparte e ha chiesto di parlare con lei. Ho un grosso problema, continuava a ripetere senza dire quale. Dapprima Alice ha pensato che fosse malato o in difficoltà e chiedesse aiuto. Dopo un bel po’, si è messo in ginocchio e le ha chiesto perdono. “Per cosa ti devo perdonare?”, gli chiedeva Alice, ma lui continuava a dire “ti prego perdonami, ti prego perdonami”. Alla fine è scoppiato in lacrime e le ha rivelato: “Io sono quello che ti ha tagliato la mano e la faccia”, e le ha spiegato dove e quando. Alice lo ha lasciato lì in ginocchio ed è scappata via. Dopo aver girovagato a lungo, è tornata a casa e ha raccontato alla famiglia quello che era successo. Sulle prime, il marito le ha detto che era colpa sua, perché aveva scelto di stare in una associazione con degli assassini. Poi le ha ricordato che aveva promesso a Dio che avrebbe perdonato il suo aggressore se un giorno lo avesse incontrato. “Ora lo hai trovato… perché stai esitando?”. Per un mese Alice ha riflettuto e pregato, poi è tornata al lavoro, ha cercato Emmanuel e gli ha detto: “Io ti perdono… Se Dio vuole, ti perdonerà”. Quando Emmanuel è comparso davanti al tribunale Gacaca, Alice ha fatto di tutto per evitargli una pena pesante.
Alice ed Emmanuel ora sono grandi amici. Alla celebrazione di chiusura dei processi Gacaca, non si sono mai separati. Sono arrivati insieme e si sono seduti una accanto all’altro, hanno condiviso il cibo e sono andati via insieme.
I tribunali della Gacaca non sono stati soltanto un modo di rendere giustizia in tempi ragionevoli alle vittime di una violenza infinita. Sono stati anche la prova – come ha detto il Presidente Kagame – della “forza liberatoria della verità”, sulla quale il Ruanda sta costruendo il suo futuro, nella Terra delle mille colline abitata non più da Tutsi e Hutu ma solo da ruandesi.