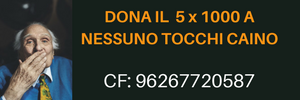02 Gennaio 2013 :
L’approvazione, nel dicembre 2007, della Risoluzione per la Moratoria Universale delle esecuzioni capitali da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è stata una tappa fondamentale non solo della lotta alla pena capitale ma anche per l’affermazione dello Stato di diritto e di quei diritti naturali storicamente acquisiti e spesso scritti nelle leggi dei Paesi, ma non rispettati.
Dopo quel voto, i soliti commentatori più realisti del re e gli osservatori solo della real politik hanno tentato di sminuirne la portata, dicendo che “tanto non serve a nulla”, non ha nessun valore giuridico, vincolante per gli Stati. E’ vero che le Nazioni Unite non possono, per il loro stesso Statuto, imporre a nessun Paese membro di abolire la pena di morte, ma è anche innegabile il valore “morale” e di indirizzo politico del testo, che costituisce una linea-guida fondamentale per chi ancora pratica la pena di morte. Perché, per la prima volta, le Nazioni Unite hanno stabilito che la questione della pena capitale attiene alla sfera dei diritti della persona e non della giustizia interna, e che il suo superamento segna un importante progresso nel sistema dei diritti umani.
Tant’è che, da allora, gli effetti concreti della Risoluzione ONU si sono visti in numerosi Paesi, anche in quelli che fino a poco tempo fa apparivano del tutto inaccessibili e dove, invece, sono avvenuti molti fatti positivi nel senso dell’abolizione, come documenta anche questo nuovo Rapporto di Nessuno tocchi Caino.
Le abolizioni legali delle esecuzioni stabilite in questi anni negli Stati Uniti o la loro diminuzione di fatto come pare stia accadendo in Cina, la riduzione dei reati capitali approvata sempre in Cina e in Vietnam o le migliaia di commutazioni di sentenze di morte decise in Pakistan, in Kenia, in Etiopia e, addirittura, in Birmania, non sono dati irrilevanti, se non altro in termini di vite umane risparmiate. In molti di questi Paesi, questi fatti forse non preludono all’abolizione immediata della pena di morte né a cambiamenti radicali in senso democratico, ma sono fatti comunque significativi che vanno chiaramente nella direzione indicata dalle Nazioni Unite.
Come pure è significativo il fatto che le abolizioni della pena di morte degli ultimi anni siano avvenute in Africa e, in particolare, in Paesi come Ruanda e in Burundi, simbolo di un continente che nella storia recente del mondo è stato il più travagliato da tragedie immani: genocidi, mutilazioni e stupri di massa, esecuzioni sommarie e deportazioni… Eppure, di fronte a massacri di così vaste proporzioni, la legittima istanza delle vittime di vedere puniti gli autori di gravi crimini non è sfociata nella furia di esecuzioni capitali. Al contrario, si è accettata la via maestra della giustizia indicata dalla comunità internazionale con la istituzione – avvenuta anche in questo caso su impulso del Partito Radicale con la sua Associazione Non c’è Pace senza Giustizia – di tribunali ad hoc o a giurisdizione universale che escludono il ricorso alla pena di morte. Questi tribunali, davanti ai quali i responsabili debbano prima o poi rispondere, sono il primo e più efficace deterrente contro il verificarsi di atti che offendono l’umanità e, fatto forse ancora più importante, contro il permanere di regimi illiberali.
Il mandato di arresto spiccato nel 2009 dalla Corte Penale Internazionale dell’Aja contro il presidente sudanese Omar Al Bashir per i massacri nel Darfur, è stato il preludio in chiave giudiziaria di quello che a livello politico e sociale sarebbe da lì a poco accaduto in molti Paesi arabi e non solo: la fine del mito della invincibilità di dittatori al potere da decenni.
Fino a solo pochi mesi fa, sembrava impossibile una “caduta degli dei” così fragorosa. A gennaio, dopo 23 anni di governo dittatoriale, Ben Alì ha abbandonato la Tunisia. A febbraio, in Egitto, Hosni Mubarak è stato costretto a dimettersi e ora rischia anche quella pena di morte che lui stesso, nel corso di trent’anni di potere ininterrotto, aveva voluto estendere fino a 40 reati. Ali Abdallah Saleh in Yemen e di Bashar al-Assad in Siria resistono ancora, ma al prezzo di una guerra che hanno deciso di scatenare contro i loro stessi popoli. Muammar Gheddafi, fino a ieri accolto e omaggiato in Occidente come fosse davvero il Re dell’Africa, mentre scrivo, è ancora rintanato nel suo bunker dove però è stato raggiunto da un mandato di arresto per crimini contro l’umanità che gli ha spiccato il Procuratore della Corte Penale Internazionale Luis Moreno-Ocampo.
Staremo a vedere se il moto di liberazione da regimi ultradecennali che ha sconquassato il mondo arabo sfocerà ovunque in riforme vere in senso democratico e liberale. Intanto, registriamo con soddisfazione i molti fatti positivi che in quest’area preludono a una soluzione di continuità rispetto a sistemi e pratiche del passato.
In Marocco, dopo le grandi manifestazioni anti-establishment di febbraio, Re Mohammed ha deciso di trasformare in costituzionale una monarchia di diritto divino, con libertà per i partiti, con la separazione dell’esecutivo dal sistema giudiziario, con l’affermazione dei diritti delle donne e delle minoranze. Inoltre, nell’aprile scorso, il Re ha concesso la grazia a 92 prigionieri politici e commutato le condanne a morte di altri cinque prigionieri.
In Tunisia, il governo ad interim di unità nazionale ha annunciato la ratifica dei più importanti trattati internazionali, dallo Statuto di Roma sulla istituzione della Corte Penale Internazionale ai due protocolli addizionali al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, tra cui quello relativo all’abolizione della pena di morte.
In Giordania, la pena capitale non viene praticata dal 2006, il che fa pensare che la monarchia stia andando decisamente verso la sua abolizione. Anche in Libano regge la moratoria di fatto delle esecuzioni in atto dal 2004. Mentre Gibuti ha approvato di recente un emendamento che introduce l’abolizione della pena di morte nella Costituzione.
Il banco di prova forse decisivo di un vero cambio di regime nei Paesi arabi è costituito proprio dall’Egitto, il Paese che all’ONU è stato sempre in prima linea, insieme a Singapore, nel contrasto alla Risoluzione pro moratoria. La democrazia non può poggiare sull’impunità, ma neppure sulla vendetta e men che meno sull’omicidio di Stato. Se il governo egiziano ad interim saprà garantire ai massimi responsabili del vecchio regime, a partire da Mubarak, i diritti fondamentali della persona, ivi incluso un processo equo e trasparente che escluda la condanna a morte, ciò sarà la prova più evidente di una soluzione di continuità rispetto al passato.
Nel dicembre scorso, questi e altri Paesi del mondo arabo, tra cui Bahrein, Emirati Arabi, Mauritania e Oman che si sono astenuti, non si sono opposti alla nuova Risoluzione sulla moratoria approvata al Palazzo di Vetro. Mentre l’Algeria, non solo ha votato a favore, l’ha anche cosponsorizzata, in piena continuità con una moratoria legale delle esecuzioni che nel Paese dura dal 1993 e in coerenza con una politica di riconciliazione nazionale che il Presidente Abdelaziz Bouteflika ha voluto perseguire, nonostante sette anni di guerra civile, i circa 100.000 omicidi, le centinaia di persone scomparse e le evidenti difficoltà istituzionali.
La larghissima maggioranza con cui è stata approvata l’ultima Risoluzione ONU, è stata il frutto anche di questi cambiamenti nel mondo arabo e un’ulteriore conferma che il mondo intero sta andando decisamente verso il superamento del fasullo e arcaico sistema della pena di morte.
Per porre davvero fine all’aberrante e contraddittorio principio secondo cui la vita si debba difendere infliggendo la morte, occorre però che i Paesi che hanno sostenuto all’Onu la moratoria la facciano rispettare in concreto e in tutte le circostanze.
Intanto, una questione chiama direttamente in causa proprio l’Europa e la coerenza nel suo impegno internazionale contro la pena di morte. L’ha sollevata Nessuno tocchi Caino nel novembre scorso quando ha scoperto che proprio in Italia, Paese leader della campagna per la moratoria universale delle esecuzione capitali, era stata avviata la produzione di Pentothal da spedire poi negli Stati Uniti dove da mesi il boia era disoccupato proprio a causa della penuria di questo farmaco essenziale per l’iniezione letale. Dopo poco più di un mese di campagna di informazione e di iniziative parlamentari e legali, a gennaio, la casa farmaceutica Hospira ha deciso di rinunciare a produrre il Pentothal utilizzato per uccidere i condannati a morte americani. Ma ora la storia ricomincia con un altro farmaco, il Pentobarbital, con il quale molti Stati americani hanno rimpiazzato il Pentothal per mandare all’altro mondo i detenuti del braccio della morte. Il Pentobarbital è prodotto e venduto in America da una multinazionale danese, la Lundbeck. E’ un farmaco largamente diffuso e ancora necessario per la cura di gravi malattie e, quindi, non si può chiedere il suo bando. L’Europa, però, potrebbe fare adeguate pressioni sulla multinazionale danese perché la produzione e la vendita di Pentobarbital siano autorizzate esclusivamente per scopi medici, a tal fine prevedendo, quantomeno, che sulla etichetta del farmaco sia chiaramente indicato che il suo utilizzo è consentito solo in strutture ospedaliere e, inoltre, che nei contratti di compravendita sia chiaramente specificato che Lundbeck non consente la distribuzione del prodotto per la pratica dell’iniezione letale. Di certo, non sarebbe comprensibile che un’impresa che ha il suo quartier generale in un Paese membro dell’Unione, che ha abolito la pena di morte, collabori attivamente alla pratica delle esecuzioni negli Stati Uniti.
Anche su altri fronti non mi pare si stia manifestando, da parte dei governi che hanno promosso la Risoluzione pro moratoria, una seria volontà di compiere gli atti conseguenti.
Da questo Rapporto emerge che l’Iran, il Paese che negli ultimi anni ha sempre conquistato l’orribile podio olimpico dei primi paesi-boia del mondo, secondo solo alla Cina ma primo in assoluto se si considera il numero di abitanti, ha festeggiato l’inizio del nuovo anno con un’orgia di esecuzioni. In Corea del Nord le esecuzioni pubbliche sono triplicate rispetto agli anni precedenti. In Iraq non si sono mai fermate, nemmeno sotto il “democratico” governo di Nouri al-Maliki; anzi, avvengono con regolarità nello stesso complesso di Kadhimiya e sulla stessa forca dove una volta Saddam Hussein impiccava le sue vittime e dove ora gli uomini di al-Maliki, in una pedissequa imitazione di terrore saddamita, impiccano le loro.
In Cina come in Iran, in Corea del Nord come in Iraq, come al solito, sarà la “diplomazia parallela” Radicale a dover supplire alle mancanze dei poteri ufficiali del mondo cosiddetto libero, civile, abolizionista. Infatti, è stato Marco Pannella a dover fare, dopo l’annuncio della condanna a morte in Iraq, lo sciopero della fame e cinque giorni di sciopero della sete per ottenere una ‘Moratoria della pena di morte anche per Tareq Aziz’. Per rompere la tragica continuità con quanto era in voga ai tempi di Saddam, ma anche per salvare un altro testimone chiave per la ricostruzione della verità storica sulle responsabilità del regime e sugli accadimenti che hanno caratterizzato la storia irachena fino alla guerra. Guerra che – ormai è chiaro e da più parti documentato – è stata fatta improvvisamente scoppiare da Bush e Blair proprio per impedire che scoppiasse la pace e si realizzasse il nostro obiettivo di un “Iraq libero” attraverso l’esilio di Saddam e una amministrazione fiduciaria dell’Onu.
Ma non c’è solo la morte come pena ufficiale e “legale”, c’è anche la morte come conseguenza di una esecuzione della pena di fatto letale.
La catastrofica situazione del carcere di Mukobeko in Zambia, come mostra la terribile foto di copertina del Rapporto e come racconta Elisabetta Zamparutti nella sua Prefazione, è comune a molte prigioni del continente, nelle quali malaria, tubercolosi e Aids, che sono malattie endemiche in molti Paesi africani, diventano condanne inesorabili nelle condizioni igienico sanitarie, di promiscuità e di fatiscenza delle strutture penitenziarie.
Ma non è solo un problema “africano”, perché condizioni disastrose delle carceri connotano anche Paesi del mondo cosiddetto sviluppato e civile.
Nel maggio scorso, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha descritto la situazione nelle carceri della California come “al di sotto degli standard” considerati accettabili. A causa del sovraffollamento delle sue carceri dove 156.000 detenuti costituivano esattamente il doppio della capienza regolamentare, “per anni – hanno scritto i Giudici nella loro sentenza – l’assistenza medica e psichiatrica fornita dalle prigioni della California non ha corrisposto ai requisiti minimi costituzionali e non è riuscita a far fronte ai bisogni primari per la salute dei prigionieri.” “Sofferenze inutili e morti ben documentate ne sono state il risultato.” I giudici supremi americani hanno, quindi, stabilito che per rimediare alla violazione dei diritti costituzionali dei detenuti almeno 37.000 di loro dovevano essere sistemati in maniera più dignitosa oppure essere liberati.
La situazione in Italia è, se è possibile, peggiore. Ad oggi, nei penitenziari italiani ci sono ben 67.174 detenuti ma solo 45.551 posti letto. Lo chiamano “sovraffollamento”, ma il termine non rende minimamente l’idea della tragedia. I detenuti sono “ristretti” – è il caso di dire – in quattro, in sei, in dodici in spazi dove dovrebbero stare al massimo in due, in quattro, in sei. Passano anche ventitré ore al giorno in celle sporche e degradate, che diventano frigoriferi d’inverno e forni d’estate. Nella promiscuità più scriteriata, trovi uno accanto all’altro recidivi pluri-condannati e ladri di pollo in attesa di giudizio, colpevoli in via definitiva e innocenti fino a prova contraria, prossimi al fine pena o col “fine pena mai”. C’è chi è malato e non può essere curato, chi è straniero e non viene considerato, chi non ce la fa più e si toglie la vita. In queste condizioni, negli ultimi dieci anni, sono morti 1.800 detenuti, molti per cause “naturali” e ben 650 per suicidio, o presunto tale. A morire non sono solo detenuti, nello stesso periodo si sono tolti la vita anche 87 agenti di polizia penitenziaria. Non c’è nulla di naturale in queste morti, che sono la conseguenza ultima di una condizione strutturale di tortura della quale sono tutti vittime, non solo i detenuti ma anche quei semi-detenuti che sono gli “agenti di custodia”, i direttori e gli altri componenti la comunità penitenziaria.
Per questo e “perché l’Italia torni a poter essere in qualche misura considerata una democrazia”, Marco Pannella ha intrapreso una lunga azione nonviolenta e, mentre scrivo, è giunto al 63° giorno di sciopero della fame e al 4° anche della sete. Marco propone l’amnistia, quale misura sempre più necessaria e urgente per far fronte al sovraffollamento nelle carceri, ma anche al “sovraffollamento” nei tribunali penali e civili che sono soffocati da undici milioni di processi pendenti e, per questo, non riescono più ad amministrare giustizia. Coi suoi tempi biblici, la giustizia italiana ha già prodotto in dieci anni due milioni di reati prescritti e continua a produrre, come una catena di montaggio impazzita, sempre meno sentenze e, al ritmo di quasi duecentomila all’anno, sempre più prescrizioni dei reati.
In questa situazione, l’amnistia non sarebbe un atto di clemenza ma un atto di buon governo, l’unico adeguato a tentare di ripristinare nella amministrazione giudiziaria e nella sua appendice carceraria un minimo di legalità o, quantomeno, di decenza… se è vero che, come diceva Voltaire, “il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri”.