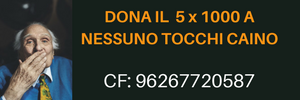28 Giugno 2019 :
CASO MARCELLO VIOLA c. ITALIA (No 2)1
(Ricorso no 77633/16)
SENTENZA
STRASBURGO
13 giugno 2019
Questa sentenza diventerà definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire delle modifiche di forma
1 La traduzione in lingua italiana di questa sentenza, dall’originale in lingua francese, è stata effettuata dall’Avvocata Antonella Mascia con la supervisione del prof. Davide Galliani.
Nel caso Marcello Viola v. Italia n. 2,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:
Linos-Alexandre Sicilianos, Presidente,
Ksenija Turković, Guido Raimondi, Krzysztof Wojtyczek, Armen Harutyunyan, Pauliine Koskelo, Gilberto Felici, Giudici,
e da Renata Degener, Vice-Cancelliere di Sezione.
Dopo aver deliberato in Camera di consiglio il 30 aprile 2019, Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data.
PROCEDURA
All’origine del caso vi è un ricorso (n. 77633/17) proposto contro la Repubblica italiana da un cittadino di questo Stato, il Signor Marcello Viola (“il ricorrente”), il quale, il 12 dicembre 2016, ha adito la Corte, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
Il ricorrente è stato rappresentato dall’avvocata A. Mascia del foro di Verona, e dagli avvocati B. Randazzo e V. Onida del foro di Milano. Il Governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dalla sua ex agente E. Spatafora e dalla sua coagente M. Aversano.
Il ricorrente lamenta di essere sottoposto a una pena detentiva a vita incomprimibile, che qualifica come inumana e degradante.
Il 30 maggio 2017, le allegazioni riguardanti gli articoli 3 e 8 della Convenzione sono state comunicate al Governo e il ricorso è stato dichiarato inammissibile quanto al resto, conformemente all’articolo 54 § 3 del Regolamento della Corte.
Sono state ricevute delle osservazioni dal Centro di documentazione “L’altro diritto onlus” dell’Università degli Studi di Firenze, dalla Rete europea di ricerca e d’azione in contenzioso penitenziario e da accademici ed esperti coordinati dall’Università degli Studi di Milano, autorizzati dal Presidente a intervenire nella procedura scritta in qualità di terzi intervenienti (articolo 36 § 2 della Convenzione e articolo 44 § 3 a) del Regolamento della Corte).
IN FATTO
LE CIRCOSTANZE DEL CASO
Il ricorrente è nato nel 1959 e si trova attualmente detenuto presso la Casa di reclusione di Sulmona.
Egli fu coinvolto negli avvenimenti che videro opporsi la cosca Radicena e la cosca Iatrinoli, a partire da metà degli anni 80 fino a ottobre 1996 (periodo definito come la “seconda faida di Taurianova”).
I procedimenti penali promossi nei confronti del ricorrente
Il primo processo promosso, tra gli altri, contro il ricorrente, il c.d. “processo Marcello Viola + 24” (n. 144/92), ricomprendeva fatti intervenuti tra gennaio 1990 e marzo 1992. Il procedimento permise, in particolare, di identificare i responsabili di quattro omicidi avvenuti il 3 maggio 1991 (“il venerdì nero”) e di scoprire le ramificazioni delle due cosce, in lotta per conquistare il controllo della città di Taurianova e dei territori limitrofi.
Il 16 ottobre 1995, la Corte di Assise di Palmi condannò il ricorrente a una pena di quindici anni di reclusione per associazione di stampo mafioso, ritenendo come circostanza aggravante il fatto che l’interessato fosse il promotore delle attività criminali della cosca. Per quanto riguardava la natura del vincolo associativo, la Corte di Assise evidenziò diversi elementi, ossia “la solidità del legame tra i membri, la gerarchia interna, la distinzione dei ruoli e dei compiti tra gli aderenti, il controllo del territorio, il disegno criminoso indeterminato, la prassi intimidatoria e, secondo un approccio più evoluto, non solo la vessazione parassitaria perpetrata nei confronti delle imprese, ma anche la partecipazione diretta all’economia del territorio, mediante il controllo effettivo delle attività economiche legali”.
Con sentenza n. 3 del 10 febbraio 1999 (depositata il 29 marzo 1999), la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria confermò la condanna del ricorrente, riducendo la pena a dodici anni di reclusione. Il ricorrente non ricorse in cassazione.
Il secondo processo promosso, tra gli altri, nei confronti del ricorrente, il c.d. “processo Taurus” (nn. 1/97 – 12/97 – 18/97), aveva ad oggetto altri fatti relativi alle attività criminali condotte a Taurianova dalle due cosche. Il 22 settembre 1999, la Corte di Assise di Palmi, con sentenza
n. 10/99, condannò il ricorrente all’ergastolo. La decisione fu confermata dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria il 5 marzo 2002. In particolare, il ricorrente fu riconosciuto colpevole del delitto di associazione di stampo mafioso ai sensi dell’articolo 416 bis del codice penale (CP), oltre che di altri delitti (omicidio, sequestro che aveva provocato la morte della vittima e detenzione illegale d’armi da fuoco), aggravati dalle circostanze
c.d. “di tipo mafioso”, previste dall’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 13 maggio 1991, convertito in legge il 12 luglio 1991 (legge di conversione
n. 203/1991). Nei confronti del ricorrente fu, inoltre, riconosciuta la circostanza aggravante dell’assunzione del ruolo di capo dell’organizzazione criminale e di promotore delle sue attività.
Ritenendo il reato continuato, la Corte di Assise di Appello condannò il ricorrente all’ergastolo con isolamento diurno di due anni.
Il ricorrente propose ricorso in cassazione, che fu rigettato il 26 febbraio 2004.
A seguito di una domanda volta alla rideterminazione della pena complessiva, basata sulla continuazione tra i fatti riguardanti il “processo Marcello Viola + 24” (sentenza del 10 febbraio 1999) e quelli riguardanti il “processo Taurus” (sentenza del 5 marzo 2002), il 12 dicembre 2008 la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria constatò l’unicità del disegno criminoso e riconobbe la continuazione dei fatti oggetto dei due processi. La pena complessiva fu quindi ricalcolata e rideterminata nella reclusione a vita con isolamento diurno per due anni e due mesi.
B. La detenzione del ricorrente
Tra giugno 2000 e marzo 2006, il ricorrente fu sottoposto al regime detentivo speciale previsto dall’articolo 41 bis, secondo comma, della legge
n. 354 del 26 luglio 1975 (“articolo 41 bis”), una disposizione che permette all’amministrazione penitenziaria di sospendere, totalmente o parzialmente, il regime detentivo ordinario, in caso di gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.
In particolare, nel corso di questo periodo, il Ministro della Giustizia, il 14 dicembre 2005, dispose con decreto, nei confronti del ricorrente, la proroga del regime del “41 bis”, per una durata di un anno. L’interessato impugnò il decreto dinanzi al Tribunale di Sorveglianza (“il TdS”) dell’Aquila, lamentando un difetto di motivazione del provvedimento, a suo avviso fondato su elementi non rispondenti alla reale situazione dell’epoca, adducendo invece una rottura dei legami con l’organizzazione mafiosa.
Con ordinanza del 14 marzo 2016, il TdS accolse la doglianza del ricorrente e pose termine al regime speciale di detenzione impostogli. Il TdS sottolineò che il regime del “41 bis” non obbligava il detenuto a provare la rottura dei legami con l’associazione mafiosa, rimanendo la prova a carico dell’amministrazione. Secondo il TdS, incombeva a quest’ultima fornire una motivazione basata su elementi fattuali precisi, concreti ed attuali, che indicassero il mantenimento dei contatti del detenuto con l’organizzazione mafiosa.
Il TdS ritenne inoltre che, nel caso di specie, le autorità si erano limitate a indicare che l’organizzazione criminale di appartenenza era ancora attiva e che il ricorrente non aveva dimostrato nessun segno di cambiamento, né aveva dato prova di voler collaborare con la giustizia. Il TdS rilevò che le autorità non avevano fornito elementi specifici che permettessero di stabilire la capacità dell’interessato di mantenere il contatto con l’organizzazione in questione e che, nel decreto, i risultati positivi del percorso rieducativo seguito non erano stati sufficientemente tenuti in considerazione.
Il ricorrente, in seguito, richiese, per due volte, che gli fosse concesso un permesso premio, beneficio riconosciuto ai detenuti in presenza di determinate condizioni (si veda, qui sotto, il paragrafo 34).
La prima richiesta fu respinta dal magistrato di sorveglianza dell’Aquila, il 13 luglio 2011. Nella motivazione, il giudice rimarcò che il benefico del permesso premio era da escludersi, per le persone condannate all’ergastolo per uno dei delitti previsti dall’articolo 4 bis (“articolo 4 bis”) della legge n. 354 del 26 luglio 1975, in caso di mancata “collaborazione con la giustizia”, prevista dall’articolo 58 ter della medesima legge (qui, di seguito, “la legge sull’ordinamento penitenziario”).
Il ricorrente ricorse al TdS dell’Aquila, basandosi sui risultati ritenuti positivi del percorso rieducativo e sulla rottura dei legami con l’ambiente mafioso. Chiese altresì di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva che il permesso premio potesse essere concesso ai condannati all’ergastolo che non avevano collaborato con la giustizia o la cui situazione non rientrava nei casi di collaborazione “impossibile” o “inesigibile”, i quali, non di meno, avevano seguito un percorso rieducativo positivo, proclamavano la loro innocenza e per i quali erano stati acquisiti elementi che permettevano sicuramente di escludere ogni legame con l’organizzazione criminale.
Con ordinanza n. 22/12 del 29 novembre 2011 (depositata il 9 gennaio 2012), il TdS respinse la domanda di permesso premio, in quanto mancava la condizione della “collaborazione con la giustizia”.
Il TdS, prima di pronunciarsi nel merito sulla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, ritenne di dover determinare se sussistevano le altre condizioni che potessero permettere la concessione del permesso. In particolare, il TdS indirizzò la sua valutazione sull’esistenza di elementi positivi che permettessero di escludere l’attualità del legame con l’organizzazione criminale.
Preliminarmente, il TdS precisò che l’ordinanza del 14 marzo 2006 (paragrafo 16, qui sopra), con la quale si era posto fine al regime del “41 bis”, non aveva alcuna conseguenza giuridica sul procedimento in corso, in quanto la valutazione del giudice verteva su due situazioni diverse. In effetti, secondo il TdS, l’ordinanza del 2006 doveva determinare se il ricorrente avesse la capacità di mantenere o meno, dal carcere, dei contatti con l’organizzazione mafiosa, mentre, nel procedimento in corso, si doveva verificare l’esistenza di elementi suscettibili di provare con certezza che il ricorrente non avesse più legami con l’organizzazione criminale.
Nel caso di specie, il TdS ritenne che non si fosse raggiunta la prova positiva della rottura di questi legami. Rilevò, al contrario, che la cosca era ancora attiva nel territorio di Taurianova, che il ricorrente era il capo riconosciuto di un’organizzazione criminale e che l’osservazione quotidiana dell’interessato non aveva fatto emergere che questi avesse compiuto una
valutazione critica del suo passato criminale. Conseguentemente, senza esaminare nel merito la questione di costituzionalità proposta dal ricorrente, la domanda fu respinta. L’ordinanza del TdS fu confermata dalla Corte di Cassazione, il 7 novembre 2012 (sentenza n. 3107/12).
La seconda domanda di permesso premio fu respinta dal magistrato di sorveglianza dell’Aquila il 4 giugno 2015 e poi dal TdS della stessa città il 13 ottobre 2015, a causa della mancata collaborazione con le autorità.
Nel frattempo, nel marzo 2015, il ricorrente aveva presentato al TdS dell’Aquila una domanda di liberazione condizionale, ai sensi dell’articolo 176 del CP. Si riferì ai risultati positivi riscontrati durante la detenzione, così come riportati nelle relazioni di servizio del 1 marzo 2011, 20 agosto 2014 e 27 gennaio 2015, nonché all’assenza di legami con la criminalità organizzata e anche all’impossibilità di poter beneficiare della riduzione di pena, ottenuta grazie alla liberazione anticipata (secondo il ricorrente, oltre 1.600 giorni, accumulati alla data di presentazione della domanda). Sostenne, inoltre, che, a causa della circostanza aggravante relativa al ruolo di capo dell’organizzazione criminale, riconosciuta nelle sentenze di condanna, la sua collaborazione con la giustizia non poteva aspirare ad essere qualificata “impossibile” o “inesigibile”, ai sensi dell’articolo 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario. Infine, chiese al TdS di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, in relazione all’articolo 27, terzo comma, della Costituzione e all’articolo 117, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 3 della Convenzione.
Con ordinanza del 26 maggio 2015, il TdS non accordò la liberazione condizionale al ricorrente, rilevando che era stato condannato per associazione mafiosa e per altri delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso o al fine di agevolare l’attività dell’associazione (articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 13 maggio 1991, convertito nella legge n. 203 del
12 luglio 1991). Secondo il Tribunale, dato che i delitti erano previsti dall’articolo 4 bis, il ricorrente non poteva essere ammesso alla liberazione condizionale in assenza di collaborazione con l’autorità giudiziaria, collaborazione che nel caso di specie non appariva né “impossibile” né “inesigibile”, ai sensi del comma 1 bis dell’articolo in questione.
In riferimento alla questione di costituzionalità proposta dal ricorrente, il TdS sostenne che la disposizione contestata era compatibile con i principi derivanti dall’articolo 27 comma terzo della Costituzione. Dopo aver ricordato la giurisprudenza costituzionale e la posizione della Corte nella sentenza Vinter e altri v. Regno Unito [GC], nn. 66069/09 e 2 altri, CEDU 2013 (estratti), il Tribunale rilevò che, ai condannati all’ergastolo per uno dei delitti previsti dall’articolo 4 bis, la legislazione offriva una concreta possibilità di liberazione, dal momento in cui l’esecuzione della pena aveva raggiunto il suo scopo e quindi il condannato poteva reinserirsi nella società. Secondo il TdS, questa possibilità era subordinata al verificarsi della condizione della rottura definitiva del legame
tra il condannato e l’ambiente mafioso, che doveva esprimersi, in pratica, con una utile collaborazione con la giustizia.
Contro tale decisione, il ricorrente propose ricorso in Cassazione, in particolare chiedendo di sollevare la questione di costituzionalità in riferimento alla disposizione, la quale prevedeva un automatismo legislativo che impediva di accordare la liberazione condizionale ai detenuti “non collaboranti”.
28 Con sentenza n. 1153/16 del 22 marzo 2016 (depositata il 1° luglio 2016), la Corte di Cassazione rigettò il ricorso del ricorrente. Per quanto riguarda la questione di costituzionalità, richiamò la giurisprudenza della Corte costituzionale e, in particolare, la sentenza n. 135/2003, secondo la quale il fatto di subordinare la concessione della liberazione condizionale alla collaborazione con la giustizia non contrastava con la funzione rieducativa della pena. Secondo la Corte costituzionale, la scelta di collaborare con la giustizia era infatti lasciata alla libera valutazione del condannato, senza che vi fosse alcuna forma di costrizione.
Riguardo all’innocenza lamentata dal ricorrente, la Suprema Corte fece riferimento ad un’altra sentenza della Corte costituzionale (n. 306/1993), con la quale quest’ultima aveva sostenuto che il regime dell’articolo 4 bis non pregiudicava il condannato che protestava la sua innocenza, in quanto siffatta evenienza rivestiva significato giuridico unicamente all’interno della procedura di revisione della sentenza di condanna. Infine, la Corte di Cassazione sottolineò il carattere assoluto della presunzione di pericolosità sociale, in caso di mancanza della collaborazione con la giustizia. Secondo la Suprema Corte, il legislatore era libero di fissare le condizioni per la liberazione delle persone condannate per delitti particolarmente gravi, come quelli collegati al fenomeno mafioso. La Suprema Corte precisò che, nel caso di pena all’ergastolo entro il regime di cui all’art. 4 bis, il condannato presentava una maggiore pericolosità valutata rispetto al delitto commesso, non già per la sua personalità. E aggiunse che il legislatore chiedeva, in modo legittimo, la prova positiva della rottura definitiva del legame dell’individuo con il gruppo mafioso di provenienza.
IL DIRITTO E LE PRASSI INTERNE RILEVANTI
Il diritto positivo
1. La Costituzione
29. L’articolo 27, comma 3, della Costituzione italiana dispone che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che devono tendere alla rieducazione del condannato.
2. Il codice penale
30. Gli articoli del CP rilevanti nel caso di specie sono così formulati:
Articolo 22 – ergastolo
“La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli istituti a ciò destinati (…)
Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto”.
Articolo 176 – Liberazione condizionale
“Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni
(...)
Il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.
La concessione della liberazione condizionale è subordinata all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle”.
Articolo 416 bis – Associazioni di tipo mafioso
“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà’ che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (…)”.
3. La legge sull’ordinamento penitenziario
La legge n. 354 del 26 luglio 1975, cd. “legge sull’ordinamento penitenziario”, disciplina il trattamento dei detenuti in ambito penitenziario e l’esecuzione delle misure privative della libertà. Al primo comma del suo articolo 1, dispone che il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.
Il regime dell’ergastolo ostativo è il risultato della riforma legislativa introdotta dalla legge n. 356 del 7 agosto 1992 (legge di conversione del decreto-legge n. 306 dell’8 giugno 1992). Si fonda sulla lettura combinata dell’articolo 22 del CP e degli articoli 4 bis e 58 ter della legge sull’ordinamento penitenziario. Secondo queste disposizioni, l’assenza di “collaborazione con la giustizia” impedisce la concessione della liberazione condizionale e degli altri benefici previsti dall’ordinamento penitenziario.
L’articolo 4 bis riguarda, più in particolare, il divieto di accesso ai benefici penitenziari e la verifica della pericolosità sociale per una determinata categoria di detenuti. Nelle sue parti rilevanti per il caso di specie, l’articolo è così formulato:
“1. L’assegnazione al lavoro all’esterno [articolo 21], i permessi premio [articolo 30 ter] e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI [del titolo I], esclusa la liberazione anticipata [articolo 54], possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, (…)
1 bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62, numero 6) (…), dall’articolo 114 ovvero dall’articolo 116, secondo comma, del codice penale.
(...)”.
L’articolo 58 ter della legge, che disciplina la “collaborazione con la giustizia”, è così formulato:
“1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell’art. 21, del comma 4 dell’art. 30-ter e del comma 2 dell’art. 50, [della legge n. 354/1975] concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’art. 4-bis, non si applicano a coloro che,
anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati.
2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione”.
L’articolo 21 e l’articolo 30 ter della stessa legge riguardano, rispettivamente, il lavoro all’esterno e i permessi premio. In particolare, l’articolo 30 ter prevede la possibilità di concedere al detenuto un permesso premio, che non superi i quindici giorni, qualora questi abbia dato prova di una condotta regolare e non costituisca pericolo per la società. A seconda della gravità del reato, il detenuto deve aver scontato un determinato periodo di detenzione, prima di poter usufruire del beneficio. L’assenza di pericolosità sociale è valutata dal giudice di sorveglianza, che deve consultare le autorità penitenziarie.
Il capitolo VI del titolo I della legge elenca tutte le misure alternative alla detenzione e, in particolare, l’affidamento in prova ai servizi sociali, la detenzione domiciliare, la semilibertà e la liberazione anticipata. In specie, l’articolo 54 prevede la possibilità di una “liberazione anticipata” che permette al detenuto, il quale abbia dimostrato di aver preso parte al progetto di rieducazione, di beneficiare di una riduzione di pena di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.
Per quanto riguarda la liberazione condizionale, l’articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 152 del 13 maggio 1991 (modificato dalla legge di conversione n. 203 del 12 luglio 1991) dispone che “i condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis della legge [sull’ordinamento penitenziario] possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti [dalla stessa legge] per la concessione dei benefici ivi indicati”.
La giurisprudenza costituzionale
La sentenza n. 12 del 4 febbraio 1966 della Corte Costituzionale offre un’interpretazione dell’articolo 27 comma 3 della Costituzione che mette in risalto l’equilibrio tra le differenti funzioni assegnate alla pena. Nei passaggi rilevanti per il caso di specie, questa sentenza sostiene testualmente:
“la norma non si limita a dichiarare puramente e semplicemente che “le pene devono tendere alla rieducazione del condannato”, ma dispone invece
che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”: un contesto, dunque, chiaramente unitario, non dissociabile, come si vorrebbe, in una prima e in una seconda parte separate e distinte tra loro, né, tanto meno, riducibile a una di esse soltanto. Oltre tutto, le due proposizioni sono congiunte non soltanto per la loro formulazione letterale, ma anche perché logicamente in funzione l’una dell’altra. Da un lato infatti un trattamento penale ispirato a criteri di umanità è necessario presupposto per un’azione rieducativa del condannato; dall’altro è appunto in un’azione rieducativa che deve risolversi un trattamento umano e civile (…).
Ricostituita la norma nella sua integrità, ne riemerge il suo vero significato. La rieducazione del condannato, pur nella importanza che assume in virtù del precetto costituzionale, rimane sempre inserita nel trattamento penale vero e proprio. È soltanto a questo, infatti, che il legislatore poteva logicamente riferirsi (…). Alla pena dunque, con tale proposizione, il legislatore ha inteso soltanto segnare dei limiti, mirando essenzialmente ad impedire che l’afflittività superi il punto oltre il quale si pone in contrasto col senso di umanità.
Rimane in tal modo stabilita anche la vera portata del principio rieducativo, il quale, dovendo agire in concorso delle altre funzioni della pena, non può essere inteso in senso esclusivo ed assoluto. Rieducazione del condannato, dunque, ma nell’ambito della pena (…).
Del resto la portata e i limiti della funzione rieducativa voluta dalla Costituzione appaiono manifesti nei termini stessi del precetto. Il quale stabilisce che le pene "devono tendere" alla rieducazione del condannato: espressione che, nel suo significato letterale e logico, sta ad indicare unicamente l’obbligo per il legislatore di tenere costantemente di mira, nel sistema penale, la finalità rieducativa e di disporre tutti i mezzi idonei a realizzarla (…).
In conclusione, con la invocata norma della Costituzione si volle che il principio della rieducazione del condannato, per il suo alto significato sociale e morale, fosse elevato al rango di precetto costituzionale, ma senza con ciò negare la esistenza e la legittimità della pena là dove essa non contenga, o contenga minimamente, le condizioni idonee a realizzare tale finalità. E ciò, evidentemente, in considerazione delle altre funzioni della pena che (…) sono essenziali alla tutela dei cittadini e dell’ordine giuridico contro la delinquenza, e da cui dipende la esistenza stessa della vita sociale”.
Dalla sentenza n. 313 del 4 luglio 1990, la Corte Costituzionale si è orientata, nella sua giurisprudenza, verso l’attribuzione di un ruolo più centrale alla funzione di risocializzazione della pena. Ha affermato che questa funzione deve accompagnare la pena a partire dalla sua creazione normativa fino alla sua estinzione. Peraltro, si tratta di una funzione che
deve orientare l’azione del legislatore, del giudice del merito, del giudice della fase esecutiva e delle autorità penitenziarie (si vedano anche le sentenze nn. 343/1993, 422/1993, 283/1994, 341/1994, 85/1997, 345/2002, 257/2006, 322/2007, 129/2008 e 183/2011).
Per quanto riguarda la legittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, la Corte costituzionale se ne è occupata, specificamente, nella sentenza n. 306 dell’11 giugno 1993. Ha messo in rilievo le scelte di politica criminale del legislatore, osservando come quest’ultimo, subordinando l’accesso alla liberazione condizionale e ad ogni altro beneficio alla collaborazione del detenuto, ha voluto privilegiare esplicitamente la prevenzione generale e la protezione della collettività, mediante il requisito della collaborazione dei membri delle associazioni mafiose, cosa che, nel contesto della lotta contro il crimine organizzato, rappresenta uno strumento capitale per le attività delle autorità inquirenti.
La Corte costituzionale ha ugualmente affermato che, se la collaborazione con la giustizia costituisce una presunzione della “dissociazione” della persona dall’ambiente mafioso e un indice in favore di un positivo sviluppo del percorso di reinserimento, non è vero il contrario, vale a dire che l’assenza della collaborazione non permette di affermare che si tratta di un indice univoco di mantenimento dei legami con l’organizzazione criminale. Ha anche riconosciuto che la scelta di collaborare può essere il frutto di una valutazione interessata, posta in essere allo scopo di beneficiare dei vantaggi che la legge prevede, senza essere il segno di un’avvenuta risocializzazione.
Tuttavia, per il giudice delle leggi, in assenza di una gerarchia fissa tra le finalità attribuite dalla Costituzione alla pena, il regime in vigore, pur generando una significativa compressione della finalità rieducativa, non l’ha ristretta in modo irragionevole e sproporzionato, dato che ha lasciato aperto l’accesso al percorso di risocializzazione.
Nella sentenza n. 273 del 5 luglio 2001, la Corte costituzionale si è nuovamente pronunciata sulla costituzionalità dell’articolo 4 bis. Ricordando i lavori preparatori della legge di conversione del decreto-legge
n. 306/1992, secondo i quali solamente attraverso la collaborazione con la giustizia il condannato può dimostrare, per facta concludentia, di aver rotto i legami con l’organizzazione criminale, ha ritenuto che tale scelta da parte del legislatore fosse compatibile con la funzione rieducativa della pena, dato che si trattava di una espressione, priva di ambiguità, della volontà del condannato di fare ammenda rispetto al suo passato criminale.
Peraltro, la Corte costituzionale ha considerato l’atteggiamento del condannato che non collabora con le autorità come una “presunzione legislativa” della persistenza del legame criminale e dell’assenza di cambiamento.
Due anni dopo, con la sentenza n. 135 del 24 aprile 2003, la Corte costituzionale ha confermato che il divieto nascente dall’articolo 4 bis non
ha il carattere di un automatismo legislativo. Ha considerato che la legge non prevede divieti assoluti, altro non fa che subordinare l’accesso alla liberazione condizionale alla “collaborazione con la giustizia”, che esprime un atto volontario e libero del detenuto. Secondo la Corte costituzionale, la disposizione in questione non vieta in modo assoluto e definitivo l’accesso alla liberazione condizionale e non è dunque in contraddizione con il principio della rieducazione, enunciato all’articolo 27 comma 3 della Costituzione. Peraltro, l’assenza di collaborazione è vista dal legislatore come una presunzione legale del fallimento del percorso di reinserimento del condannato.
Per quanto riguarda le “presunzioni legislative assolute”, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona (sentenze nn. 41/1999, 139/2010 e 265/2010), la Corte costituzionale le ritiene contrarie al principio di uguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali o se non rispondono ai dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula “id quod plerumque accidit” (sentenza n. 57 del 29 marzo 2013). Più specificamente, riguardo ai benefici penitenziari, la Corte costituzionale ha affermato la necessità di attribuire al giudice il potere di valutare gli elementi del caso concreto, in modo che la concessione di un determinato beneficio sia collegato ad una prognosi ragionevole quanto alla sua idoneità a fare proseguire il detenuto nel suo percorso di reinserimento (sentenze nn. 436/1999, 255/2006 e 189/2010).
Recentemente, nella sentenza n. 149 dell’11 luglio 2018 (si vedano anche le sentenze n. 239 del 22 ottobre 2014 e n. 76 del 12 aprile 2017), la Corte costituzionale ha preso posizione sulla costituzionalità dell’articolo 58 quater della legge sull’ordinamento penitenziario. Questa norma, dichiarata incostituzionale, prevedeva che, i condannati all’ergastolo per il delitto di sequestro di persona, che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non potessero essere ammessi ad alcun beneficio, se non avessero effettivamente espiato almeno ventisei anni di reclusione.
In questa sentenza, la Corte costituzionale ha evidenziato che siffatta soglia temporale era in contrasto con i principi della progressione trattamentale e della flessibilità della pena, a fondamento del graduale processo di reinserimento del condannato. Inoltre, ha osservato che questa soglia rendeva del tutto inutili gli effetti della “liberazione anticipata” (riduzione di pena di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata) e questo aveva un impatto negativo sulla motivazione del detenuto a portare a termine il suo percorso rieducativo. Infine, ricordando la sua giurisprudenza precedente (sentenze nn. 313/1990, 68/1995, 257/2006 e 78/2007), ha criticato l’automatismo dell’applicazione della soglia di ventisei anni a tutti i detenuti. Ha rilevato che questo automatismo aveva per effetto quello di impedire alla magistratura di sorveglianza di procedere a una qualsiasi valutazione dei risultati ottenuti dal detenuto nel corso del suo percorso intra-muros, privilegiando l’aspetto retributivo della pena, a
detrimento della sua finalità di risocializzazione. La Corte costituzionale ha considerato che “previsioni che precludano in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso, l’accesso ai benefici penitenziari a particolari categorie di condannati – i quali pure abbiano partecipato in modo significativo al percorso di rieducazione e rispetto ai quali non sussistano gli indici di perdurante pericolosità sociale individuati dallo stesso legislatore all’articolo 4 bis – in ragione soltanto della particolare gravità del reato commesso, ovvero dell’esigenza di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati”, erano contrari ai principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena (si veda anche la sentenza n. 239 del 29 ottobre 2014).
Sul potere di grazia del Presidente della Repubblica italiana, previsto dall’articolo 87 comma 11 della Costituzione, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 200 del 18 maggio 2006, ha identificato la natura dell’atto della grazia presidenziale e l’estensione del potere del Capo dello Stato in materia. Ha ritenuto che il potere di clemenza presidenziale risponde a finalità eminentemente umanitarie e serve a temperare la rigidità della legge penale. In particolare, la Corte costituzionale ha sostenuto che, dopo la legge n. 663 del 10 ottobre 1986, la grazia presidenziale è “destinata a soddisfare unicamente straordinarie esigenze di natura umanitaria”, assumendo la “funzione di mitigare o elidere il trattamento sanzionatorio”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione
Nella sentenza n. 45978 del 26 novembre 2012, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un’ordinanza di un TdS che aveva respinto la richiesta di un permesso premio per mancanza di “collaborazione con la giustizia”. Ha ritenuto che, a parte le ipotesi della collaborazione “impossibile” o “inesigibile”, la legge permetteva al giudice di esercitare una valutazione individuale e personalizzata del comportamento del detenuto, e ciò pertanto escludeva l’esistenza di rigidi automatismi (si vedano anche le sentenze nn. 18206 del 30 aprile 2014, 34119 del 14 aprile 2016 e 9276 del 7 novembre 2017).
Nella sentenza n. 47044 del 24 ottobre 2017, la Suprema Corte ha ricordato la sua interpretazione delle nozioni di collaborazione “impossibile” e “inesigibile” (si vedano anche le sentenze della Corte costituzionale nn. 357/1994 e 68/1995): la collaborazione “impossibile” corrisponde alla situazione dove i fatti e le responsabilità dei quali il condannato potrebbe avere conoscenza sono stati già rilevati o chiariti; la collaborazione “inesigibile” rinvia all’ipotesi in cui il condannato, per il suo ruolo marginale all’interno dell’organizzazione criminale, non è in grado di conoscere fatti e responsabilità riguardanti il livello superiore dell’organizzazione (si vedano, tra molte altre, le sentenze nn. 3034 del 18 maggio 1985 e 29217 del 6 giugno 2013).
Nella sentenza n. 46103 del 7 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha rilevato che “in tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo”. Ha aggiunto che la detenzione non fa “cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo” nell’organizzazione, una volta che il soggetto è uscito dal carcere. Per quanto riguarda l’analisi delle caratteristiche del delitto di associazione mafiosa, in particolare gli elementi strutturali e il bene giuridico protetto, la Corte di Cassazione ha ricordato che si tratta di un reato permanente, che presuppone l’esistenza di un vasto programma criminale, proiettato verso il futuro e senza alcun limite temporale. Inoltre, il reato di associazione mafiosa si distingue dall’ipotesi di partecipazione di più individui alla commissione di un reato continuato. Riguardo al bene giuridico protetto, la Suprema Corte ha affermato che esso consiste nella necessità di tutelare l’ordine pubblico da una situazione di pericolo potenziale, che insorge per il solo fatto del pactum sceleris e dalla volontà degli associati di commettere delle attività delittuose. Da tali premesse, la Corte di Cassazione ha concluso che la “esistenza” del delitto previsto dall’articolo 416 bis è compatibile con l’inattività dell’associato o lo stato silente dell’associazione; sicché il rapporto associativo cessa solamente nel caso di una oggettiva rottura dell’accordo associativo o soggettivamente nei casi di morte, di rottura dei singoli rapporti individuali o con l’esclusione da parte degli altri associati.
Recentemente, con ordinanza n. 4474 del 20 dicembre 2018, la Corte di Cassazione ha sollevato dinanzi alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale, riguardante il contrasto tra l’articolo 4 bis e la funzione di risocializzazione della pena. In particolare, ha affermato quanto segue:
“In questo contesto si inserisce problematicamente l’art. 4 bis, comma 1, Ord. Pen. che, in relazione alla concessione del permesso premio, ne preclude l’accesso, in senso assoluto, a tutte le persone condannate per delitti ostativi che non hanno fornito una collaborazione con la giustizia rilevante ai sensi dell’art. 58 ter Ord. Pen.”
(...)
Del resto, tali obiettivi di risocializzazione, che non consentono l’applicazione di presunzioni assolute in materia di benefici penitenziari, erano ulteriormente corroborati dalla giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza della Grande Camera Vinter e altri v. Regno Unito [GC], nn. 66069/09 e 2 altri, CEDU 2013 (estratti) (…).
Tuttavia, che la cessazione dei legami consortili di un detenuto con il gruppo criminale di riferimento possa essere dimostrata, durante la fase di esecuzione della pena, solo attraverso le condotte collaborative di cui all’art.
58 ter Ord. Pen. è affermazione che non può assumere valore incontrovertibile e assurgere a canone valutabile in termini di presunzione assoluta, a prescindere dalle emergenze concrete.
(...)
le considerazioni esposte impongono di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, 354, nella parte in cui esclude che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis cod. pen. Ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, nei termini di cui all’art. 58 ter Ord. Pen., possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio”.
La Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata sulla questione.
I progetti di riforma dell’articolo 4 bis
La “Commissione Palazzo”, incaricata, con decreto del Ministero della Giustizia del 10 giugno 2013, di elaborare un progetto di riforma del sistema penale ha proposto, nello specifico, di modificare le disposizioni regolanti l’ergastolo stabilite dall’articolo 4 bis, al fine di sostituire la presunzione assoluta di pericolosità sociale in presunzione relativa. Ha inoltre suggerito di prevedere altre circostanze in grado di permettere la valutazione dei risultati del percorso di reinserimento e dell’assenza di legami con il gruppo criminale, al fine di rendere possibile l’accesso alla liberazione condizionale e ai benefici previsti dalla legge.
Il 19 maggio 2015, il Governo ha avviato gli “Stati generali dell’esecuzione penale”, un’iniziativa che ha coinvolto sia le istituzioni sia l’accademia, nonché le diverse professionalità impegnate nel mondo penitenziario, al fine di elaborare un progetto di riforma del sistema penitenziario. Il documento finale, pubblicato il 19 aprile 2016, conteneva, tra le altre, una proposta di riforma dell’articolo 4 bis, volta a introdurre un nuovo comma, che avrebbe dovuto offrire al condannato un’alternativa alla “non collaborazione”, consentendo l’accesso ai benefici e alla liberazione condizionale. Si trattava di una condotta riparatrice nei confronti delle vittime e più in generale nei confronti della società.
La legge delega n. 103 del 23 giugno 2017 (la c.d. “Legge Orlando”) ha autorizzato il Governo a riformare il CP, il codice di procedura penale (CPP) e la legge sull’ordinamento penitenziario. In particolare, l’articolo 1, comma 85, lettera e) ha delegato al Governo il potere di sopprimere gli
automatismi che impediscono l’individualizzazione del trattamento rieducativo penitenziario e di riformare il regime di accesso ai benefici penitenziari per i condannati all’ergastolo, esclusi i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in ogni caso i delitti collegati alla mafia e al terrorismo. Il 2 ottobre 2018, il Governo ha adottato il decreto legislativo n.
214 relativo alla riforma del sistema penitenziario, senza modificare le norme riguardanti l’individualizzazione del trattamento penitenziario e l’accesso ai benefici penitenziari.
LA NORMATIVA EUROPEA E INTERNAZIONALE RILEVANTE
I testi di diritto europeo e internazionale rilevanti per il caso di specie, in particolare in tema di ergastolo e sul principio della risocializzazione, sono richiamati nelle sentenze Vinter e altri v. Regno Unito ([GC], nn. 66069/09 e 2 altri, §§ 60-75 e 76-81, CEDU 2013 (estratti)), Dickson v. Regno Unito ([GC], n. 44362/04, §§ 28-36, CEDU 2007-V) e Murray v. Paesi Bassi ([GC], n. 10511/10, §§ 58-65 e 70-76, 26 aprile 2016).
IN DIRITTO
SULLA DOGLIANZA RELATIVA ALLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE
Nell’ambito dell’articolo 3 della Convenzione, il ricorrente lamenta che la pena dell’ergastolo inflittagli è incomprimibile e non gli offre alcuna possibilità di beneficiare della liberazione condizionale; ciò contrasta con le esigenze di questa disposizione. Richiamando gli articoli 3 e 8 della Convenzione, lamenta anche l’incompatibilità del regime penitenziario con lo scopo di cambiamento e di risocializzazione dei detenuti.
La Corte ricorda che spetta a lei decidere sulla qualificazione giuridica dei fatti del caso e che non è vincolata dalla ricostruzione operata dai ricorrenti (si vedano, tra le altre, Guerra e altri v. Italia, 19 febbraio 1998, § 44, Raccolta sentenze e decisioni 1998-I, Scoppola v. Italia n. 2 [GC], n. 10249/03, § 48, 17 settembre 2009, e Radomilja e altri v. Croatia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, § 126, 20 marzo 2018). Per tale ragione, considerando la formulazione delle doglianze presentate dal ricorrente, la Corte decide di esaminarle unicamente dal punto di vista dell’articolo 3 della Convenzione, così formulato:
“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”
Sulla ammissibilità
Sulla qualifica di vittima
Il Governo sostiene che il ricorrente non può essere considerato vittima ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, in quanto, a suo parere, alle autorità non è imputabile alcuna violazione dei diritti convenzionali facenti capo all’interessato.
La Corte ritiene che l’eccezione sollevata dal Governo sia strettamente legata alla questione di sapere se la pena dell’ergastolo, alla quale il ricorrente è stato condannato, sia comprimibile de iure e de facto e quindi al merito della doglianza riguardante la violazione dell’articolo 3. Conseguentemente, decide di unirla alla valutazione sul merito.
2. Sul mancato esperimento delle vie di ricorso interne
Il Governo solleva anche un’eccezione di mancato esperimento delle vie di ricorso interne. Ritiene che il ricorrente si lamenti, in sostanza, di non essere stato riconosciuto innocente dalle giurisdizioni interne. Sostiene, inoltre, che l’interessato abbia erroneamente adito la magistratura di sorveglianza richiedendo la liberazione condizionale, quando, invece, per protestare la propria innocenza, avrebbe avuto a sua disposizione una via di ricorso interna specifica e appropriata, vale a dire la domanda di revisione della sentenza definitiva emessa nei suoi confronti, istituto previsto dagli articoli 629 e seguenti del codice di procedura penale. Rimprovera pertanto al ricorrente di non aver esercitato un rimedio specificamente previsto dal suddetto codice.
Il ricorrente contesta la tesi del Governo. Egli sostiene che le sue valutazioni riguardano chiaramente il fatto che il sistema nazionale non offre alcuna possibilità di riduzione della pena per i condannati all’ergastolo per uno dei reati previsti dall’articolo 4 bis. La reclusione a vita costituisce così una pena de jure e de facto incomprimibile, in manifesta violazione dell’articolo 3 della Convenzione.
Il ricorrente evidenzia che la sua domanda alla magistratura di sorveglianza mirava ad ottenere un riesame delle esigenze di ordine penologico che giustificassero il suo mantenimento in detenzione. Ora, secondo il ricorrente, in assenza della collaborazione con la giustizia, la magistratura di sorveglianza non può tener conto del percorso di cambiamento del condannato e determinare se sono stati compiuti dei progressi.
Per quel che riguarda la professione di innocenza, il ricorrente sottolinea che si tratta di un sentimento personale, una convinzione intima che riguarda la sua sfera privata, che è espressione di un aspetto della sua identità e della sua dignità di essere umano. Ai suoi occhi, il fatto di
protestarsi innocente deve pertanto essere percepito unicamente come uno degli elementi che gli impediscono di collaborare con la giustizia.
Il ricorrente conclude che la sola via di ricorso interna di cui disponeva, per permettere alle autorità nazionali di rimediare alle violazioni lamentate, era quella di adire la magistratura di sorveglianza, presentando una domanda di liberazione condizionale.
La Corte osserva, innanzitutto, che la domanda di revisione di una sentenza è un rimedio straordinario, che può essere presentato contro una sentenza penale irrevocabile di condanna. Ricorda di aver già affermato che i ricorrenti non sono tenuti a far uso di questo tipo di rimedi straordinari, per rispettare quanto disposto dall’articolo 35 § 1 della Convenzione (Sofri e altri v. Italia (dec.), n. 37235/97, CEDU 2003VIII, Prystavska c. Ucraina (dec.), n. 21287/02, CEDU 2002X).
Sottolinea, peraltro, che le situazioni che permettono di richiedere la revisione sono rigorosamente elencate: contrasto nell’accertamento dei fatti tra due giudicati di condanna irrevocabili; revocazione di una sentenza civile o amministrativa, che ha statuito su una questione pregiudiziale; esistenza di nuove prove, che giustificano l’assoluzione del condannato; condanna pronunciata in conseguenza di falso in giudizio o di un altro reato.
Ora, nella fattispecie, la Corte nota che il caso del ricorrente non rientra in alcuna di tali ipotesi. In effetti, l’interessato denuncia, sotto il profilo dell’articolo 3 della Convenzione, l’impossibilità di beneficiare della liberazione condizionale, a causa della incomprimibilità della pena dell’ergastolo che gli è stata inflitta e la protesta di innocenza non è che uno degli elementi di cui si avvale.
Pertanto, la Corte ritiene che il ricorrente abbia correttamente adito la magistratura di sorveglianza, vale a dire la giurisdizione competente per decidere sulla liberazione condizionale e su ogni altra forma di rivalutazione della pena delle persone condannate, al fine di valutare la scarcerazione. Per quanto detto, la Corte rigetta l’eccezione del Governo.
3. Conclusione
66. Alla luce degli elementi di cui dispone, la Corte ritiene che le doglianze del ricorrente, in riferimento all’articolo 3, sollevino, rispetto alla Convenzione, importanti questioni di fatto e di diritto che richiedono un esame nel merito. Inoltre, la Corte ha deciso di valutare nel merito l’eccezione del Governo, per quanto riguarda la qualificazione di “vittima” del ricorrente (paragrafo 56, qui sopra). E conclude che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione. Constatando che non è presente alcun altro motivo di inammissibilità, la Corte dichiara il ricorso ammissibile.
Sul merito
Tesi delle parti
Il ricorrente
Il ricorrente rileva che il sistema italiano prevede due tipi di ergastolo: quello “ordinario”, previsto dall’articolo 22 del CP, che permette un riesame della pena dopo ventisei anni di detenzione e quello incomprimibile, detto “ergastolo ostativo”, previsto dall’articolo 4 bis. Egli sottolinea che questo articolo comporta una impossibilità di riconoscere la liberazione condizionale e gli altri benefici penitenziari, che trova fondamento in una irreversibile presunzione legislativa assoluta di pericolosità, vale a dire la persistenza del legame tra il condannato e l’associazione criminale mafiosa di appartenenza. Solo una effettiva collaborazione con la giustizia permetterebbe di escluderla.
Il ricorrente evidenzia che, a causa della presenza della circostanza aggravante accertata nei suoi confronti al momento della condanna, e riguardante l’assunzione del ruolo di capo del clan mafioso e promotore delle sue attività, il giudice non potrà mai considerare la sua collaborazione come “impossibile” o “inesigibile” (paragrafo 46, qui sopra).
Sostiene che si ritrova senza alcuna prospettiva di rilascio e senza possibilità di far riesaminare la pena dell’ergastolo che gli è stata inflitta: a suo dire, qualunque sia il suo comportamento in carcere, la sua pena rimane immutabile e insuscettibile di controllo, in quanto il giudice competente ad effettuare l’esame non può valutare i risultati del suo percorso di cambiamento.
Il ricorrente aggiunge che la coercizione che dice di subire, oltre a scontrarsi con la sua intima convinzione di essere innocente e quindi con la sua libertà morale, lo pone davanti a un dilemma: accettare il rischio di mettere in pericolo la propria vita e quella dei suoi cari, esponendosi ed esponendoli alle rappresaglie tipiche della logica mafiosa, o rifiutare di collaborare e rinunciare ad ogni possibilità di liberazione.
Il ricorrente afferma inoltre che la collaborazione con la giustizia non può costituire una “prospettiva di rilascio” per motivi di ordine penologico, ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione. A riguardo, argomenta che il sistema italiano obbliga il condannato a collaborare con la giustizia, in quanto un eventuale rifiuto lo escluderebbe a priori da ogni percorso di reinserimento e da ogni possibilità di accedere alla liberazione condizionale. Ai suoi occhi, questo meccanismo presenta delle forti similitudini con il meccanismo valutato nel caso Trabelsi v. Belgio (n. 140/10, §§ 134-139, CEDU 2014 (estratti)). In più, il ricorrente lamenta che l’automatismo previsto dalla legislazione italiana favorisce eccessivamente le esigenze di politica criminale, a discapito degli imperativi penitenziari di
risocializzazione e ciò comporterebbe una violazione della dignità umana di ogni detenuto. A suo dire, questo meccanismo l’ha ridotto al suo reato e non gli permette di prefigurare l’uscita dal carcere, se non attraverso una logica strumentale (che si traduce, per l’interessato, nel fatto di offrire la sua collaborazione totale), ignorando però totalmente il suo percorso rieducativo.
Riguardo infine agli scopi della risocializzazione e del reinserimento dei detenuti, che sono principi stabiliti dalla Corte (Murray, citata, §§ 102- 104, e Khoroshenko c. Russia [GC], n. 41418/04, § 121, CEDU 2015), il ricorrente lamenta che la previsione legislativa nel caso di specie implica una presunzione assoluta di non-rieducazione e di persistenza della pericolosità, in caso di mancanza di collaborazione. La possibilità di lavorare al proprio reinserimento sarebbe quindi svuotata di ogni efficacia e questa prospettiva, oltre ad esporlo ad una situazione di estrema angoscia, lo priverebbe di ogni possibilità di influire, con il suo comportamento, sul percorso di reinserimento nella società. Anche la sua capacità di autodeterminazione sarebbe colpita. Lo Stato italiano non rispetterebbe il suo obbligo positivo di garantirgli la possibilità di lavorare al suo reinserimento.
Per quanto riguarda la procedura della liberazione condizionale, il ricorrente espone che durante l’intera detenzione ha sempre tenuto una condotta positiva, sia a livello comportamentale che a livello rieducativo e che ha partecipato con successo alle attività di reinserimento. Indica che, non avendo subito alcuna sanzione disciplinare, ha accumulato più di cinque anni di “liberazione anticipata” (alla data del 30 dicembre 2013), proprio per via della sua partecipazione alle attività proposte dall’amministrazione penitenziaria. Precisa che non può tuttavia beneficiarne in quanto è sottoposto al regime dell’articolo 4 bis.
Ancora, il ricorrente sostiene che i suoi progressi in carcere sono stati constatati dal TdS dell’Aquila nell’ordinanza che aveva posto fine al regime del “41 bis”. Tuttavia, anche presentando elementi di prova concreti che giustificano la sua domanda di liberazione, non potrà mai ottenere un esame di tali elementi, sia in una procedura di liberazione condizionale e del resto sia di richiesta di un permesso premio. Peraltro, il ricorrente lamenta che la procedura di riesame non rispetta i criteri procedurali imposti in materia dalla giurisprudenza della Corte (Murray, citata, § 99).
Riguardo, infine, al potere di grazia presidenziale, il ricorrente afferma che nessun condannato all’ergastolo, rientrante nel regime dell’articolo 4 bis, è stato graziato dal Presidente della Repubblica.
Il Governo
Nelle sue osservazioni, il Governo tiene a ricordare innanzitutto il contesto particolare in cui è applicato l’articolo 4 bis. Afferma che, a causa
dell’estrema gravità dei delitti in questione, per i quali l’elemento mafioso si caratterizzerebbe dalla solidità del legame e la sua stabilità nel corso del tempo, il regime del caso di specie richiede di dimostrare in modo tangibile, con la collaborazione con le autorità, vuoi la riuscita del percorso rieducativo in carcere, vuoi la “dissociazione” dall’ambiente criminale. In altri termini, per il Governo resistente, il detenuto deve essere in grado di provare, alla fine del suo percorso di risocializzazione, che ha rifiutato i “valori criminali”, contribuendo alla “disintegrazione” dell’associazione mafiosa e al ristabilimento della legalità.
Il Governo constata inoltre che esiste una profonda differenza tra il regime del 41 bis e quello previsto dall’articolo 4 bis. A riguardo indica che, nel caso di specie, la magistratura di sorveglianza ha posto fine al regime speciale previsto dall’articolo 41 bis, ritenendo che il ricorrente non avesse più la capacità di mantenere dal carcere i contatti con l’organizzazione criminale, mentre, per quanto previsto dall’articolo 4 bis, l’interessato sarebbe tenuto a fornire la prova positiva della rottura di ogni collegamento con l’organizzazione criminale d’appartenenza.
Il Governo ritiene che questa distinzione sia fondamentale, tanto più che il clan mafioso, del quale il ricorrente è stato riconosciuto essere uno dei capi storici, sarebbe ancora molto attivo a Taurianova, come provavano le ordinanze di custodia cautelare adottate nei confronti di membri di questo clan o l’arresto della moglie dell’interessato il 12 dicembre 2017.
Per quanto riguarda la natura dell’ergastolo previsto dall’articolo 4 bis, il Governo, ricordando la giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana e della Corte di Cassazione, sostiene che rimane compressibile de iure e de facto.
In effetti, a detta del Governo, il condannato all’ergastolo può presentare una domanda di liberazione condizionale alla magistratura di sorveglianza, basandosi sui risultati del percorso rieducativo e sulla collaborazione con l’autorità giudiziaria. Secondo il Governo, il sistema offre così una prospettiva concreta all’ergastolano, da una parte, permettendo che questi possa accedere ai benefici penitenziari in caso di collaborazione “impossibile” o “inesigibile” (il Governo ha trasmesso un elenco molto dettagliato delle pronunce che fanno giurisprudenza su questo aspetto) e, dall’altra parte, connettendo alla libera scelta dell’interessato di collaborare, e non a un automatismo legislativo, la possibilità di ottenere questi stessi benefici. Ciò giustificherebbe la scelta del legislatore di dare priorità alle esigenze di prevenzione generale e di protezione della società.
Il Governo sostiene che, nel caso di specie, la procedura di riesame ha permesso di tener conto dei progressi del ricorrente nel suo percorso rieducativo. Indica che i giudici aditi hanno potuto determinare se l’interessato aveva compiuto progressi tali affinché alcun motivo legittimo di ordine penologico poteva più giustificare il suo mantenimento in detenzione. Ha sostenuto, inoltre, che il ricorrente ha avuto sempre
l’opportunità di collaborare con l’autorità giudiziaria, per fornire la prova inconfutabile della sua completa riabilitazione.
Il Governo espone, in aggiunta, che il sistema interno prevede due altri rimedi, alternativi alla domanda di liberazione condizionale: la domanda di grazia presidenziale, prevista dall’articolo 174 del CP e la domanda di sospensione dell’esecuzione della pena per motivi di salute, prevista dagli articoli 147 e 148 dello stesso codice.
Riguardo alla prospettiva della rivalutazione della legittimità della detenzione per ragioni di ordine penologico, il Governo contesta l’analisi della sentenza Trabelsi (citata) fatta dal ricorrente, in quanto verteva principalmente sull’assenza di criteri oggettivi e prestabiliti, in merito alla procedura di riesame prevista nell’ordinamento statunitense. Secondo il Governo, la legislazione italiana prevede, al contrario, una procedura di riesame della pena a vita, fondata su criteri chiari ed oggettivi. Gli effetti della collaborazione con la giustizia sarebbero chiaramente stabiliti dall’articolo 58 ter del CP e conosciuti in anticipo dai condannati.
Il Governo argomenta che il sistema italiano garantisce ai detenuti condannati all’ergastolo una possibilità di lavorare al loro reinserimento, in applicazione dell’obbligo positivo nascente dagli articoli 3 e 8 della Convenzione. L’obiettivo di reinserimento sarebbe perseguito dalla legge dell’ordinamento penitenziario, anche per i condannati alla pena a vita cosiddetta “ergastolo ostativo”, attraverso l’individualizzazione del trattamento penitenziario (sostegno costante agli interessi culturali, umani e professionali dei detenuti, soppressione degli ostacoli allo sviluppo personale e promozione della risocializzazione).
In conclusione, il Governo sostiene che il legislatore non ha fatto altro che aggiungere una condizione ulteriore per i condannati all’ergastolo entro il regime disciplinato dall’articolo 4 bis. A dire del Governo, una volta soddisfatta questa condizione, che il detenuto è libero di rispettare collaborando con le autorità, questi può aspirare alla liberazione condizionale e ai benefici penitenziari. Il sistema italiano è dunque, nella visione del Governo, compatibile con l’articolo 3 della Convenzione.
I terzi intervenienti
Gli accademici e esperti coordinati dall’Università degli Studi di Milano (Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storici-politici)
Gli accademici ed esperti, coordinati dall’Università degli Studi di Milano, rilevano, per prima cosa, l’evoluzione della legislazione in materia: l’articolo 4 bis, inizialmente previsto per permettere a colui che ha collaborato con la giustizia di avere accesso ai benefici penitenziari in via preferenziale rispetto agli altri, vale a dire prima del decorso del termine ordinariamente previsto, è stato modificato dal decreto-legge n. 306 dell’8
giugno 1992, in seguito all’attentato contro il giudice G. Falcone e la sua scorta, nel senso di una trasformazione della “collaborazione” in elemento necessario per l’accesso alla liberazione condizionale e agli altri benefici penitenziari.
La parte terza richiama, poi, la giurisprudenza della Corte, per dedurne che, se un trattamento o una pena non possono mai essere contrarie al principio della “dignità umana”, quale che sia il loro effetto dissuasivo, il non tener conto della possibilità di “non collaborare” e di mantenere il silenzio costituisce una violazione alla dignità dell’individuo e del suo diritto all’autodeterminazione. Secondo questi terzi intervenenti, l’automatismo legislativo, che vede il detenuto “non collaborante” escluso da ogni beneficio, introduce una presunzione assoluta di pericolosità, legata ad un un’ampia ed eterogenea categoria di delitti, che la dottrina qualifica con l’espressione “diritto penale d’autore”. La presunzione di pericolosità sociale non potrebbe, in pratica, essere rovesciata da alcun giudice.
Per questa parte terza, il regime della pena dell’ergastolo incomprimibile è anche in contraddizione con i principi di individualizzazione e di progressività del trattamento penitenziario: l’ergastolo ostativo impedisce ogni progresso del detenuto “non collaborante” nel percorso di reinserimento graduale nella società.
Il centro di documentazione “L’altro diritto onlus” (Università degli Studi di Firenze)
Il centro di documentazione “L’altro diritto onlus” fa presente, innanzitutto, che, secondo i dati forniti nel 2016 dal Ministero della Giustizia italiano, sul numero totale di condannati all’ergastolo, il 72,5% (vale a dire 1.216 persone) erano detenuti per uno dei delitti previsti dall’articolo 4 bis (ergastolo ostativo). Secondo questo terzo interveniente, introducendo la “collaborazione con la giustizia” come condizione preliminare ad ogni valutazione del percorso di reinserimento del condannato, il sistema nazionale è in contraddizione con il diritto di autodeterminazione di quest’ultimo. Il detenuto non è in grado di determinare la sua esistenza in carcere e di avere un’influenza sullo svolgimento della pena, in quanto, in assenza di collaborazione, il suo comportamento e le sue azioni non sono prese in considerazione dal giudice. Inoltre, la pena a vita sarebbe contraria all’obbligo positivo dello Stato di organizzare un sistema penitenziario che favorisca la rieducazione e il reinserimento dei detenuti.
Il centro di documentazione “L’altro diritto onlus” espone, infine, che l’alternativa tra la collaborazione e la non collaborazione obbliga il detenuto condannato all’ergastolo a scegliere tra, da una parte, la sua dignità (la sua capacità di determinare il suo percorso di uscita, che deve passare dalla collaborazione) e, dall’altra parte, la sua vita o la sua integrità e quella
dei suoi familiari (essendovi il rischio di rappresaglie in ambito mafioso). Su questo ultimo punto in particolare e fondandosi sull’osservazione diretta dei detenuti condannati all’ergastolo che ha incontrato, precisa che la ragione principale del rifiuto di collaborare risiede nel timore per il detenuto di mettere in pericolo se stesso o i suoi familiari.
La rete europea di ricerca e d’azione in contenzioso penitenziario (RCP)
La RCP considera che il criterio della “non collaborazione” non può essere un motivo penologico legittimo e, in ogni caso, la procedura di riesame in Italia non rispetta i parametri convenzionali. In particolare, sostiene che la giurisprudenza interna mostra l’esistenza di un esame praticamente binario (collaborazione o non collaborazione), al quale la magistratura di sorveglianza sarebbe costretta a far riferimento, circostanza ben lontana dal controllo in concreto delle esigenze di ordine penologico che giustificano il mantenimento in detenzione.
Peraltro, la RCP invita la Corte ad occuparsi di due questioni che, dal suo punto di vista, dovrebbero chiarire la sua giurisprudenza: una, relativa all’affermazione dell’esigenza di un controllo giurisdizionale rigoroso, accompagnato da garanzie procedurali analoghe alle garanzie esistenti in materia di libertà personale; l’altra, riguardante la consacrazione di un vero e proprio “diritto al reinserimento sociale”, esigenza dettata dai principi di effettività (che permetterebbe alla Corte di chiarire gli obblighi degli Stati) e di sussidiarietà (che porterebbe il giudice nazionale a controllare il rispetto del diritto convenzionale a livello interno).
2. Valutazione della Corte
Principi applicabili
I principi rilevanti in materia di pene detentive perpetue, di reinserimento e di liberazione condizionale sono stati esposti in dettaglio nella sentenza Vinter (citata, § 103–122, con i riferimenti alla sentenza Kafkaris v. Cipro [GC], n. 21906/04, CEDU 2008), e recentemente riassunti nelle sentenze Murray (citata, §§ 99-100) e Hutchinson v. Regno Unito [GC] (n. 57592/08, §§ 42-45, 17 gennaio 2017).
Applicazione dei principi al caso di specie
La Corte, da subito, osserva che, nel caso di specie, il ricorrente non si lamenta di una netta sproporzione della pena dell’ergastolo alla quale è stato condannato (si vedano, tra altre, Matiošaitis e altri v. Lituania,
nn. 22662/13 e 7 altri, § 157, 23 maggio 2017, e Vinter, citata, § 102), ma della incomprimibilità de iure e de facto di questa pena.
La Corte, poi, nota che il presente caso si distingue dai casi riguardanti la pena dell’ergastolo presentati in precedenza nei confronti dell’Italia, dove era stata chiamata ad esaminare la pena a vita disciplinata dall’articolo 22 del CP. Nella decisione Garagin v. Italia ((dec.) n. 33290/07, 29 aprile 2008; si veda anche Scoppola v. Italia (dec.) n. 10249/03, 8 settembre 2005), la Corte ha sostenuto che la reclusione a vita resta compatibile con l’articolo 3 della Convenzione, esprimendosi come segue:
“(...) il condannato all’ergastolo può essere scarcerato secondo la formulazione dell’articolo 176 del CP. Secondo questa disposizione, il condannato all’ergastolo, che ha tenuto un comportamento tale da dimostrare un sicuro ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale dopo aver scontato ventisei anni di detenzione. Può inoltre essere ammesso al regime di semi-libertà dopo aver scontato venti anni di reclusione (articolo 50 § 5 della legge n. 354 del 1975) (…), in Italia le pene a vita sono (…) de iure e de facto comprimibili. Peraltro, non si può dire che il ricorrente non abbia alcuna prospettiva di liberazione, né che il suo mantenimento in detenzione, seppur per un lungo periodo, è in se costitutivo di un trattamento inumano o degradante”.
Peraltro, nella sentenza Vinter (citata, § 117), la Corte si è basata, tra l’altro, sul diritto interno italiano – la legislazione e la giurisprudenza della Corte costituzionale – per affermare che la prassi degli Stati contraenti riflette la volontà di aprire al reinserimento dei condannati all’ergastolo e di offrire loro una prospettiva di liberazione
La Corte osserva che, nel caso di specie, il regime applicabile alla pena perpetua è il risultato dell’applicazione combinata dell’articolo 22 del CP con gli articoli 4 bis e 58 ter della legge sull’ordinamento penitenziario. Questa categoria specifica di pena a vita è denominata, a livello nazionale, come “ergastolo ostativo”.
Rileva che tali disposizioni prevedono un trattamento penitenziario differenziato, che ha l’effetto di impedire la concessione della liberazione condizionale, nonché l’accesso agli altri benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione (ad eccezione della “liberazione anticipata”), qualora non sia stata soddisfatta la necessaria condizione di collaborare con la giustizia. In effetti, se per tutte le misure che favoriscono il progressivo reinserimento del condannato all’ergastolo, regolato dall’articolo 22 del CP, il legislatore, in funzione della misura richiesta, ha previsto certe condizioni di accesso (buona condotta, partecipazione al progetto rieducativo, progressione del percorso trattamentale, prova positiva di cambiamento), con l’articolo 4 bis ha instaurato una condizione specifica (paragrafo 32, qui
sopra), che è di ostacolo alla concessione dei benefici da parte del giudice nazionale.
La Corte osserva che il contenuto di questa collaborazione è disciplinato dall’articolo 58 ter (paragrafo 33, qui sopra): il condannato deve fornire alle autorità elementi decisivi che permettano di prevenire le conseguenze ulteriori del reato o di facilitare l’accertamento dei fatti e l’identificazione dei responsabili dei reati. Il condannato è dispensato da tale obbligo se tale collaborazione può essere qualificata come “impossibile” o “inesigibile” (paragrafo 46, qui sopra) e se prova la rottura di ogni legame attuale con il gruppo mafioso (paragrafo 32, qui sopra).
Sulla prospettiva di liberazione e la possibilità di chiedere la liberazione condizionale
La Corte osserva, al pari del ricorrente e del Governo (paragrafi 68 e 77, qui sopra), che, a causa dell’esistenza della circostanza aggravante collegata al ruolo di capo all’interno del gruppo mafioso di appartenenza riconosciuta nei suoi confronti, l’interessato non potrebbe ottenere che la sua eventuale collaborazione sia qualificata come “impossibile” o “inesigibile”, conformemente alla legislazione in vigore e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (paragrafi 33 e 46, qui sopra).
Così, per determinare nel caso di specie se il cosiddetto “ergastolo ostativo” è de jure e de facto comprimibile, vale a dire se offre una prospettiva di rilascio e una possibilità di riesame (si veda, tra molte altre, Hutchinson, citata, § 42), la Corte si concentrerà sulla sola opzione disponibile in capo al ricorrente: collaborare all’interno delle attività investigative e inquirenti condotte dalle autorità giudiziarie (paragrafo 77, qui sopra), al fine di avere una possibilità di domandare e ottenere la liberazione.
La Corte sottolinea che le circostanze riguardanti la situazione nel caso di specie sembrano distinguersi dai fatti di cui al caso Öcalan v. Turchia n.2 (nn. 24069/03 e 3 altri, §§ 200-202, 18 marzo 2014). In effetti, in questo caso, il contrasto tra l’ordinamento giuridico turco e l’articolo 3 della Convenzione derivava dalla disposizione normativa allora in vigore. Questa impediva al ricorrente, a causa della sua condizione di condannato alla pena dell’ergastolo aggravata per aver commesso un crimine contro la sicurezza dello Stato, di chiedere, ad un certo momento dell’esecuzione della pena, la liberazione per motivi legittimi di ordine penologico. In quel caso, si trattava di un automatismo legislativo, che escludeva ogni possibilità di ottenere il riesame della pena e che era legata alla natura del reato contestato al ricorrente.
La Corte osserva che, nel presente caso, la legislazione interna non vieta, in modo assoluto e con effetto automatico, l’accesso alla liberazione
condizionale e agli altri benefici del sistema penitenziario, ma li subordina alla “collaborazione con la giustizia”.
Effettivamente, la specifica situazione del ricorrente, derivante dall’articolo 4 bis, finisce con il situarsi tra quella del condannato all’ergastolo ordinario, prevista dall’articolo 22 del CP, la cui pena è comprimibile de jure e de facto, e quella del detenuto che si vede impedire dal sistema, a causa di un ostacolo normativo o pratico, ogni possibilità di liberazione, in violazione dell’articolo 3 della Convenzione.
La Corte considera le affermazioni del Governo (paragrafo 75, qui sopra), secondo le quali l’articolo 4 bis ha la finalità di domandare ai condannati la dimostrazione tangibile della loro “dissociazione” dall’ambiente criminale e la buona riuscita del percorso di risocializzazione, attraverso una utile collaborazione con la giustizia, volta alla “disintegrazione” dell’associazione mafiosa e al ripristino della legalità (si veda anche la Corte costituzionale, paragrafo 40, qui sopra). Per il Governo, l’obiettivo di politica criminale, sottostante alla disciplina del 4 bis, è quindi chiaramente definito, come peraltro evidenziato nella sentenza n. 306/1993 della Corte costituzionale (paragrafo 39, qui sopra): il legislatore ha esplicitamente privilegiato le finalità di prevenzione generale e di protezione della collettività, chiedendo ai condannati per i delitti in questione di dare prova di collaborazione con le autorità, collaborazione valutata come uno strumento di importanza capitale nella lotta contro il fenomeno mafioso. Secondo il Governo, la specificità del fenomeno conduce all’esigenza di prevedere un regime di reclusione a vita diverso dal regime ordinario di cui all’articolo 22 del CP.
Riguardo al fenomeno mafioso, la Corte ritiene utile riferirsi alle osservazioni del Governo (paragrafo 75, qui sopra) e alla sentenza della Corte di Assise di Palmi (paragrafo 9, qui sopra), che riporta la specificità dell’associazione mafiosa e l’accordo concluso tra i suoi appartenenti, associazione che si contraddistingue per essere particolarmente solida e caratterizzata da una certa continuità.
Rinvia anche alla sentenza della Corte di Cassazione n. 46103 del 7 novembre 2014 (paragrafo 47, qui sopra), nella quale è stato evidenziato che il reato di associazione mafiosa, un reato permanente, presuppone l’esistenza di un vasto programma criminale, proiettato nel futuro e senza alcuna limitazione temporale. Secondo la Suprema Corte, lo stato di detenzione di un membro appartenente a una associazione mafiosa non implica la cessazione automatica della sua partecipazione a tale organizzazione. La conclusione che ne trae la Corte di Cassazione è che la “permanenza” del reato previsto dall’articolo 416 bis è compatibile con l’inattività dell’associato o lo stato di latenza dell’associazione; il rapporto associativo cessa solamente nel caso oggettivo di rottura dell’accordo associativo o nel caso soggettivo di decesso, di rottura del legame
individuale o di esclusione da parte degli altri consociati (paragrafo 47, qui sopra).
L’articolo 4 bis prevede quindi una presunzione di pericolosità del condannato legata al tipo di reato per il quale è stato condannato. Questa pericolosità e il legale con l’ambiente criminale di appartenenza non scomparirebbero per il solo fatto di essere detenuto. La Corte nota che, secondo il Governo, è per questa ragione che la norma in questione chiede al condannato di provare concretamente, attraverso la collaborazione, di aver rotto il legame con l’ambiente criminale di appartenenza, cosa che indicherebbe anche il successo del processo di risocializzazione.
La Corte ricorda di aver affermato che la scelta degli Stati circa il regime complessivo della propria giustizia penale, ivi compreso il riesame della pena e le modalità di liberazione, sfugge in linea di principio al controllo europeo esercitato dalla stessa Corte, purché il sistema non disconosca i principi della Convenzione (Vinter, citata, § 104).
Ha anche sostenuto che, se la punizione rimane uno degli obiettivi della detenzione, le politiche penali europee mettono ormai l’accento sull’obiettivo di risocializzazione, che riguarda anche i detenuti condannati all’ergastolo (ibidem, §§ 115-118), in particolare verso la fine di una lunga pena detentiva (Dickson, citata, § 75, con riferimento ai paragrafi 28-36). Il principio di risocializzazione si riflette nelle norme internazionali ed è attualmente riconosciuto nella giurisprudenza della Corte (Murray, citata,
§102, con la giurisprudenza ivi citata).
A livello interno, la Corte rileva che, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 1990 (paragrafo 38, qui sopra), la giurisprudenza del giudice delle leggi sulla funzione della pena testimonia il ruolo centrale della risocializzazione, che deve accompagnare la pena dalla sua formulazione normativa astratta alla sua concreta esecuzione: la Corte costituzionale ha affermato che la risocializzazione deve orientare l’azione del legislatore, del giudice della cognizione, del giudice della sorveglianza e delle autorità penitenziarie.
Queste prime considerazione conducono la Corte ad affrontare la questione centrale che si pone nel caso del ricorrente, ovvero se l’equilibrio tra le finalità di politica criminale e la funzione di risocializzazione non finisca, nella sua applicazione pratica, per limitare eccessivamente la prospettiva di rilascio dell’interessato e la possibilità per quest’ultimo di domandare il riesame della pena.
La Corte osserva che il sistema penitenziario italiano si fonda sul principio della progressione trattamentale, secondo il quale la partecipazione attiva al programma individuale di rieducazione e il passare del tempo possono produrre degli effetti positivi sul condannato e promuovere il suo pieno reinserimento nella società. Man mano che evolve la detenzione, ammesso che evolva, il detenuto si vede offrire dal sistema la possibilità di beneficiare di misure progressive (che vanno dal lavoro
all’esterno alla liberazione condizionale), destinate ad accompagnarlo nel suo “cammino verso l’uscita”.
Si tratta di una declinazione della funzione rieducativa evocata nella sentenza Murray (precitata, § 101).
La Corte rileva, inoltre, di aver affermato che il principio della “dignità umana” impedisce di privare una persona della libertà, senza lavorare allo stesso tempo al suo reinserimento e senza fornire allo stessa la possibilità di riconquistare un giorno questa libertà. Ha precisato che “un detenuto condannato all’ergastolo incomprimibile ha il diritto di sapere (…) che cosa deve fare perché la sua liberazione sia possibile e quali sono le condizioni applicabili” (Vinter, citata, § 122).
Ha inoltre affermato che le autorità nazionali devono fornire ai detenuti condannati all’ergastolo una possibilità reale di reinserimento (Harakchiev e Tolumov v. Bulgaria, nn. 15018/11 e 61199/12, § 264, CEDU 2014 (estratti)). Si tratta, chiaramente, di un obbligo positivo di mezzi e non di risultato, che implica garantire per questi detenuti l’esistenza di regimi penitenziari che siano compatibili con l’obiettivo rieducativo e che permettano di progredire su questa strada (Murray, citata, § 104). A questo riguardo, la Corte ha precedentemente accertato la violazione di tale obbligo, nel caso in cui il regime o le condizioni detentive erano d’ostacolo alla rieducazione dei detenuti (Harakchiev e Tolumov, citata, § 266).
La Corte, nel caso di specie, considera la posizione del Governo, il quale sostiene che l’ostacolo rappresentato dall’assenza della “collaborazione con la giustizia” non è il risultato di un automatismo legislativo, che ostacolerebbe in modo assoluto ogni possibilità di liberazione per il ricorrente, ma piuttosto la conseguenza di una scelta individuale. Il ruolo centrale assegnato alla volontà del condannato, che sarebbe il solo artefice del suo destino, costituisce uno degli argomenti principali del Governo (paragrafo 79, qui sopra), il quale peraltro richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale (paragrafo 41, qui sopra).
La Corte valuta anche la tesi del ricorrente, che, da parte sua, afferma che collaborare con le autorità comporterebbe per lui o per i suoi familiari il rischio di essere esposti a rappresaglie da parte dell’organizzazione mafiosa e sarebbe contrario alla sua intima convinzione di essere innocente (paragrafo 70, qui sopra). Critica anche la logica strumentale del sistema, che fa dipendere la sua possibilità di liberazione con l’offerta di una sua collaborazione totale (paragrafo 71, qui sopra).
Ora, se è vero che il regime interno offre al condannato la scelta di collaborare o meno con la giustizia, la Corte dubita della libertà di questa scelta, come dell’opportunità di stabilire un’equivalenza tra la mancanza di collaborazione e la pericolosità sociale del condannato.
Senza voler analizzare la fondatezza della protesta di innocenza avanzata dal ricorrente – che d’altra parte sfugge alla sua competenza –, la Corte constata che quest’ultimo non fa che affermare che, per non andare
contro alla sua intima convinzione e per non dover subire reazioni violente da parte dei vecchi associati, ha deciso di non collaborare con la giustizia (paragrafo 70, qui sopra). Riguardo a questo aspetto, è opportuno ricordare le dichiarazioni del terzo interveniente “L’altro diritto onlus”, relative alla sua attività di osservazione diretta di detenuti condannati all’ergastolo regolato dall’articolo 4 bis. Secondo questo terzo interveniente, la ragione principale del rifiuto di collaborare con la giustizia risiederebbe nel timore per i detenuti condannati per delitti di tipo mafioso di mettere in pericolo la loro vita o quella dei loro familiari (paragrafo 89, qui sopra).
La Corte ne deduce che la mancanza di collaborazione potrebbe essere non sempre legata ad una scelta libera e volontaria, né giustificata unicamente dalla persistenza dell’adesione ai “valori criminali” e dal mantenimento di legami con il gruppo di appartenenza. Ciò è stato peraltro riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 306 dell’11 giugno 1993, quando ha affermato che l’assenza di collaborazione non indica necessariamente il mantenimento dei collegamenti con l’organizzazione mafiosa (paragrafo 39, qui sopra).
Inoltre, la Corte rileva, al pari di quanto fatto dalla Corte costituzionale nella medesima sentenza, che si potrebbe ragionevolmente essere messi di fronte alla situazione dove il condannato collabora con le autorità, senza che tuttavia il suo comportamento rifletta un cambiamento da parte sua o una “dissociazione” effettiva dall’ambiente criminale, in quanto l’interessato potrebbe agire con l’unico proposito di ottenere i vantaggi previsti dalla legge.
Constata che, se altre circostanze o altre considerazioni possono spingere il condannato a rifiutare di collaborare, o se la collaborazione può eventualmente essere proposta con uno scopo puramente opportunistico, l’immediata equivalenza tra l’assenza di collaborazione e la presunzione assoluta di pericolosità sociale finisce per non corrispondere al reale percorso rieducativo del ricorrente.
Osserva, in effetti, che, considerando la collaborazione con le autorità come la sola dimostrazione possibile della “dissociazione” del condannato e del suo cambiamento, non si è tenuto conto degli altri elementi che permettono di valutare i progressi compiuti dal detenuto. In effetti, non è escluso che la “dissociazione” con l’ambiente mafioso possa esprimersi in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia.
La Corte ricorda, come già detto (paragrafo 111, qui sopra), che il sistema penitenziario italiano offre un ventaglio di progressive occasioni di contatto con la società – che vanno dal lavoro all’esterno alla liberazione condizionale, passando dai permessi premio e dalla semilibertà – che hanno la finalità di favorire il processo di risocializzazione del detenuto. Ora, il ricorrente non ha beneficiato di queste progressive occasioni di reinserimento sociale.
La Corte rileva che tutto ciò si è verificato, nonostante i rapporti di osservazione del ricorrente durante la detenzione, allegati alla domanda di liberazione condizionale (paragrafo 24, qui sopra), avessero attestato un’evoluzione della personalità dell’interessato ritenuta positiva. Ugualmente, nota che l’ordinanza del TdS dell’Aquila, che aveva posto termine al regime del “41 bis”, nonostante sia stata presa in riferimento ad un riferimento normativo differente, indicava comunque i risultati positivi del percorso di risocializzazione del ricorrente (paragrafo 16, qui sopra).
La Corte constata, inoltre, che il ricorrente ha dichiarato di non essere mai stato sottoposto ad una sanzione disciplinare e di aver accumulato dalla sua condanna, per la partecipazione a un programma di reinserimento, circa cinque anni di liberazione anticipata (paragrafo 73, qui sopra), ma che, a causa dell’assenza della collaborazione, non può in pratica beneficiare della riduzione di pena ottenuta.
La Corte ritiene che la personalità del condannato non resta congelata al momento del reato commesso. Essa può evolvere durante la fase di esecuzione della pena, come vuole la funzione di risocializzazione, che permette alla persona di rivedere in maniera critica il suo percorso criminale e di ricostruire la sua personalità (Murray, citata, § 102).
La Corte ricorda che, per questo, il condannato deve sapere quello che deve fare perché la sua liberazione possa essere considerata e a quali condizioni (Vinter e altri, citata, § 122, e Trabelsi, citata, §§ 115 e 137).
In questo caso, la Corte ritiene che l’assenza della “collaborazione con la giustizia” determini una presunzione assoluta di pericolosità, che ha per effetto quello di privare il ricorrente di ogni prospettiva realistica di liberazione (si veda, tra altre, Harakchiev e Tolumov, citata, § 264, e Matiošaitis e altri, citata, § 177). Il ricorrente rischia di non potersi mai riscattare: qualsiasi cosa faccia in carcere, la sua punizione rimane immutabile, insuscettibile di controllo e rischia anche di appesantirsi con il tempo (Vinter, citata, § 112).
La Corte sottolinea che, in effetti, il ricorrente si trova nella impossibilità di dimostrare che non vi è più alcun motivo legittimo di ordine penologico a giustificazione del suo mantenimento in detenzione e che, pertanto, ciò è contrario all’articolo 3 della Convenzione (ibidem, § 129), dato che, disponendo l’equivalenza tra l’assenza di collaborazione e la presunzione assoluta di pericolosità sociale (paragrafi 116 e 120, qui sopra), il regime in vigore collega in realtà la pericolosità dell’interessato al momento in cui i delitti sono stati commessi, invece di tener conto del percorso di reinserimento e degli eventuali progressi compiuti dalla condanna.
Inoltre, la Corte sottolinea che tale presunzione assoluta impedisce de facto al giudice competente di esaminare la domanda di liberazione condizionale e di considerare se, nel corso dell’esecuzione della pena, il ricorrente è evoluto e progredito così tanto nel percorso di cambiamento,
che il mantenimento in detenzione non si giustifica più per motivi di ordine penologico (Murray, citata, § 100 con la giurisprudenza ivi citata). L’intervento del giudice è limitato alla constatazione del mancato rispetto della condizione della collaborazione, senza poter effettuare una valutazione del percorso individuale del detenuto e della sua evoluzione verso la risocializzazione. Cosa che, del resto, è avvenuta con la valutazione del TdS dell’Aquila nel presente caso. Quest’ultimo ha respinto la domanda di liberazione condizionale del ricorrente, rilevando l’assenza di collaborazione con la giustizia (paragrafo 25, qui sopra), senza una valutazione degli eventuali progressi che l’interessato diceva di aver compiuto dalla sua condanna.
La Corte riconosce certamente che i delitti per i quali il ricorrente è stato condannato riguardano un fenomeno particolarmente pericoloso per la società. Nota anche che l’introduzione dell’articolo 4 bis è il risultato della riforma del regime penitenziario del 1992 e che tale riforma è avvenuta in un contesto emergenziale, dove il legislatore è stato chiamato a intervenire in seguito a un episodio estremamente drammatico per l’Italia (paragrafo 85, qui sopra), in una situazione particolarmente critica. Detto questo, la lotta contro tale flagello non dovrebbe giustificare deroghe alle disposizioni dell’articolo 3 della Convenzione, che proibiscono in termini assoluti le pene inumane e degradanti. Pertanto, dalla visuale dell’art. 3, la natura dei reati per cui è stato condannato il ricorrente non è rilevante per l’esame del presente caso (Öcalan, citata, §§ 98 e 205, e la giurisprudenza ivi richiamata). Peraltro, la Corte ha affermato che la funzione della risocializzazione mira, in ultima analisi, ad impedire la recidiva e a proteggere la società (Murray, citata, § 102).
È opportuno ricordare che la Corte, in un caso riguardante la durata delle detenzione cautelare, e quindi nell’ambito dell’articolo 5 della Convenzione, ha richiamato il principio secondo il quale “la presunzione legale di pericolosità può giustificarsi in particolare quando non è assoluta, ma si presta a essere contraddetta dalla prova contraria” (Pantano v. Italia,
n. 60851/00, § 69, 6 novembre 2003). Questa affermazione vale ancora di più per quanto riguarda l’articolo 3 della Convenzione, considerando il carattere assoluto di questa disposizione, che non ammette alcuna eccezione (si veda, tra molte altre, Trabelsi, citata, § 118).
La Corte osserva, in subordine, che, a livello interno, sembra svilupparsi una recente tendenza in favore di una rimessa in discussione della presunzione assoluta di pericolosità sociale, come provano la sentenza
n. 149 dell’11 luglio 2018 della Corte Costituzionale (paragrafo 43, qui sopra), l’ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione alla Corte Costituzionale relativa alla legittimità costituzionale dell’articolo 4 bis (paragrafo 48, qui sopra), nonché i due recenti progetti di riforma dell’articolo 4 bis, di fonte governativa (paragrafi 49 e 50, qui sopra).
Sugli altri rimedi interni al fine di riesame della pena
Infine, per quanto riguarda le affermazioni del Governo, secondo le quali il sistema interno prevede due altri rimedi per ottenere il riesame della pena, vale a dire la domanda di grazia presidenziale e la domanda di sospensione della pena per motivi di salute (paragrafo 81, qui sopra), la Corte ricorda la sua giurisprudenza rilevante per il caso di specie, secondo la quale la possibilità per un detenuto che sconti la pena dell’ergastolo di beneficiare della grazia o della rimessione in libertà per motivi umanitari, legati ad un problematico stato di salute, ad una invalidità fisica o all’età avanzata, non corrisponde al significato dell’espressione “prospettiva di rilascio”, utilizzata a partire dalla sentenza Kafkaris (citata, § 127; si veda anche Öcalan, citata, § 203, e László Magyar v. Ungheria, n.73593/10,
§§ 57 e 58, 20 maggio 2014).
In particolare, la Corte osserva che, nella sentenza n. 200 del 18 maggio 2006 (paragrafo 44, qui sopra), la Corte costituzionale ha ritenuto che il potere di grazia presidenziale risponde a finalità eminentemente umanitarie e serve a temperare la rigidità della legge penale. Riguardo alle domande di sospensione della pena per motivi di salute, esse corrispondo a ciò che la Corte ha definito al pari di un “riesame limitato a motivi umanitari” (Hutchinson, citata, § 43, Vinter, citata, § 127, e Matiošaitis e altri, citata, § 173)
Peraltro, la Corte prende nota di quanto dichiarato dal ricorrente, secondo il quale nessun detenuto condannato all’ergastolo rientrante nel regime di cui all’articolo 4 bis ha mai beneficiato di una decisione di grazia presidenziale (paragrafo 74, qui sopra). A questo riguardo, il Governo non ha fornito alcun esempio di un condannato all’ergastolo di questo tipo che abbia ottenuto una modifica della pena in forza di una grazia presidenziale (si veda Bodein v. Francia, n. 40014/10, § 59, 13 novembre 2014, e, a contrario, Kafkaris, citata, § 103).
Conclusione
La Corte vuole rimarcare che la dignità umana, situata al centro del sistema creato dalla Convenzione, impedisce di privare una persona della sua libertà, senza operare al tempo stesso per il suo reinserimento e senza fornirgli una possibilità di riguadagnare un giorno questa libertà (Vinter, citata, § 113).
Tenuto conto dei principi e delle ragioni esposte sopra, la Corte considera che la pena perpetua alla quale è soggetto il ricorrente, in virtù dell’art. 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario, ossia il cd. “ergastolo ostativo”, limita eccessivamente la prospettiva di rilascio dell’interessato e la possibilità di riesame della pena. Pertanto, questa pena
perpetua non può essere qualificata come comprimibile ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione. La Corte rigetta in tal modo l’eccezione del Governo, riguardante la qualificazione di vittima del ricorrente e conclude che in questo ambito le esigenze dell’articolo 3 della Convenzione non sono state rispettate.
Detto ciò, ritiene che l’accertamento della violazione nel presente caso non dovrebbe essere intesa al pari della possibilità, per il ricorrente, di prospettarsi una imminente liberazione (si veda, tra le altre, Harakchiev e Tolumov, citata, § 268, e László Magyar, citata, § 59).
SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 46 DELLA CONVENZIONE
Ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione :
“1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione”.
La Corte ricorda che, interpretato alla luce dell’articolo 1 della Convenzione, l’articolo 46 impone allo Stato resistente l’obbligo giuridico, non solo di versare alle persone interessate le somme riconosciute a titolo di equa soddisfazione, ma anche di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o se del caso individuali idonee per porre fine ai problemi che hanno condotto all’accertamento della violazione, nonché per porre fine alle conseguenze di questi problemi (Scozzari e Giunta v. Italia [GC], nn. 39221/98 e 41963/98, § 249, CEDU 2000VIII, e László Magyar, citata, § 70). Per facilitare il rispetto da parte dello Stato membro degli obblighi nascenti dall’articolo 46, la Corte può eccezionalmente indicare il tipo di misure individuali o generali auspicabili per porre fine alla situazione di violazione constatata (Broniowski v. Polonia [GC], n. 31443/96, §§ 189-194 e il suo dispositivo, CEDU 2004V, Scoppola
v. Italia n. 2 [GC], citata, § 148, e Stanev v. Bulgaria [GC], n. 36760/06,
§ 255, CEDU 2012).
Il presente caso mette in luce un problema strutturale, per il quale sono attualmente pendenti davanti alla Corte un certo numero di ricorsi. In prospettiva, potrebbe dar luogo alla presentazione di numerosi altri ricorsi aventi ad oggetto la stessa problematica.
La Corte ribadisce che la presunzione assoluta di pericolosità, prevista in materia di reclusione a vita per i delitti previsti dall’articolo 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario, derivante dall’assenza di collaborazione con la giustizia, rischia di privare i condannati per questi reati di ogni prospettiva di rilascio e della possibilità di ottenere un riesame della pena.
La natura della violazione accertata ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione impone allo Stato di attuare, di preferenza per iniziativa legislativa, una riforma del regime della reclusione dell’ergastolo, che garantisca la possibilità di riesame della pena; cosa che permetterebbe alle autorità di determinare se, nel corso dell’esecuzione della pena, vi è stata una evoluzione del detenuto e se è progredito nel percorso di cambiamento, al punto che nessun motivo legittimo di ordine penologico giustifichi più la detenzione. Inoltre, la riforma deve garantire la possibilità per il condannato di beneficiare del diritto di sapere cosa deve fare perché la sua liberazione sia possibile e quali siano le condizioni applicabili. La Corte, pur ammettendo che lo Stato possa pretendere la dimostrazione della “dissociazione” dall’ambiente mafioso, considera che questa rottura possa esprimersi con strumenti diversi dalla collaborazione con la giustizia e dall’automatismo legislativo attualmente in vigore.
Gli Stati contraenti godono di un ampio margine di discrezionalità per decidere sulla durata delle pene detentive per determinati reati e il semplice fatto che una pena detentiva a vita possa in pratica essere scontata integralmente non la rende incomprimibile (László Magyar, citata, § 72). Conseguentemente, la possibilità di riesame dell’ergastolo implica la possibilità per il condannato di chiedere la liberazione, non necessariamente di ottenerla, nel caso in cui costituisca ancora un pericolo per la società.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette, se non in modo imperfetto, di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa”.
Danni
Il ricorrente chiede 50.000 euro per il pregiudizio che ritiene di aver subito.
Il Governo contesta questa richiesta: ritiene che il pregiudizio lamentato deriva dal fatto che il ricorrente non ha ancora intrapreso il suo percorso rieducativo e che, in assenza di una prova positiva della rottura di ogni legame con l’organizzazione mafiosa, che si rileva essere una scelta deliberata dell’interessato, quest’ultimo rappresenta sempre una minaccia per la sicurezza pubblica. Aggiunge che, le eventuali sofferenze legate alla condizione del ricorrente, quale detenuto incarcerato a vita, non sono provate da documenti medici che giustificano una tale somma. Infine, a
titolo sussidiario, il Governo chiede che la Corte dichiari che la constatazione della violazione costituisce di per sé una sufficiente equa soddisfazione.
La Corte ritiene che, con riguardo alle circostanze del caso di specie, la constatazione di violazione dell’articolo 3 della Convenzione a cui è giunta costituisce un’equa soddisfazione sufficiente per ogni danno morale che può aver subito il ricorrente (si veda, tra molte altre, Matiošaitis e altre, citata, § 199). Non riconosce pertanto a questo titolo alcuna somma.
Costi e spese
Il ricorrente chiede 17.600 euro, oltre a ogni altro importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per i costi e le spese sostenute davanti alle giurisdizioni interne nella procedura della liberazione condizionale e 42.500 euro, oltre a ogni altro importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per quelle sostenute davanti alla Corte. Chiede che tutte le somme che la Corte dovesse accordare a tale titolo siano direttamente corrisposte ai difensori, in quanto questi non hanno ancora ricevuto le somme indicate.
Il Governo contesta le richieste del ricorrente. Sostiene che sono astratte, non fondate su una pertinente documentazione e senza alcuna relazione con i parametri tariffari nazionali, tanto più che l’interessato si è rivolto a tre avvocati. Critica anche, come deontologicamente ingiustificata, la richiesta di rimborso del parere pro veritate, redatto da uno degli avvocati del ricorrente nell’ambito della procedura nazionale. Infine, osserva che le fatture prodotte dal ricorrente indicano che non ha ancora corrisposto le spese richieste per l’attività degli avvocati.
Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso dei costi e delle spese nella misura in cui siano reali, necessari e di importo ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole riconoscere al ricorrente, per tutte le spese, la somma di 6.000 euro. Queste somme saranno corrisposte sui conti bancari le cui coordinate saranno indicate dai rappresentanti dell’interessato.
Interessi di mora
La Corte ritiene opportuno calcolare il tasso degli interessi di mora sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE
Riunisce nel merito e rigetta, all’unanimità, l’eccezione del Governo riguardante la qualificazione di “vittima” del ricorrente;
Dichiara all’unanimità il ricorso ammissibile;
Decide, sei voti contro uno, che vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione;
Decide, sei voti contro uno, che la constatazione della violazione costituisce di per sé un’equa soddisfazione sufficiente per il danno morale subito dal ricorrente;
Decide, sei voti contro uno,
che lo Stato resistente deve versare al ricorrente, secondo le modalità definite al paragrafo 151 della presente sentenza, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza diventerà definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di 6.000 euro (seimila euro), oltre ad ogni importo dovuto a titolo di imposta, costi e spese;
che, dallo scadere di tale termine e fino al versamento, tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante il periodo, aumentato di tre punti percentuali;
Rigetta, all’unanimità, la richiesta di domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in francese, comunicata per iscritto il 13 giugno 2019, ai sensi dell’articolo 77 § 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Renata Degener Vice Cancelliere Linos-Alexandre Sicilianos Presidente
Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del Regolamento, l’opinione separata del Giudice Wojtyczek.
L.-A.S.
R.D.
OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE WOJTYCZEK
Con mio grande rammarico, non posso sottoscrivere l’opinione della maggioranza, secondo la quale, nel presente caso, la Repubblica italiana ha violato l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
L’articolo 2 della Convenzione impone alle Alte Parti contraenti l’obbligo di adottare misure appropriate per proteggere la vita umana. La Corte ha già ricordato, per esempio nel caso Kayak v. Turchia (n. 60444/08,
§ 53, 10 luglio 2012),
“ (…) che la prima frase dell’articolo 2 § 1 impone agli Stati, non solo di astenersi dal provocare la morte in modo volontario e illegale, ma anche di adottare le misure necessarie alla protezione della vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione (L.C.B. v. Regno Unito, 9 giugno 1998, § 36, Raccolta 1998-III), e che, a tale riguardo, l’obbligo dello Stato implica il dovere primordiale di assicurare il diritto alla vita, ponendo in essere un quadro giuridico e amministrativo idoneo a dissuadere dal commettere delle violazioni contro la persona, che si basi su un meccanismo di prevenzione, repressione e sanzionatorio delle violazioni (Makaratzis v. Grecia [GC], n. 50385/99, § 57, CEDU 2004-XI)”.
Questo obbligo riguarda in particolare la protezione contro il crimine organizzato. Le Alte Parti contraenti hanno l’obbligo di adottare delle misure efficaci per smantellare le organizzazioni criminali che costituiscono una minaccia per la vita delle persone. Per raggiungere questo obiettivo, è cruciale distruggere la solidarietà tra i membri di tali organizzazioni e infrangere la relativa legge del silenzio. A tal fine, le autorità nazionali devono adottare delle misure idonee, tenuto conto delle circostanze specifiche del loro paese.
Gli aspetti essenziali del presente caso possono essere riassunti come segue. Il ricorrente, che è stato condannato all’ergastolo, dirigeva un’organizzazione criminale. Si tratta di una organizzazione che continua a rappresentare una minaccia per la vita e la sicurezza delle persone in Italia. Il ricorrente detiene delle informazioni che potrebbero aiutare le autorità a perseguire altre persone attive all’interno di quest’organizzazione e contribuire così a ridurre considerevolmente la minaccia che pesa sulla vita delle persone e impedire nuovi crimini. Rifiuta tuttavia di comunicare le informazioni rilevanti alle autorità, protestando la sua innocenza e invocando il timore per la sua vita e quella dei membri della sua famiglia. Il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila ha notato in particolare che:
“la cosca era sempre attiva nel territorio di Taurianova, che il ricorrente era il capo riconosciuto di un’organizzazione criminale e che l’osservazione
quotidiana dell’interessato non aveva fatto emergere che questi avesse compiuto una valutazione critica del suo passato criminale” (paragrafo 22 della presente sentenza).
A fronte di questa situazione, aspettarsi che il ricorrente aiuti le autorità italiane a salvare delle vite umane, comunicando loro le informazioni, non sembra essere irragionevole.
La legislazione italiana non priva le persone condannate all’ergastolo, per crimini tra i più pericolosi per la società, della speranza di ottenere un giorno la libertà. Prevede la possibilità di una liberazione condizionale, ma subordina questa alla condizione della collaborazione con la giustizia. E si deve notare, peraltro, che, in pratica, le persone che non sono state considerate come facenti parte del vertice dell’organizzazione criminale non sono sottoposte a questa condizione e beneficiano del regime ordinario di applicazione delle pene.
La legislazione italiana non è rigida; è stata oggetto di modifiche e è stata sottoposta diverse volte al controllo di costituzionalità. È stata dibattuta e analizzata in ambito parlamentare e giurisprudenziale (si faccia la comparazione con gli standard enunciati nella sentenza Animal Defenders International v. Regno Unito ([GC], n. 48876/08, §§ 113-116, CEDU 2013 (estratti)); noto, tra parentesi, che la Corte sembra aver dimenticato questi standards nella propria giurisprudenza.
Noto anche che le autorità italiane hanno adottato una legislazione che permette ai criminali implicati nella criminalità organizzata di ottenere degli sconti di pena in caso di collaborazione con le autorità inquirenti in fase istruttoria. Evidenzio che, nel corso degli anni, migliaia di criminali hanno collaborato con le autorità e hanno beneficiato di tali misure. La minaccia che il crimine organizzato fa pesare sui “pentiti” non raggiunge un livello capace di paralizzare l’applicazione di queste misure. Il ricorrente stesso è stato condannato grazie alla collaborazione con la giustizia di due persone “pentite”.
È evidente che la situazione di un imputato e di un condannato all’ergastolo sono diverse. Il primo, collaborando con la giustizia, può ottenere un vantaggio considerevole (una riduzione di pena sostanziale), mentre il secondo non può ottenere che un vantaggio lontano e incerto (la possibilità di chiedere un giorno la liberazione condizionale). A seconda del caso, il bilanciamento dei vantaggi e dei rischi si pone in modo differente. Tuttavia, la minaccia che il crimine organizzato fa pesare sulle persone che infrangono la legge del silenzio non sembra essere un ostacolo insormontabile nell’applicazione di diverse misure che mirano alla collaborazione dei criminali con le autorità inquirenti.
I terzi intervenienti sostengono che le misure censurate non sono efficaci e non apportano i risultati attesi, poiché, in pratica, le persone interessate rifiutano di collaborare con la giustizia. Rilevo che, in questi ambiti, in materia di politica criminale, gli Stati godono di un certo margine di
discrezionalità. Se il controllo di proporzionalità delle violazioni ai diritti costituisce una sorta di controllo di razionalità di queste ingerenze, la Corte non è competente per valutare la razionalità in quanto tale delle politiche in materia penale degli Stati parti della Convenzione. Come sottolineato dalla giurisprudenza, “la scelta da parte di uno Stato di un sistema di giustizia penale, ivi compreso il riesame della pena e le modalità di liberazione, sfugge in linea di principio al controllo esercitato dalla Corte”(Harakchiev e Tolumov v. Bulgaria, nn. 15018/11 e 61199/12, § 250, CEDU 2014 (estratti)).
La maggioranza esprime il suo punto di vista al paragrafo 118 (grassetto aggiunto):
“La Corte ne deduce che la mancanza di collaborazione potrebbe essere non sempre legata ad una scelta libera e volontaria, né giustificata unicamente dalla persistenza dell’adesione ai “valori criminali” e dal mantenimento di legami con il gruppo di appartenenza. Ciò è stato peraltro riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 306 dell’11 giugno 1993, quando ha affermato che l’assenza di collaborazione non indica necessariamente il mantenimento dei collegamenti con l’organizzazione mafiosa (…)”.
Se capisco correttamente i miei colleghi, essi ritengono che le condizioni della liberazione di un detenuto condannato all’ergastolo devono essere tali da dipendere sempre, per loro natura, dalla libera scelta del detenuto. Dal loro punto di vista, l’assenza di condizioni deve sempre essere legata a una scelta libera e volontaria. Questa argomentazione è sbalorditiva. L’approccio della maggioranza valuta la legislazione nazionale in abstracto e la mette in discussione nel suo insieme, per il solo fatto che, in certi casi, può produrre degli effetti problematici. A mio avviso, la questione rilevante, nel contesto dell’esame di un ricorso individuale da parte della Corte, non è quella di sapere se la scelta in questione è sempre libera e volontaria, ma piuttosto di determinare se la scelta concreta del detenuto interessato è libera e volontaria.
La Corte ha sostenuto questo ragionamento nella sentenza Hutchinson v. Regno Unito ([GC], n. 57592/08, § 42, 17 gennaio 2017):
“ (...) per essere compatibile con l’articolo 3, tale pena deve essere comprimibile de jure e de facto, vale a dire deve offrire una prospettiva di rilascio e una possibilità di riesame. Tale riesame deve, in particolare, fondarsi sulla valutazione delle motivazioni legittime di ordine penologico, che giustifichino o meno il mantenimento in detenzione del detenuto. Gli imperativi retributivi, dissuasivi, di protezione del pubblico e di reinserimento rientrano tra questi motivi”.
Questo approccio conferma che la pena è uno strumento legislativo multidimensionale. La risocializzazione del criminale è un obiettivo fondamentale, ma non è il solo obiettivo. La pena ha anche una funzione
retributiva: offre un sentimento di giustizia, non solo alla società, ma anche, e soprattutto, alla vittima. La pena ha anche una funzione dissuasiva, riguardo agli altri potenziali criminali. Può anche mirare ad altri obiettivi e, in particolare, può essere regolamentata in modo da ridurre la criminalità, aiutando le autorità a smantellare le organizzazioni criminali.
Conviene ricordare qui che il diritto internazionale dei diritti umani insiste molto fortemente sulla funzione dissuasiva della pena. Numerose sentenze della Corte dichiarano che certe pene sono manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del reato. La pena è ritenuta sproporzionata riguardo alla natura del reato commesso, senza che la Corte cerchi di stabilire le esigenze di risocializzazione nel caso in esame. A titolo d’esempio, si possono qui citare le seguenti considerazioni:
“una tale sanzione non sembra considerabile idonea a dissuadere l’autore dei fatti o altri agenti dello Stato a commettere reati simili né essere percepita come giusta per le vittime” (Sidiropoulos e Papakostas
v. Grecia, n. 33349/10, § 95, 25 gennaio 2018 – grassetto aggiunto)”;
“il sistema penale e disciplinare, così come applicato nel caso di specie, non è stato rigoroso e non poteva generare alcuna forza dissuasiva, capace di assicurare la prevenzione efficace di atti illegali come quelli denunciati dalla ricorrente” (Zeynep Özcan v. Turchia, n. 45906/99, § 45, 20 febbraio 2007 – grassetto aggiunto)”.
È compito del legislatore nazionale porre in essere la politica penale, stabilendo le pene ritenute idonee a seconda di differenti delitti e reati, definendo gli scopi concreti della pena, oltre che la loro priorità.
La motivazione della presente sentenza lascia intendere che la risocializzazione diventa il solo scopo legittimo della pena. Non sono d’accordo con questo approccio. Conduce a ribaltare tacitamente su questo punto la giurisprudenza Hutchinson. In più, se la risocializzazione deve essere il solo scopo della pena, che cosa si dovrebbe fare delle persone che hanno commesso dei reati e che sono state perseguite molti anni dopo, quando nel frattempo si sono pentite del loro crimine e hanno completamente cambiato personalità?
La strategia argomentativa della maggioranza si basa sull’idea che il sistema si basi su una presunzione “assoluta” di pericolosità sociale del detenuto che rifiuti di collaborare con le autorità. Il termine “presunzione assoluta” riveste in generale una connotazione negativa in materia penale. Fa pensare di primo acchito che una persona potrebbe essere vittima di una situazione ingiusta, dovuta all’impossibilità di provare il contrario.
Constato in questo ambito che la nozione stessa di “presunzione assoluta” è giustamente criticata dalla teoria del diritto, la quale indica che le presunzioni relative e le “presunzioni assolute” costituiscono due categorie giuridiche completamente distinte. Una “presunzione assoluta” non è una presunzione che guida i ragionamenti per giustificare delle proposizioni fattuali a partire da altre proposizioni fattuali, ma,
semplicemente, una regola di diritto, che attribuisce certe conseguenze giuridiche a certe circostanze di fatto (su questo tema, si veda, per esempio
T. Gizbert-Studnicki, “Znaczenie terminu ,,domniemanie prawne’’ w języku prawnym i prawniczym”, [Il significato del termine “presunzione legale” nel linguaggio legislativo e giuridico], Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, vol. 36, 1974, n. 1). Si possono presentare come presunzioni assolute tutte le regole di diritto che prevedono determinate conseguenze giuridiche, a fronte di determinate circostanze di fatto; tuttavia, un tale approccio non apporta alcun valore aggiunto alla comprensione del diritto.
Se il ricorrente nel presente caso è tuttora detenuto, non è perché è ritenuto socialmente pericoloso, ma perché è stato condannato ad una certa pena, che soddisfa nel loro complesso le funzioni della pena. È detenuto, in particolare, perché la sua detenzione è necessaria per dare un sentimento di giustizia alle famiglie delle vittime e alla società italiana in generale, nonché per dissuadere altri potenziali criminali dal commettere reati simili. Motivi legittimi di ordine penologico giustificano quindi il mantenimento in detenzione dell’interessato.
Nella sentenza Hutchinson, citata, la Corte ha stabilito il principio seguente:
“Un detenuto condannato all’ergastolo incomprimibile ha quindi il diritto di sapere, sin dall’inizio della pena, quello che deve fare perché sia possibile la sua liberazione e quali sono le condizioni applicabili” (paragrafo 44).
A mio avviso, la legge italiana è sufficientemente chiara e può permettere al detenuto di gestire la sua condotta, rispettando così il principio della sicurezza giuridica.
Al paragrafo 133 della presente sentenza, la maggioranza esprime il seguente punto di vista:
“Per quanto riguarda infine le affermazioni del Governo, secondo le quali il sistema interno prevede due altri rimedi per ottenere il riesame della pena, vale a dire la domanda di grazia presidenziale e la domanda di sospensione della pena per motivi di salute (paragrafo 81, qui sopra), la Corte ricorda la sua giurisprudenza rilevante per il caso di specie, secondo la quale la possibilità per un detenuto che sconti la pena dell’ergastolo di beneficiare della grazia o della rimessione in libertà per motivazioni umanitarie, legate ad un problematico stato di salute, a invalidità fisica o all’età avanzata, non corrisponde al significato dell’espressione “prospettiva di rilascio”, utilizzata a partire dalla sentenza Kafkaris (citata, § 127; si veda anche Öcalan, citata, § 203, e László Magyar v. Ungheria, n.73593/10,
§§ 57 e 58, 20 maggio 2014)”.
Evidenzio che, nella sentenza Iorgov v. Bulgaria n. 2 (n. 36295/02, 2 settembre 2010) e quindi nella sentenza Harakchiev e Tolumov, citata, la Corte ha esposto il metodo da tenere in considerazione, affinché il diritto di domandare grazia permetta di considerare comprimibile una determinata pena. In questi due casi, la Corte ha analizzato nel dettaglio il quadro
normativo e la prassi del diritto di domandare la grazia. Al paragrafo 262 della sentenza Harakchiev e Tolumov ha dichiarato che “[l]’assenza di esempi che tendano a suggerire che una persona che sconta una pena all’ergastolo incomprimibile [può], a certe condizioni ben definite, ottenere una modificazione della pena” non è in ogni caso sufficiente per dimostrare che la pena dell’ergastolo è de facto incomprimibile.
Noto che la maggioranza, nel caso di specie, ha rifiutato di seguire questa impostazione. L’argomentazione secondo cui il Governo “non ha fornito alcun esempio di un condannato alla pena dell’ergastolo di questo tipo che abbia ottenuto una modificazione della pena in forza della grazia presidenziale” (paragrafo 135 della presente sentenza) non può essere decisiva. È possibile che non vi sia alcun detenuto condannato all’ergastolo che soddisfi le condizioni in merito alla risocializzazione, non giustificando in questo modo la concessione della grazia presidenziale.
Come già detto, la presente sentenza ribalta tacitamente alcuni principi enunciati nella sentenza Hutchinson. È difficile peraltro conciliare questa sentenza con quelle della Corte che mettono l’accento sull’effetto dissuasivo della pena e con quelle che riguardano la grazia presidenziale. Di conseguenza, il risultato è una situazione nella quale la giurisprudenza della Corte sulla pena dell’ergastolo diventa meno comprensibile e sempre più imprevedibile.
LINK AGLI INTERVENTI DI TERZI:
Per L'Altro Diritto
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/3618-amicuscuriaeviolaf.pdf
Per i Professori - Università di Milano
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1144-amicus-curiae-viola-v-itaita.pdf
Per l'European prison litgation network
https://www.prisonlitigation.org/?lang=en)