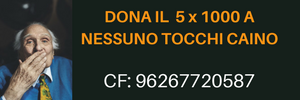07 Febbraio 2026 :
Adolfo Ceretti su l’Unità del 7 febbraio 2026
Inizio con la lettura di una dedica che un’amica ha scritto sulla sua tesi: “Ad Adolfo, per aver condiviso un capodanno in terra di guerra parlando di pace. Con affetto Arianna Fioravanti.”
Una dedica bellissima. Al suo interno ritrovo lo spirito di tutto quello che cerchiamo di fare da anni. Da trent’anni mi occupo di giustizia riparativa, nel micro e nel macro: ho lavorato in qualità di studioso e di practitioner in Sudafrica, in Colombia, e molto, naturalmente, in Italia. Ho presieduto i lavori che hanno portato alla legge inserita nella riforma Cartabia (decreto legislativo 150/2022).
Vorrei riportare alcune parole che aiutino a entrare nella poetica della giustizia riparativa.
Il filosofo Paul Ricoeur scriveva che “il tempo diviene tempo umano nella misura in cui è articolato in modo narrativo”. E lo psichiatra Eugenio Borgna aggiungeva: “Non c’è comunicazione autentica se non quando le parole creano ponti fra la soggettività di chi parla e quella di chi ascolta, quando i loro tempi interiori si corrispondono.” Così, comunicare significa uscire da sé e immedesimarsi nella vita dell’altro, nei suoi pensieri e nelle sue azioni. Le parole cambiano significato solo se accompagnate dal linguaggio del corpo vivente: dal sorriso, dalle lacrime, dagli sguardi, dai gesti, e anche dal silenzio.
Riprendendo Emmanuel Lévinas possiamo sostenere che chi si occupa di giustizia riparativa non si occupa di questioni ontologiche, ma del vivente, che nel nostro caso significa che le relazioni nascono dall’ascolto del dicibile e dell’indicibile e dall’ombra che il crimine – agito o subito – lascia nell’esistenza delle persone coinvolte.
Il poeta americano Robert Frost scriveva a sua volta nel 1913: “Io, fra gli scrittori di lingua inglese, mi sono proposto di ricavare musica da ciò che chiamo il suono del senso.” Ecco! Chi lavora nella giustizia riparativa è chiamato a far emergere in chi ha attraversato un conflitto distruttivo, proprio quel suono del senso. Vittime e autori del reato sono invitati a ritrovarlo insieme: è quel suono che li conduce ai “roveti ardenti” delle emozioni, là dove il dolore e la colpa prendono voce e diventano condivisibili.
Chi pratica giustizia riparativa lavora sulla biografia intima delle persone, sulla loro narrazione. A differenza di un processo giudiziario, non c’è un giudizio, ma ascolto. È un incrocio di parole ed emozioni, ma soprattutto di pensieri difficili – quei pensieri che non si riescono a pensare da soli – che avviene in un incontro che, a differenza del processo, predilige l’orizzontalità dello sguardo che – ancora con Lévinas – è il punto di svolta della responsabilità verso l’altro, verso il gesto compiuto o subito.
In questi spazi le vicende concrete delle persone diventano la materia viva del lavoro. C’è la necessità di prendere la parola per dirsi, per dire ciò che è accaduto nel proprio mondo interiore dopo un evento che ha ridefinito la vita e spesso i circuiti neuronali. Alcuni gesti, infatti, umiliano e sotterrano la dignità dell’altro, ma anche quella di chi li compie. Anche chi agisce violenza mortifica se stesso. I programmi di giustizia riparativa mirano a ricreare la possibilità di uno sguardo, non a ottenere perdono, ma a ricomporre i frammenti di relazione.
Riguardo allo stato dell’arte della giustizia riparativa in Italia, possiamo affermare che il governo attuale, pur non avendola posta fra le sue priorità, non ha tradito le aspettative della Riforma Cartabia. Per attuare gli articoli 42-67 del decreto è stata necessaria una complessa riforma amministrativa. Oggi l’Italia è il primo e unico Paese al mondo ad avere una legge organica che prevede la giustizia riparativa in ogni fase del processo, incluso il periodo dell’esecuzione. È un risultato di cui essere orgogliosi. Detto altrimenti, in ogni stadio del procedimento c’è ora la possibilità di uscire dalla logica del giudizio per restituire ai protagonisti – vittima e autore – la dimensione relazionale e
umana del conflitto. In ogni Corte d’Appello è stato istituito almeno un Centro di giustizia riparativa, molti già operativi.
In numerose università sono partiti i corsi per mediatori e formatori: a Milano, grazie al protocollo con la magistratura, abbiamo continuato a lavorare anche nei momenti più difficili.
Chiudo ricordando il progetto finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) presso l’istituto minorile Beccaria. Non dimentichiamo che lì, in passato, sono stati violati i diritti umani e inflitte ferite profonde a molti ragazzi, nell’indifferenza di chi non ha visto o ha finto di non vedere. Credo che non saranno le punizioni a restituire dignità al Beccaria – che per decenni è stato un simbolo della giustizia minorile – ma il lavoro condiviso tra operatori, fondato sullo sguardo, sul racconto, sulla parola. Solo così, con la forza del dialogo e della responsabilità reciproca, potremo riportare luce nei luoghi dell’ombra e continuare a costruire una giustizia che ripara, che ascolta, che restituisce umanità.