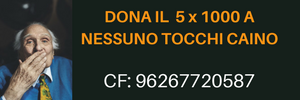10 Gennaio 2026 :
Tullio Padovani* su l’Unità dell’8 gennaio 2026
Il carcere, che dovrebbe garantire la legalità, sopravvive solo assicurando legalmente la sua illegalità. È un paradosso solo apparente: è la nostra realtà. Il Presidente d’Onore di Nessuno tocchi Caino è intervenuto al Congresso del Carcere Beccaria con un discorso straordinario, illuminante nei contenuti, appassionato nei toni.
Siamo a un nuovo congresso di Nessuno tocchi Caino, ma i problemi sono sempre gli stessi, e purtroppo sempre più gravi. Purtroppo, sempre più gravi. All’orizzonte non si vede una luce di speranza: nonostante le voci si facciano ormai corali nel richiedere interventi decisi, radicali, per raggiungere un minimo di decenza nella condizione carceraria, il silenzio in cui cadono queste grida, richiami e appelli è pressoché totale. Rimaniamo senza parole, ci chiediamo che altro debba accadere perché qualcuno intervenga. E allora, in momenti come questi, siamo indotti a riflettere su come tutto ciò sia possibile. Perché, anche guardando da lontano – non solo da vicino –, il primo impulso è chiedersi come si sia potuti giungere a un tale stato di degrado. Il carcere è, di per sé, un’istituzione negativa per ragioni che conosciamo e sulle quali non voglio tornare; ma un tale grado di negatività perversa è difficile da immaginare.
Nel 2025, abbiamo celebrato – o preteso di celebrare – il cinquantesimo anniversario della grande riforma penitenziaria del 1975. Mi dispiace dirlo, ora che sono vecchio: all’epoca ero giovane, e non lo sapevo, ma non mi ha incantato allora e, francamente, mi incanta ancor meno oggi. Ora si è visto di che pasta era fatta quella riforma del ’75: una pessima riforma. Pessima. Una delle tante riforme italiane nutrite di vacua retorica. Una riforma rimessa alla discrezionalità di un potere arbitrario, che ne ha riempito i contenuti nei modi che oggi vediamo. Perché la situazione attuale è anche figlia di quella riforma – non solo di quella, per carità, ma certo anche di quell’impostazione –, e soprattutto dell’ostinazione nel negare l’unico rimedio che fino al 1992 aveva accompagnato i problemi del carcere, problemi che sono storicamente sempre gli stessi: il ricorso sistematico all’amnistia e all’indulto. Sono strumenti con cui si è gestito il carcere durante la monarchia, l’Italia liberale, il fascismo, e nell’età repubblicana fino alla dissennata riforma costituzionale che conosciamo. Ma certo, la riforma del 1975 ci ha messo del suo.
Salutata come segno di rinnovamento radicale rispetto al Codice Rocco, in realtà aveva solo le parvenze del rinnovamento, non la sostanza. Si diceva: è una legge, non un regolamento, quindi sancisce solennemente, con una forza che un regolamento non ha, i principi ispirati all’articolo 27 della Costituzione – la finalità rieducativa della pena e la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, quei diritti che non vengono mai meno, nemmeno nello stato di privazione della libertà. La riforma introdusse le misure alternative alla detenzione – forse l’unico capitolo positivo, sebbene tardivo. Fiore all’occhiello, si disse; ma altrove in Europa quelle misure esistevano da più di un secolo. Noi arrivavamo con cent’anni di ritardo: un fiore all’occhiello appassito. Quella riforma, dietro le parole solenni, introduceva un sistema destinato a rimanere in gran parte lettera morta. Le affermazioni di principio erano vacue, puramente retoriche, senza strumenti per garantirne l’effettività. Consegnava così all’amministrazione penitenziaria una discrezionalità persino maggiore di quella che esisteva con il regolamento Rocco – un regolamento feroce, per carità, ma almeno “legalitario”. Con la legge del ’75 tutto è finito nelle mani dell’amministrazione: tutte le scelte, anche quelle che prima richiedevano un provvedimento del giudice di sorveglianza. E mentre la legge si vantava di non occuparsi dell’“ordine e disciplina” – temi centrali in un’istituzione totale – lasciava aperte le porte all’arbitrio.
Di lì a pochi anni nacque il “carcere speciale”, attraverso meccanismi che, a raccontarli oggi, sembrano tratti da 1984 di Orwell. Il tessuto normativo della legge del ’75 era di plastilina: se ne poteva fare tutto. E tutto se n’è fatto. Dietro le grandi parole e le formule edificanti, si è perpetuata una politica abituata a dipingere un mondo ideale – quello di Alice nel Paese delle Meraviglie – davanti a una realtà che tutti conoscono. È un’abitudine che non si è mai perduta. Negli ultimi tempi, per esempio, ho letto quella direttiva intitolata “Misure di coordinamento tra le aree per l’efficienza operativa e la prevenzione di eventi critici negli istituti penitenziari”. Basta sfogliarla per restare tra l’edificante e lo sconcertante. Si parla di “accoglienza del detenuto”, di “clima di convivenza”, di “informative complete e comprensibili sui diritti fondamentali” … Sembra la reception di un grande hotel più che un ingresso in carcere. “Garantire una sistemazione alloggiativa appropriata”, “attivare tempestivamente le misure organizzative necessarie” … il linguaggio è quello della brochure di un resort a cinque stelle. Eppure, l’autore della direttiva, c’è da chiedersi, un carcere lo ha mai visto? Lo conosce? Sa come funziona davvero? Perché, se davvero funzionasse così, saremmo nel paradiso. Ma invece sappiamo tutti qual è la realtà. Non voglio infierire, ma un documento del genere si attira addosso la critica sarcastica. E tuttavia non si può neppure imputare troppo a chi lo redige: il meccanismo fa parte della frammentazione e dell’eliminazione delle responsabilità che caratterizzano l’intera gestione penitenziaria.
È un processo tipico delle organizzazioni pubbliche impastate di illegalità. Ognuno ha la coscienza a posto, anche quando nulla è a posto con ciò che la legge prescrive. E così, nell’ambito dell’esecuzione della pena – che dovrebbe essere la massima espressione della legalità – domina, paradossalmente, l’illegalità. Quella che era nata sotto il segno della speranza si è trasformata in una mistificazione continua. Le istituzioni penitenziarie sono governate dalla discrezionalità amministrativa, tramite una proliferazione di norme secondarie e circolari che determinano, nel migliore dei casi, un’evasione dalla legalità, e nel peggiore, la sua violazione sistematica. Sovraffollamento, carenze di cibo e vestiario, mancanza d’aria, di salute, di spazio, ambienti malsani infestati da parassiti… Si potrebbe continuare per ore a elencare le tragedie delle nostre carceri. Poche eccezioni non cambiano un quadro complessivo di degrado tragico.
E allora, com’è possibile che un’istituzione che deve rieducare alla legalità agisca essa stessa nell’illegalità più totale? Il primo strumento di rieducazione dovrebbe essere l’esempio: mostrare che lo Stato rispetta la legge persino con chi l’ha violata. Se invece l’istituzione che incarna la legge ne viola ogni principio, come può pretendere di educare, o anche solo di esistere con dignità? E com’è possibile che nessuno faccia cessare questa situazione di illegalità? Se in un supermercato saccheggi la merce, ti fermano. Se vandalizzi per strada, ti fermano. Ma qui no. Qui l’illegalità continua indisturbata. Perché? Perché nessuno ha il potere di farla cessare. Non esiste, in concreto, un’autorità che possa dire: “Questo carcere si chiude subito”. Eppure, in altri contesti – una casa di riposo abusiva, una struttura fatiscente – si interviene immediatamente. Ma per le carceri no. E non perché se ne siano dimenticati, ma perché non deve esserci nessuno con quel potere: se esistesse, il sistema crollerebbe, perché è tutto impregnato di illegalità. Basterebbe uno sguardo che brucia, e nulla sopravviverebbe a quello sguardo.
Il carcere, che dovrebbe garantire la legalità, sopravvive solo assicurando legalmente la sua illegalità. È un paradosso solo apparente: è la nostra realtà. Un sistema fondato sulla frantumazione delle responsabilità, sulla parcellizzazione delle competenze, sull’irraggiungibilità dei vertici e sulla moltiplicazione della vigilanza senza effetti. Nessuno risponde. Nessuno decide. Tutti fanno la propria parte burocratica, nell’ingranaggio dell’illegalità legalizzata. E così, un’istituzione pubblica nata per difendere la legge vive – e prospera – nella sua negazione.
Deve durare così. Io ci metterei un punto di domanda. Quel punto di domanda deve essere l’inizio di un cammino diverso. Occorre studiare meccanismi nuovi, che incrinino questa irresponsabilità diffusa. Perché altrimenti che facciamo? Continuiamo con appelli inascoltati, col parlare di carceri nuove “comode”, mentre il sangue di questa tragedia continua a scorrere. Se non fosse una tragedia fatta di sangue, sarebbe una farsa da ridere. Ma sangue è, e resta – una tragedia senza fine.
*Presidente d’onore Nessuno tocchi Caino