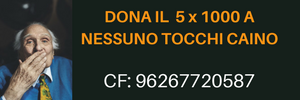12 Gennaio 2017 :
PREFAZIONE
del Prof. Umberto Veronesi
Presidente di Science for Peace
Non ho mai creduto in una ricerca scientifica che non si occupi delle ricadute sociali delle sue scoperte; anzi, ho sempre sostenuto che la scienza – nel mio caso scienza medica, ma lo stesso vale per la fisica, la chimica, e così via – quando conquista un nuovo sapere sull’uomo e la sua natura, abbia il dovere di diffonderlo, condividerlo e offrirlo al dibattito pubblico, perché la società lo applichi in modo consapevole alle varie discipline. Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha conseguito nuove conoscenze sulla natura dell’uomo. Prima di tutto ha dimostrato che la violenza non fa parte della sua biologia. Lo provano le indagini genetiche, antropologiche e biologiche. Il messaggio del nostro DNA è la perpetuazione della specie: procreare, educare, abitare, fare sapere, costruire ponti e legami che rendono più sicura la vita. In sintesi il nostro genoma “pensa” l’essere, non la distruzione. Uccidere, esercitare violenza e fare guerre, rappresenta un’infrazione al messaggio genetico, che ci spinge invece verso relazioni costruttive. Gli studi più recenti in neurologia hanno dimostrato inoltre che il nostro sistema di neuroni è plastico e si rinnova, perché il cervello è dotato di cellule staminali proprie in grado di generare nuove cellule. Questo dimostra scientificamente che per ogni uomo esiste, nel corso di tutta la sua vita, la possibilità di cambiare ed evolversi. Infine, molti studi sostengono l’ipotesi ambientale della violenza: chi agisce con aggressività è stato esposto a fattori esterni sfavorevoli (abusi subiti, disagio sociale o psichico) che lo spingono all’atto violento.
La scienza si schiera quindi contro tutte le forme di violenza, soprattutto se istituzionalizzate. Prima fra tutte la pena di morte, perché è un omicidio di Stato, che inevitabilmente genera una distorsione. Se lo Stato uccide, lo posso fare anch’io: lo Stato non può uccidere in nome dei cittadini rendendo omicida tutti quanti rappresenta. La pena capitale è dunque una legittimazione dell’assassinio e, infatti, il tasso di omicidi nei Paesi civilmente avanzati che ancora la mantengono, come gli Stati Uniti, è più alto che in quelli che l’hanno abolita. Tuttavia esiste anche un’altra forma di pena capitale e si chiama “ergastolo ostativo”, cioè senza possibilità di liberazione condizionale, che è una forma di pena di morte o una pena fino alla morte, perché una persona condannata a morire in carcere entra in cella per affrontare un’agonia lenta e spietata, perché sa di non poter mai più ritornare alla vita sociale. Togliere a un essere umano la speranza di un futuro è come togliere la vita. Anzi, come già diceva Cesare Beccaria, è una pena di morte più crudele perché rende lungo il processo del morire. Tanto crudele, da far scrivere a Carmelo Musumeci, un “ergastolano ostativo” con cui intrattengo un carteggio da molto tempo, “Fatemi la grazia di morire”.
L'Italia è rimasta uno degli ultimi Paesi ad applicare l'ergastolo ostativo, che fu introdotto come misura emergenziale nei primi anni '90, con l’obiettivo di potenziare la lotta alla mafia, e non si può certo affermare che fu una misura efficace. Per questo il movimento Science for Peace, che ho creato nell’ambito della Fondazione che porta il mio nome, si è affiancato all’impegno di quanti in Italia si adoperano per l’abolizione dell’ergastolo.
Le motivazioni vanno ben di là della questione giuridico-legislativa: sono ragioni morali, etiche, culturali, oltre che scientifiche, come abbiamo visto. Noi crediamo nel principio di una giustizia tesa al recupero e alla rieducazione della persona, che eviti trattamenti contrari al senso di umanità e dignità della persona, come recita la nostra Costituzione all’articolo 27. Una giustizia che condanna “per sempre”, invece, è soltanto vendetta, perché esclude la possibilità di un ravvedimento, e rappresenta un concetto antico e più vicino alla barbarie che alla civiltà. Per i greci Nemesi rappresentava l’aspetto tragico della Dike, la divinità della Giustizia, che nella sua forma etica è invece restituzione, e nella espressione della coscienza personale è Metànoia, la stessa che Giovanni Battista predicava sulle rive del Giordano: il Ravvedimento, appunto.
Un esempio straordinario di evoluzione in senso civile del concetto di Giustizia viene, inaspettatamente, dal Ruanda. Nel 1994 il Paese fu devastato da una selvaggia lotta fratricida fra tribù che causò lo sterminio di un quinto della popolazione Tutsi da parte degli Hutu. Il genocidio fu di una violenza inaudita: i Tutsi furono massacrati, violentati, bruciati vivi, mutilati. Per ricostruire un Ruanda senza più identità, se non quella del sangue e della paura, la via scelta dal Paese fu quella di una giustizia basata sul perdono e la riconciliazione. Innanzitutto, fu abolita la pena di morte, quindi venne applicato il sistema di giustizia “Gacaca”, che sta a indicare i processi pubblici celebrati nei luoghi aperti con la partecipazione della gente, un po’ come nella Agorà ateniese. Ebbene, dopo soli dieci anni di attività, le corti Gacaca avevano già processato tutti i criminali Hutu, giudicando circa 2 milioni di casi, di cui la maggioranza assoluta è stata assolta o condannata a pene alternative al carcere. Migliaia di questi casi son stati risolti con il principio della riconciliazione che si è diffuso e consolidato nella società tanto da dar vita ad associazioni di sopravvissuti e autori del genocidio che insieme si dedicano alla ricostruzione.
La vendetta, invece, è una giustizia che punisce senza capire le cause profonde di un crimine, e così facendo perde anche la sua efficacia. Molti giuristi sostengono che la criminalità gioisce di fronte a una condanna di ergastolo, perché sa che la persona non verrà recuperata e non potrà dunque tradire l’organizzazione criminale. Sappiamo, tuttavia, che scardinare dall’opinione pubblica il principio della vendetta richiede un grande sforzo collettivo. Non è questione giuridica o politica, ma prima di tutto culturale. Sappiamo però anche che un’evoluzione culturale è possibile, perché è già avvenuta, non solo in Ruanda, un Paese che può sembrare lontano dalla nostra realtà, ma in molti Paesi a noi vicini, come la Spagna e il Portogallo, ad esempio, oltre che in diversi Stati dell’America latina come Brasile, Colombia, Venezuela.
Il modello per noi dovrebbe essere la Norvegia, dove la pena massima che una Corte di giustizia può applicare arriva al massimo a ventuno anni di reclusione, il 60% delle pene dura meno di tre mesi e il 90% non arriva ai dodici mesi. Dati alla mano, il sistema sembra funzionare: secondo alcuni studi, nei due anni successivi al rilascio, torna a delinquere solo il 20 per cento dei detenuti, uno dei tassi più bassi del mondo.
Il principio su cui si basa il sistema penale norvegese è che il carcere è concepito come una scuola: il detenuto vive in condizioni di assoluta dignità e da subito entra a far parte di un programma educativo/riabilitativo che lo accompagna fino alla fine della sua pena. Voglio a questo proposito citare un pensiero del filosofo Giuseppe Ferraro che condivido pienamente: “La civiltà di un Paese si misura dalle carceri e dalle scuole: quando le scuole cesseranno di essere carceri e le carceri inizieranno a essere delle scuole, potremo dire di vivere in un Paese civile”.