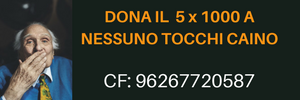24 Dicembre 2013 :
Ripensare la pena per riformare il carcere
La mole e lo spessore delle idee, degli spunti e dei ragionamenti che hanno riempito le due giornate del Quinto congresso di Nessuno tocchi Caino sono stati così densi e significativi da non avere nulla da invidiare a una delle migliori aule universitarie, con il valore aggiunto di essere fecondati e resi pregnanti dalle testimonianze di Carmelo, Bruno, Lorenzo, Biagio, Giovanni.
Scusate se inizio con dei ringraziamenti, che è spesso una consuetudine formale che può risultare fastidiosa, ma mi sembra doveroso e mi fa davvero piacere ringraziare pubblicamente Nessuno tocchi Caino e Sergio D’Elia, di cui mi onoro di essere amico da 35 anni, per il prezioso impegno che porta avanti da vent’anni con passione e competenza, assieme a Elisabetta e tanti altri compagni.
Un impegno, per dirla con le parole che utilizza Marco Pannella nella sua introduzione al libro sul 41 bis, la tortura democratica, che ha portato “Nessuno tocchi Caino” «a essere e operare come la più importante e significativa delle forze impegnate nel mondo a mutare e permutare la pena di morte nel mondo in civile recupero del diritto della e alla vita».
Si tratta di un impegno già straordinario quanto a risultati. Guardando alle voci del bilancio economico e alla esiguità dei contributi pubblici che l’associazione riceve, viene da pensare a quante conquiste in più, a quali altri importanti obiettivi si potrebbero ottenere se il sostegno pubblico non fosse limitato agli apprezzabili ma episodici contributi di singoli enti locali ma vi fosse un adeguato sostegno da parte del governo e delle istituzioni.
“Civile recupero del diritto della e alla vita” e lotta alla pena capitale non sono temi e battaglie che riguardano solo luoghi lontani e paesi distanti.
La pena di morte e la morte per pena, come sottolinea il titolo di questo Congresso, sono due facce della stessa medaglia, rispondono alla medesima logica di annichilimento della persona e del suo diritto a essere considerata e trattata come tale, quale che sia la sua responsabilità.
È dunque tanto più significativo che il congresso di Nessuno tocchi Caino si tenga per la seconda volta consecutiva in questo luogo: il carcere.
Un luogo di cui si è tornati a parlare, grazie alle ostinate e generose iniziative di Marco Pannella, di Rita e dei Radicali e al messaggio alle Camere del Capo dello Stato, ma rispetto al quale poco o nulla si riesce a modificare, tanto sedimentati e incancreniti sono i problemi e tanto inerte e demagogico è l’atteggiamento di governo e forze politiche. Vedremo quel che produrrà il recente decreto del ministro Cancellieri, che indubbiamente è positivo (braccialetto elettronico a parte, una misura che ha già sprecato circa 80 milioni di euro per la sola sperimentazione e che servirà solo a garantire business, non certo sicurezza) ma anche insufficiente e all’insegna della prudenza.
Quel che è certo è che una riforma radicale del carcere non è più procrastinabile:
per ragioni umanitarie, anzitutto. Ma anche per ragioni economiche: con la crisi, l’incarcerazione di massa che ha avuto luogo come tendenza negli ultimi trent’anni non è più sostenibile, come mostrano i dati degli Stati Uniti, che sono stati il capofila di quel processo, e come mostrano anche le statistiche italiane, che negli ultimi tre anni hanno visto il numero dei reclusi fermarsi attorno a quota 64-65.000.
Il recente decreto e il rallentamento nelle incarcerazioni, tuttavia, non sono indizi di reale inversione, quand’invece, come sappiamo e come ci ha intimato di fare l’Europa, la necessità è quella di un forte decremento nelle presenze.
A tutt’oggi – seconda solo alla Grecia – l’Italia detiene il record del sovraffollamento con 134,4 detenuti ogni 100 posti, mentre la media europea è di 99,5. Un dato peraltro sottostimano, poiché, come documentato da Antigone e riconosciuto dallo stesso ministro Guardasigilli, le cifre effettive della capienza sono assai più basse: 37.000 posti a fronte degli oltre 47.000 dichiarati nelle statistiche ufficiali, il che porta a un tasso reale del 173%.
I numeri, tuttavia, non vivono di moto proprio: sono l’esito – tangibile e drammatico – di quelle che sono le politiche penali e le culture generali.
· Per riformare il carcere, dunque, occorre prima di tutto riaprire una riflessione sulla pena, le sue forme e le sue funzioni. I suoi limiti e i suoi costi.
In questi decenni, complice l’affermarsi – anche a sinistra e persino nel sociale – delle campagne demagogiche sulla sicurezza, ogni ragionamento critico sulla pena è stato zittito o ignorato e non ha più trovato spazio e cittadinanza. Si è così dato per scontato che la reclusione potesse essere – come in effetti è divenuta – la risposta a ogni tipo di devianza e di lacerazione sociale.
Si è passati, in poco tempo e con scarsissime resistenze, da un dibattito sul “liberarsi della necessità del carcere” all’accettazione quasi a 360 gradi di logiche autoritarie, di tolleranza zero, di legge e ordine.
Lo Stato penale ha così soppiantato lo Stato sociale e ha usato lo strumento carcerario per stigmatizzare i comportamenti individuali e per criminalizzare la povertà.
Pochi, pochissimi, hanno tentato di contrastare queste nefaste parole d’ordine, anch’esse di importazione dagli Stati Uniti, dove basti sapere che il 20% dei neri è sottoposto a misure penali e che l’area di quanti sono sottoposti a misure penali pochi anni fa ha superato i sette milioni di individui, perlopiù appunto appartenenti alle minoranze etniche e alle classi deboli.
Come dagli USA è stata copiata la normativa, e la filosofia sottostante, le discipline sulle droghe.
I risultati li abbiamo visti, sia lì che qui, e sono ancora operanti.
A partire dai primi anni Novanta in Italia la normativa sugli stupefacenti ha avuto un impatto devastante, con le decine di migliaia di persone che finiscono in carcere sulla base di quell’unica legge ma anche sulle centinaia di migliaia che sono comunque sottoposte a sanzioni amministrative per possesso di sostanze stupefacenti: in poco più di 20 anni sono state 853.004!
Il carcere è così diventato un deposito di quelli che il criminologo Nils Christie ha efficacemente definito “nemici perfetti”, vale a dire di quei soggetti e gruppi sociali facilmente stigmatizzabili e da sempre oggetto di processi di esclusione: tossicodipendenti, appunto, e poi immigrati, senza dimora, giovani delle periferie urbane. Il carcere è diventato un contenitore, ma anche un’impresa, possibilmente da privatizzare. Per dirla con le parole di una studiosa, Elisabetta Grande, è avvenuta «la trasformazione del povero da figura economicamente inutile se in libertà, a soggetto economicamente redditizio quando prigioniero».
Il carcere, dicono i giuristi, dovrebbe essere l’extrema ratio. Figure come il compianto cardinal Martini sono giunte a sostenere che il carcere può essere giustificato solo come misura di emergenza per interrompere una violenza in atto.
In passato sono esistiti movimenti che avevano portato avanti lunghe battaglie culturali, politiche e sociali per arrivare appunto a liberarsi dalla necessità del carcere.
Come vediamo, le cose sono andate in modo diametralmente opposto: il carcere è la risposta prioritaria e centrale a ogni tipo di reato e di devianza; la misura della pena è divenuta sempre più esorbitante e sganciata da principi di proporzionalità con il bene leso; il pensiero e la pratica politica si sono insomma piuttosto liberati dalla necessità di riformarlo il carcere, relegato a comodo contenitore di povertà e a sostituto autoritario delle politiche sociali.
Queste logiche, poi, hanno portato a un irrigidimento complessivo del sistema penitenziario e a quelle forme di tortura legalizzata che pochissimi si ostinano a denunciare: il 41 bis, l’ergastolo e l’ergastolo cosiddetto ostativo in primo luogo. Una realtà che riguarda una quota nemmeno piccola di reclusi: sono infatti 710 le persone sottoposte alla tortura del 41 bis, 8.914 quelle in regime di alta sicurezza e 1.582 quelle in espiazione dell’ergastolo.
Se questo è il quadro che parla, senza esagerazione, di una vera e propria persecuzione di massa, per riprendere il filo di un discorso necessariamente critico e adeguatamente riformatore bisogna però riformulare il vocabolario con il quale, anche noi, ragioniamo di carcere e di pena, giacché si tratta anche di recuperare maggiore laicità nel dibattito su questi temi.
Da quando, e sono ormai quasi 40 anni, una parola nobile come “pentimento” è stata svilita dall’uso giornalistico e giudiziario che è poi diventato linguaggio comune, progressivamente ma inesorabilmente i termini e le categorie con i quali si riflette sul sistema penale e penitenziario hanno visto slittamenti e accentazioni anche importanti ma pertinenti semmai ad altri campi e discipline.
Così, sempre più spesso, anche noi, parliamo di colpa e di male, scriviamo sui nostri giornali del “buio dell’anima” e insistiamo sui meandri della psiche, ma abbiamo smesso di ricercare, analizzare e denunciare le cause sociali del crimine e abbiamo abbandonato ogni consapevolezza di come e quanto la questione criminale sia anzitutto questione sociale, come insegnava il padre della criminologia critica, Alessandro Baratta.
Anche noi, in qualche modo, talvolta ci prestiamo, certo in buona fede e con le migliori intenzioni, a processi di stigmatizzazione e di etichettamento morale, venendo così meno al nostro ruolo. Che, nel caso specifico, è certo quello di rispettare Abele sapendo però difendere Caino, non prestandosi a metterli in contraddizione e conflitto e ricordando sempre quel che ha scritto Sandro Margara: «Il carcere crea innocenza, trasformando anche il colpevole in vittima».
Nella Genesi, sulla fronte di Caino è stato posto un segno, non un marchio.
Da tempo, venuta meno una cultura critica sul carcere e sulla pena, in questo Paese si vede invece una voglia diffusa di gogna pubblica, di inchiodamento perpetuo del reo al suo reato. Sino a che morte non sopraggiunga. E anche dopo, per la verità. Abbiamo visto di recente persone indagate per aver partecipato al funerale di un ex brigatista.
Le parole, insomma, sono importanti. Il principio di ogni cosa. E tanto più lo sono nei luoghi e nei momenti dove la libertà viene sacrificata o sottratta.
Perciò non bisogna avere paura delle parole, anche se appaiono dure e scomode o addirittura violente. Perché spesso violente sono le cose, non le parole che le descrivono.
E non bisogna avere paura neppure di riprenderla la parola, anche se troppi ci vorrebbero zitti e invisibili. Perché anche l’imposizione del silenzio è una forma di annichilimento, di uccisione simbolica ma al tempo stesso concreta.
Se la pena di morte è, come è, un omicidio di Stato premeditato, la morte per pena è un omicidio di Stato distrattamente e quotidianamente posto in essere non solo da leggi incivili ma anche, e forse prima, da opinioni pubbliche indifferenti nonché abituate – grazie a un certo modo di fare informazione e a una abdicazione morale di gran parte dell’intellettualità italiana – a considerare normali e legittimati sentimenti e pratiche di vendetta.
Vorrei terminare con la citazione di un filosofo con la quale il professor Umberto Veronesi chiude la sua prefazione al Rapporto 2013 di Nessuno tocchi Caino:
«La civiltà di un Paese si misura dalle carceri e dalle scuole: quando le scuole cesseranno di essere carceri e le carceri inizieranno a essere delle scuole, potremo dire di vivere in un Paese civile».
Questo carcere di Padova ieri e oggi è stato una scuola. Quando ciò avverrà 365 giorni l’anno e riguarderà tutti gli istituti d’Italia, solo allora, allora sì, potremo dire di abitare in un paese umano e civile.