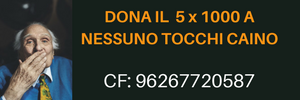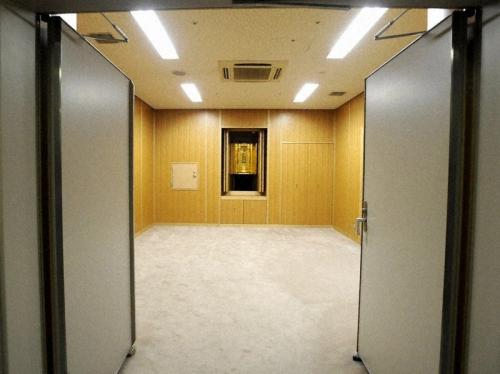15 Novembre 2025 :
Iacopo Benevieri su l’Unità del 15 novembre 2025
Conosciamo il disinteresse che da sempre la politica manifesta nei confronti della condizione carceraria, disinteresse che riflette una percezione diffusa nella società contemporanea, quella che equipara il criminale a colui che è stato espulso dalla comunità civile, destinatario dell’infamia e del bando collettivi. In questa rappresentazione il carcere continua a restare un luogo irrappresentabile, oggetto di una rimozione psichica collettiva.
La stessa etimologia della parola “crimine” rivela il nesso tra questo concetto e quello di esclusione sociale. Nella seconda metà dell’Ottocento il linguista svizzero Pictet sottolinea come in latino la parola crimen derivi dal verbo “cerno”, che significa sì “decidere”, ma anche “discernere, distinguere, separare, dividere”: ciò che viene separato, ciò che viene diviso implica l’idea di un limite che viene superato, di una soglia che è stata varcata socialmente. Crimen dunque è quell’azione umana che ha passato una soglia, ha oltrepassato il perimetro della comunità civile.
Una suggestiva conferma ci proviene proprio dallo stesso Pictet quando individua l’etimologia latina di “crimen” nel sanscrito “karman”, che significa “fatto umano compiuto”, stabilendo un legame tra l’atto umano e le sue conseguenze. Crimen è l’azione di colui che ha passato la soglia, di chi ha superato il varco della comunità civile, portandosi dietro quelle conseguenze irrogate dalla stessa comunità.
Nell’ambito del diritto penale ci sono altre parole che rappresentano il fatto illecito come atto di deviazione, di separazione dal sentiero di una collettività, superamento di una soglia. Una di queste parole è “delinquente”. Trae origine dal latino dēlinquo, verbo composto della particella “de” con il verbo “linquo”, che significa “lasciare, abbandonare, divergere”. Delinquente, pertanto, è colui il quale devia dalla strada della convivenza civile, e, conseguentemente, è il “deviante” (altro termine diffuso nel lessico giuridico) rispetto ai viandanti. È chi oltrepassa il confine.
Il crimine e il delitto dunque sono gli atti di colui che ha oltrepassato un perimetro sociale, lo ha valicato, si è posto fuori dalla collettività ed è lì a rappresentare per gli altri consociati l’esistenza stessa del limite da non superare (così Durkheim circa la centralità dell’interdetto nella definizione dei fenomeni sociali). Infatti a partire dalla metà del Cinquecento, nelle Piazze di tutti gli Stati italiani e d’Europa vengono emessi numerosi bandi proprio contro coloro che potevano costituire minaccia per la convivenza civile, con l’ordine di abbandonare la città, di oltrepassare fisicamente il confine della comunità civile, confine già superato con le condotte illecite. Nei secoli successivi gli strumenti di allontanamento del delinquente rispetto alla Piazza civile si succederanno nelle varie forme della condanna alle galee, poi dell’internamento in case di correzione e infine della detenzione in carcere.
Dunque la configurazione di un territorio «sicuro» contro la «turba infame» ha essenzialmente a che fare con l’attività di tracciamento di confini e di separazione di due territori: confini di inclusione e di esclusione, confini di assegnazione di identità. La stessa costruzione di identità, cioè di inclusione e appartenenza sociale, viene definita anche attraverso la narrazione dell’esclusione: ci percepiamo come “inclusi” in quanto non si appartiene a chi non lo è, a chi è stato allontanato dalla comunità. Ancora, torna il tema di “separare”, “dividere” di pertinenza della parola “crimen”.
Per funzionare i confini devono essere percepibili dai consociati, anche se si tratta di confini non necessariamente visivi. Un confine può venire tracciato in molti modi, anche attraverso la comunicazione. Nella narrazione quotidiana dei mass-media, infatti, l’esperienza dei detenuti è rappresentata come esperienza oltre-confine, oltre il perimetro dei diritti e delle garanzie, come uno spazio appunto “ob-sceno”, cioè fuori dalla scena di ciò che può esser rappresentato e di cui occuparsi. Questa, però, dovrebbe esser la missione del diritto in un Paese democratico: occuparsi delle minoranze che fanno esperienze fuori dal “centro” della comunità, occuparsi di chi vive sulle “soglie” o anche oltre le soglie, occuparsi delle umanità “decentrate” e riportarle al centro dell’interesse giuridico come lo sono al centro della nostra Costituzione.