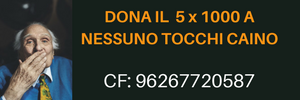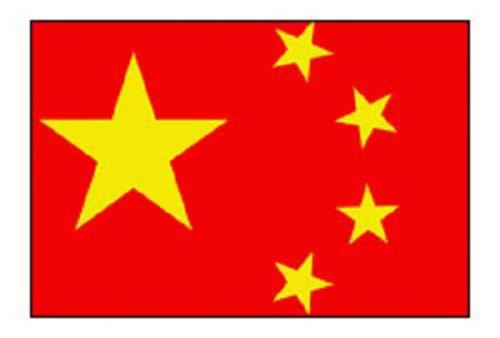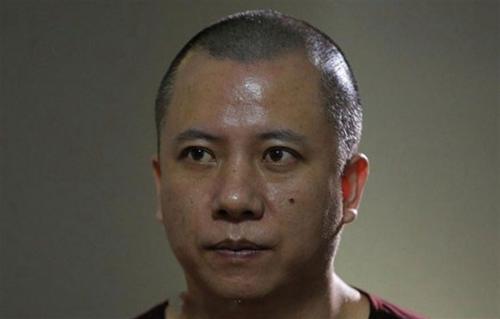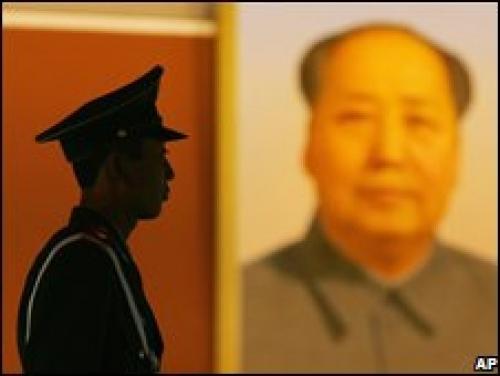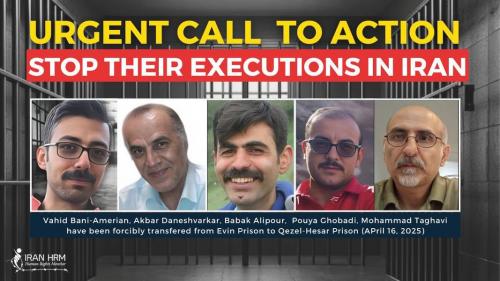situazione:Nel febbraio 2011, il Congresso Nazionale del Popolo ha approvato un emendamento al Codice Penale che riduce di 13 il numero dei reati punibili con la pena di morte, portandoli a 55. I 13 reati non più punibili con la pena capitale sono per lo più di natura economica e non violenta. L’emendamento stabilisce inoltre che la condanna a morte non possa essere imposta a persone che al momento del processo abbiano 75 anni e oltre, fatta eccezione per i casi di omicidio commesso con eccezionale crudeltà. In precedenza, solo i minori di 18 anni al momento del crimine e donne incinte al momento del processo non erano passibili di morte.
Il 27 ottobre 2014, un progetto di modifica del Codice Penale che eliminerebbe la pena di morte per nove reati è stato presentato per una prima lettura al Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo durante la sua sessione bimestrale. I nove reati comprendono il contrabbando di armi, munizioni, materiali nucleari o denaro contraffatto; contraffazione di denaro; raccolta di fondi per mezzo di frodi; favorire o costringere un’altra persona a prostituirsi; ostacolare un comandante o una persona di turno nell’esercizio dei suoi compiti; invenzione di voci per indurre in errore altri in tempo di guerra. Dopo l’eventuale eliminazione dell
a pena di morte per questi crimini, i condannati rischierebbero come pena massima l’ergastolo. La proposta di modifica, se approvata, costituirebbe un altro passo da parte della Cina nel limitare l’uso della pena di morte, e sarebbe la seconda volta che la Repubblica Popolare di Cina riduce il numero di reati capitali da quando il Codice Penale è entrato in vigore nel 1979.
Il 23-24 novembre 2014, all’Accademia Cinese di Scienze Sociali si è tenuta una conferenza sulla pena di morte, che ha coinvolto la Corte Suprema del Popolo, la Procura Suprema del Popolo e altri dipartimenti governativi, così come esperti dell’Università di Tsinghua, dell’Università di Scienze Politiche e Giurisprudenza. Hu Yunteng, responsabile dell’Ufficio Studi della Corte Suprema ha detto che per riformare la pena di morte occorre concentrarsi su misure legislative e giudiziarie volte a ridurre il numero di reati capitali e l’uso giudiziario della pena di morte. Il Giudice Hu ha dichiarato che la pena di morte verrà mantenuta, ma l’obiettivo è applicarla al 100% in modo corretto per evitare errori giudiziari.
Anche se la pena di morte continua a essere considerata in Cina un segreto di Stato, negli ultimi anni si sono succedute notizie, anche di fonte ufficiale, in base alle quali condanne a morte ed esecuzioni sarebbero via via diminuite rispetto all’anno precedente.
Tale diminuzione è stata più significativa a partire dal 1° gennaio 2007, quando è entrata in vigore la riforma in base alla quale ogni condanna a morte emessa da tribunali di grado inferiore deve essere rivista dalla Corte Suprema.
Nel 2006, media statali avevano riportato le stime di un esperto cinese, Liu Renwen, direttore del dipartimento di diritto penale della Facoltà di Legge dell’Accademia Cinese di Scienze Sociali, secondo cui il numero di circa 8.000 esecuzioni l’anno era allora un dato ‘realistico’.
Da quando il potere di revisione finale delle condanne a morte è stato restituito alla Corte Suprema del Popolo nel 2007, il numero delle esecuzioni a livello nazionale potrebbe essere sceso di oltre un terzo, con punte di quasi il 50 per cento in alcune regioni, ha riferito il Southern Weekly nel 2014 citando un esperto interno al sistema giudiziario.
Nel 2013, il 39 per cento di tutti i casi capitali sottoposti a revisione della Corte Suprema è stato rispedito alle alte corti provinciali per ulteriori prove, ha detto il Southern Weekly citando l’intervento di un funzionario della Corte a un seminario giuridico. Un ex giudice anziano della Corte Suprema ha detto al Southern Weekly che la Corte attualmente rovescia meno del 10 per cento delle condanne a morte, mentre negli anni immediatamente dopo il 2007 il tasso è stato di circa il 15 per cento.
La politica della “giustizia mitigata dalla clemenza”
La Fondazione statunitense Dui Hua ha stimato che la Cina ha giustiziato 2.400 persone nel 2013, lo stesso numero di esecuzioni previsto nel 2014. Questo dato rappresenta un calo del 20 per cento rispetto alle circa 3.000 esecuzioni del 2012 e un calo dell’80 per cento rispetto alle 12.000 del 2002.
Secondo la Dui Hua, la riduzione è stata probabilmente determinata da un maggiore utilizzo della pena di morte con due anni di sospensione (che è quasi sempre commutata nel carcere a vita o a una pena detentiva a termine), dai miglioramenti in materia di giusto processo recentemente codificati nelle revisioni al codice di procedura penale dalla Corte Suprema del Popolo che ha continuato a riesaminare le sentenze capitali e dalla decisione di abbandonare l’uso di prigionieri giustiziati come fonte primaria in Cina per la donazione di organi.
Il 12 marzo 2015, presentando il suo rapporto alla sessione annuale del Congresso Nazionale del Popolo, il Presidente della Corte Suprema del Popolo, Zhou Qiang, si è rigorosamente attenuto alla linea governativa di tradizionale segretezza, non fornendo statistiche sul numero delle condanne a morte o delle esecuzioni.
Nel 2014, i tribunali cinesi a vari livelli hanno definito circa 1.020.000 casi penali, condannando circa 1.180.000 persone, un incremento del 7,2 e del 2,2 per cento rispettivamente in rapporto al 2013. I tribunali cinesi hanno trattato 248.000 casi di reati violenti, tra cui omicidio, sequestro di persona e rapina. In totale, 304.000 persone coinvolte in questi casi sono state condannate e punite. Ma ancora una volta il primo giudice cinese non ha rivelato quante sono state “condannate a morte, all’ergastolo o a oltre cinque anni di carcere”, che era la formula onnicomprensiva nella quale in passato la Corte Suprema racchiudeva le “pene severe” comminate nei processi.
Nel 2014, la Corte Suprema del Popolo ha trattato 11.210 casi di vario tipo, l’1,8 per cento in più rispetto al 2013, e ha concluso 9.882 casi, in crescita dell’1,7 per cento, secondo il rapporto di Zhou.
Considerato che almeno il 90 per cento dei casi trattati dalla Corte è composto da casi capitali, una stima approssimativa ma realistica sarebbe quella che fissa il numero dei casi capitali del 2014, tra quelli definitivi e quelli sospesi per due anni, intorno agli 8.900, un po’ di più rispetto ai circa 8.700 stimati nel 2013.
Considerato inoltre che, sin dal febbraio 2010, la Corte Suprema ha raccomandato di adottare la politica della “giustizia mitigata dalla clemenza”, suggerendo ai tribunali che i criminali non meritevoli di immediata esecuzione debbano essere condannati a morte con due anni di sospensione, è realistico ritenere che le esecuzioni nel 2014 siano state almeno 2.400, più o meno come nel 2013.
Le riforme della Corte Suprema
La riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2007 è ritenuta una delle più importanti sulla pena di morte in Cina e segna un’inversione rispetto alle campagne del “colpire duro” avviate negli anni 80 e che avevano portato nel 1983 la Corte Suprema a delegare alle corti provinciali la definizione in ultima istanza dei casi capitali.
In base alla riforma del 2007, la revisione di ogni caso giudiziario è effettuata da un panel di tre giudici della Corte Suprema, che devono riesaminare tutte le prove, la legge applicata, la commisurazione della pena, il dibattimento nel precedente processo e devono sentire l’imputato di persona o per lettera prima di giungere alla decisione finale. Se i giudici reputano insufficienti le prove, non commisurata la pena o illegale il dibattimento, devono sottoporre il caso al comitato giuridico della Corte Suprema, il quale è tenuto a esaminarlo con un magistrato della Procura Suprema. I casi capitali che non abbiano avuto un processo d’appello pubblico non sono rivisti dalla Corte Suprema ma sono rinviati alla corte di seconda istanza per lo svolgimento di un pubblico processo.
Dopo la riforma del 2007, la Cina ha continuato ad adottare nuove misure per limitare il numero delle condanne a morte e prevenire quelle errate.
Nel maggio 2008, la Corte Suprema e il Ministero della Giustizia cinesi hanno emanato congiuntamente un regolamento sul ruolo degli avvocati difensori nei casi capitali, il quale dispone che le istituzioni di sostegno legale debbano designare avvocati esperti di casi capitali e che questi ultimi non possano trasferire il caso ai propri assistenti.
Nel 2011, la Corte Suprema ha raccomandato ai tribunali di “sospendere la condanna a morte per due anni in tutti i casi che non richiedono l’esecuzione immediata”. Nella normale pratica giudiziaria, in questi casi la condanna è commutata in ergastolo dopo due anni. La Corte Suprema ha raccomandato inoltre di “applicare la pena di morte solo a un’estrema minoranza di criminali responsabili di crimini molto gravi”.
Nel marzo 2012, il Congresso Nazionale del Popolo ha riformato la legge di procedura penale in senso più garantista. Secondo la riforma, la Corte Suprema, nel corso del procedimento di verifica, può interrogare l’imputato e deve sentire le argomentazioni dell’avvocato difensore, se ne fa richiesta. Inoltre, per la prima volta, la riforma chiarisce che le confessioni estorte con mezzi illegali, come la tortura, le deposizioni dei testimoni e delle vittime ottenute illegalmente devono essere escluse dai processi. Per evitare le confessioni estorte illegalmente, gli indagati, dopo essere stati fermati o arrestati, devono essere condotti in un centro di detenzione per la custodia cautelare e l’interrogatorio deve essere audio o video-registrato.
Il 22 gennaio 2015, la Corte Suprema del Popolo ha ribadito che i criteri per infliggere la pena capitale devono essere rigorosamente rispettati in modo da garantire che tale pena sia “utilizzata solo per pochissimi condannati i cui crimini siano estremamente gravi”.
Maggiore trasparenza nei processi giurisdizionali
Assoluzioni nel sistema giudiziario cinese sono state estremamente rare in passato, considerato che la quasi totalità degli imputati è stata sempre giudicata colpevole, secondo le statistiche ufficiali. La Cina ha di tanto in tanto esonerato detenuti condannati ingiustamente dopo che altri hanno confessato i loro crimini oppure, in alcuni casi, perché la presunta vittima di omicidio è stata poi ritrovata viva.
Nel 2014, tuttavia, i tribunali cinesi hanno riesaminato 1.317 casi e corretto una serie di sentenze sbagliate, secondo il rapporto di Zhou Qiang alla sessione del 2015 del Congresso Nazionale del Popolo. In quella occasione, il Presidente della Corte Suprema ha espresso “profondo rimorso” per questo. “Ci dobbiamo vergognare di queste condanne errate e i tribunali a tutti i livelli dovrebbero imparare una seria lezione da questi casi”, ha detto Zhou. Nel 2014, la Corte Suprema ha continuato a lavorare per migliorare la trasparenza nei processi giurisdizionali. Relazioni annuali sul lavoro dei tribunali sono state pubblicate e documenti giudiziari sono stati messi online e le parti hanno potuto seguire il procedere dei loro casi giudiziari attraverso i siti web. Supervisione giurisdizionale e trasparenza sono essenziali per prevenire condanne errate.
Il 22 agosto 2014, l’Alta Corte della Provincia del Fujian ha dichiarato innocente e liberato Nian Bin, un uomo condannato a morte nel 2008 per l’avvelenamento di due bambini e tenuto in carcere da allora. “Nessuna delle prove presentate nel caso è stata adeguatamente verificata”, ha detto la corte del Fujian in un post sul suo microblog che annuncia l’innocenza di Nian. Il 17 febbraio 2015, un tribunale cinese gli ha riconosciuto un risarcimento di 1,14 milioni di yuan (189 mila dollari) per la perdita della libertà personale e la sofferenza psichica subita, ha riportato la Xinhua.
Il 9 settembre 2014, Xu Hui è stato dichiarato innocente dal Tribunale Intermedio del Popolo di Zhuhai dopo essere stato condannato a morte 13 anni prima dalla Corte di Zhuhai per aver violentato e ucciso una ragazza di 19 anni. Xu aveva ripetutamente protestato la sua innocenza, ma tutti i ricorsi sono stati respinti dai tribunali locali fino a che la Procura Suprema del Popolo (PSP) ha trovato la confessione del sospettato contraddetta da prove fornite nel 2007.
Nel dicembre 2014, dopo una revisione postuma del processo, l’Alta Corte del Popolo della Mongolia Interna ha assolto un ragazzo di 18 anni di nome Hugjiltu giustiziato per stupro e omicidio nel 1996. Un dubbio pesante sul verdetto di colpevolezza è sopravvenuto quando un altro uomo ha confessato il delitto nel 2005.
La guerra alla droga
Secondo la legge penale cinese, un trafficante di droga può essere condannato a morte per la produzione, il trasporto o il traffico di un quantitativo pari o superiore a 50 grammi di eroina o a un chilo di oppio. Anche i trafficanti catturati con 150 chili di marijuana rischiano la pena di morte. La condanna più mite per un tale reato è di 15 anni.
Tra gennaio e ottobre 2014, più di 84.000 condannati per droga sono stati messi dietro le sbarre, ha rivelato la Corte Suprema del Popolo, secondo la Xinhua. Circa il 27 per cento ha ricevuto sanzioni che vanno dai cinque anni di carcere alla condanna a morte, secondo la Quinta Sezione Penale della Corte Suprema. Nel mese di giugno, alla vigilia della Giornata internazionale contro l’abuso di droga, il Presidente cinese Xi Jinping ha annunciato un giro di vite sul traffico di droga. Lo stesso giorno, la Corte Suprema ha detto che vi era stato un aumento del traffico di droga nel Paese, sottolineando che 39.762 persone erano state condannate per reati di droga solo tra dicembre 2013 e aprile 2014, che indica un aumento del 27,8 per cento in rapporto allo stesso periodo dell’anno prima. Quattro persone sono state giustiziate per droga durante lo stesso periodo.
Il numero effettivo di esecuzioni per reati di droga è sconosciuto, anche se è apparentemente diminuito nel 2013-2014 rispetto agli anni precedenti per effetto della riforma del 1° gennaio 2007 che ha riconsegnato alla Corte Suprema del Popolo il potere esclusivo di revisione finale di tutte le condanne a morte, oltre che delle direttive della Corte Suprema che ha stabilito che la pena di morte vada inflitta solo a “un numero estremamente ridotto di criminali efferati”.
In ogni caso, come’è sempre accaduto in Cina, condanne a morte ed esecuzioni sono aumentate sensibilmente in prossimità di feste nazionali o di date simboliche internazionali come il 26 giugno, Giornata Internazionale Contro la Droga.
La civiltà dell’iniezione letale
Le sentenze capitali sono per lo più eseguite con un colpo di fucile sparato a distanza ravvicinata al cuore oppure alla nuca.
Nel 1996, con un emendamento al Codice di Procedura Penale, la Cina ha autorizzato esecuzioni tramite iniezione letale, per la quale sarebbe stato usato lo stesso cocktail di tre farmaci introdotto per la prima volta negli Stati Uniti. “L’iniezione è più umana, riduce la paura e la sofferenza”, hanno dichiarato le autorità cinesi. “E’ preferita sia dai condannati sia dai loro familiari.” Il nuovo sistema è “più pulito, più sicuro e più conveniente” rispetto all’uso di armi da fuoco, secondo il direttore del dipartimento ricerca della Corte Suprema del Popolo, Hu Yunteng.
L’iniezione letale è stata applicata per la prima volta il 28 marzo 1997 a Kunming, capoluogo della Provincia dello Yunnan.
E’ impossibile sapere quante persone sono state giustiziate con l’iniezione letale, dal momento che in Cina i dati sulla pena di morte sono coperti dal segreto di Stato.
Tra il 6 e il 7 agosto 2014, la Cina ha giustiziato tre cittadini sudcoreani mediante iniezione letale per reati di droga, nelle prime condanne a morte nei confronti di coreani effettuate nel Paese in un decennio.
In molte Province sono state allestite anche delle unità mobili su dei furgoni da 24 posti, opportunamente modificati, che raggiungono il luogo dove si è svolto il processo. Questo evita il trasferimento dei condannati nei posti previsti per le esecuzioni, una procedura che implica notevoli misure di sicurezza. Il detenuto è assicurato con delle cinghie a un lettino di metallo posto sul retro del furgone. Una volta inserito l’ago, un poliziotto preme un bottone e automaticamente la sostanza letale viene iniettata nella vena. Il mezzo è dotato anche di una telecamera che filma l’esecuzione, in modo che rimanga una registrazione audio-video da visionare in caso di eventuali contestazioni procedurali.
Secondo alcuni osservatori sui diritti umani, il passaggio dal colpo di pistola all’iniezione letale avrebbe favorito il traffico illegale di organi dei condannati. Le iniezioni lasciano intatto il corpo e richiedono la presenza di medici. Gli organi possono essere espiantati in un modo più veloce ed efficace che nel caso in cui i detenuti siano fucilati.
In passato, le organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato il collegamento tra l’alto numero di esecuzioni in Cina e la crescente domanda di trapianti, accusando le autorità di costringere i condannati a morte a firmare autorizzazioni all’espianto. Il regime di Pechino ha ammesso nel 2005 di prelevare organi di prigionieri nel braccio della morte, una pratica iniziata a metà degli anni 80. E nel luglio 2006 la Cina ha approvato una legge che proibisce la vendita di organi senza il consenso del donatore. Ciò nonostante, gli espianti illegali di organi in Cina pare siano continuati. In base a una revisione del codice penale adottata nel febbraio 2011, il “prelievo forzato di organi, la donazione forzata di organi e il prelievo di organi da minorenni” sono diventati reati penali, paragonati all’omicidio. Ma, nel marzo 2012, l’allora Vice-Ministro della Salute Huang Jiefu ha ribadito che i prigionieri giustiziati continuano a essere in Cina la principale fonte di organi per i trapianti, a causa della carenza di donatori volontari.
Il 4 dicembre 2014, Huang Jiefu, nel frattempo divenuto capo dell’ufficio trapianti di organi del Ministero della Sanità, ha dichiarato che a partire dal 1° gennaio 2015 potranno essere usati nei trapianti solo organi volontariamente donati da civili. Al dicembre 2014, 38 centri di trapianto in tutto il Paese, compresi quelli di Pechino, Guangdong e Zhejiang, avevano già smesso di utilizzare gli organi dei prigionieri. “Il divieto ha lo scopo di affrontare il problema della carenza di organi”, ha detto Huang 11 marzo 2015. “Quanto più rispettiamo i detenuti del braccio della morte, tanto più avremo donazioni volontarie di organi da parte dei cittadini.” Secondo Huang, la donazione volontaria da parte dei cittadini cinesi è diventata la principale fonte di organi per i trapianti, pari all’80 per cento del totale delle donazioni nel 2014.
Guerra al terrorismo
Il Governo cinese ha usato la lotta al terrorismo come pretesto per aumentare il pugno di ferro contro tutte le forme di dissenso politico o religioso nel Paese. Sospetti separatisti o estremisti religiosi da anni rischiano detenzioni arbitrarie, l’isolamento, la tortura e, al termine di processi iniqui, il carcere o l’esecuzione. In particolare, la Cina fa passare la repressione dei Tibetani e degli Uiguri come lotta contro il terrorismo ed esercita pressioni su Paesi confinanti come il Kirghizistan, il Kazakistan, il Nepal e il Pakistan per costringerli a rimpatriare i militanti dell’etnia uigura, turcofona e musulmana. Molti degli Uiguri rimpatriati hanno subito gravi violazioni dei diritti umani, tra cui torture, iniqui processi e anche esecuzioni.
Secondo la relazione annuale della Corte Suprema del Popolo, illustrata al Congresso Nazionale del Popolo il 12 marzo 2015, i tribunali cinesi hanno trattato 558 casi di terrorismo, tra cui separatismo e attacchi terroristici, con un incremento del 14,8% rispetto al 2013. Un totale di 712 persone coinvolte in questi casi sono state condannate e punite, in crescita del 13,3% rispetto all’anno precedente.
La lotta al terrorismo si è concentrata in particolare nel Turkestan Orientale (o Xinjiang occidentale), la Regione Autonoma nord-occidentale in cui vivono otto milioni di Uiguri (46 per cento della popolazione), in particolare dopo i disordini del luglio 2009 a Urumqi, capoluogo della Regione, che hanno coinvolto sia Han e Uiguri sia le due etnie e la polizia cinese. Le violenze provocarono almeno 197 morti e 1.721 feriti.
Pechino ha annunciato un giro di vite sulla sicurezza della durata di un anno a seguito di un attentato che il 23 maggio 2014 ha provocato la morte di 43 persone e il ferimento di oltre 90 nella capitale della Regione, Urumqi. Dopo l’attacco di Urumqi, la Cina ha detto di aver sgominato 23 bande di terroristi e arrestato più di 200 persone in tre aree del sud dello Xinjiang. Nel corso del 2014, nello Xinjiang, almeno 200 persone sono morte in attentati e scontri tra residenti Uighuri e forze di sicurezza.
Nel 2014, la Cina ha giustiziato almeno 21 Uiguri per “terrorismo”.
Pena di morte per reati non violenti, politici e di opinione
La restituzione nel 2007 alla Corte Suprema del Popolo del potere esclusivo di approvare le condanne a morte ha portato i tribunali del Paese a gestire i casi capitali in maniera più prudente, in particolare quelli relativi a reati non violenti. Nel febbraio 2010, la più alta corte cinese ha emesso anche nuove linee guida sulla pena di morte che indicano ai tribunali minori di limitarne l’applicazione a un numero ristretto di casi “estremamente gravi”.
Secondo la legge attuale, 55 reati sono soggetti alla pena di morte, un terzo dei quali sono reati economici come corruzione e uso di tangenti.
Il Governo cinese ha continuato a negare la detenzione di prigionieri politici, affermando che le autorità hanno arrestato persone non per le loro opinioni politiche o religiose, ma perché hanno violato la legge. Tuttavia, decine di migliaia di prigionieri politici sono ancora in carcere, alcuni in prigioni e altri nei campi di Rieducazione Attraverso il Lavoro o in detenzione amministrativa. Nel dicembre 2013, il Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo ha abolito il sistema della Rieducazione Attraverso il Lavoro (in vigore dal 1° gennaio 2014).
Le autorità hanno continuato ad attuare politiche repressive nella Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang nei confronti della popolazione uigura. I funzionari cinesi nello Xinjiang hanno continuato il loro impegno per reprimere le cosiddette “tre forze”: “estremismo religioso”, “separatismo” e “terrorismo”. Il possesso di pubblicazioni o materiali audiovisivi che parlano di indipendenza, autonomia o altri temi sensibili continua a essere vietato.
Secondo la Dui Hua Foundation, un gruppo di difesa dei diritti umani con sede negli Stati Uniti, le sue stime e la Relazione annuale dell’Alta Corte dello Xinjiang sui casi giudiziari hanno mostrato che, mentre il numero di casi relativi alla Sicurezza dello Stato nella Regione Autonoma è rimasto fermo a circa 300 nel 2014, il numero di processi penali conclusi nella regione è salito di oltre il 40 per cento a 29.511 processi, compresi quelli di primo e secondo grado. Il gruppo ha detto che la campagna anti-terrorismo lanciata dal Presidente Xi Jinping nel maggio 2014 “ha probabilmente giocato un ruolo significativo nella più rigorosa applicazione della legge”.
In una dichiarazione rilasciata il 10 marzo 2015, la Dui Hua ha anche detto che l’aumento significativo dei processi penali indica che anche senza un aumento dei processi per terrorismo e separatismo, i dati evidenziano come le autorità “abbiano intensificato la soppressione del dissenso e l’attivismo per i diritti umani nello Xinjiang”. Processi per violazione dei diritti individuali e democratici dei cittadini sono quasi raddoppiati raggiungendo quasi 7.500 casi. Questa categoria di reati comprende il reato di “incitamento all’odio e alla discriminazione razziali”, che può essere applicato a persone che diffondono informazioni che “offuscano” l’armonia etnica della Cina, ad esempio, sfidando il divieto del Governo su barbe, veli e osservanza religiosa.
La persecuzione di appartenenti a movimenti religiosi o spirituali
Le autorità cinesi ammettono a parole che la libertà di religione rappresenta un fondamentale diritto umano riconosciuto dalla Costituzione e dai principali trattati internazionali. Nei fatti, la libertà religiosa è fortemente ridotta in Cina.
Le minoranze religiose ed etniche sono state un obiettivo chiave della repressione anche nel 2014, in particolare gli appartenenti a movimenti religiosi o spirituali non autorizzati dallo Stato: protestanti e cattolici, musulmani uiguri e buddisti tibetani. Il Governo ha continuato anche la repressione dei movimenti che considera “culti”, in particolare il Falun Gong.
Le nuove “misure per la regolamentazione delle questioni religiose”, approvate dalla Commissione governativa permanente per il Tibet nel settembre 2006 ed entrate in vigore il 1° gennaio 2007, anziché garantire la libertà religiosa rafforzano i poteri dei funzionari cinesi nella restrizione, controllo e repressione del credo buddista.
Il grado di libertà di culto è diverso a seconda delle regioni. Per esempio, nello Xinjiang vi è un controllo ferreo sui musulmani che nel resto del Paese godono invece di una maggior libertà. Lo stesso vale per i buddisti della Mongolia Interna e del Tibet rispetto a quelli di altre zone. Nell’Henan sono stati perseguitati in particolare i protestanti, mentre nell’Hebei i cattolici legati al Vaticano.
Secondo le norme sulle attività religiose, i luoghi in cui si esercita il culto devono essere autorizzati dal Governo e le forze dell’ordine sono spesso intervenute in abitazioni private dove si radunavano dei credenti per interrompere le funzioni con la scusa che disturbavano i vicini o provocavano disordini sociali, anche arrestando i partecipanti e diffidandoli dal riunirsi nuovamente in quel luogo. A volte chi dice messa subisce duri trattamenti come la detenzione, veri e propri arresti e condanne alla rieducazione o al carcere. E anche in questo caso la repressione è stata diversa a seconda delle aree.
Nella Regione Autonoma dello Xinjiang a maggioranza uigura, a seguito gli scontri etnici del 2009, la presenza di forze e dispositivi di sicurezza è rimasta consistente e le autorità hanno intensificato i controlli sull’Islam nella regione.
Secondo i dati diffusi nel rapporto annuale dell’Alta Corte dello Xinjiang citato dalla Fondazione Dui Hua, il numero di processi penali per intralcio ai provvedimenti sociali amministrativi sono raddoppiati nel 2014 fino a superare 4.500 casi. Questa categoria di reati può essere usata per colpire gruppi islamici e cristiani non autorizzati o “sette” e copre attività come la distribuzione di materiale religioso. Processi per violazione dei diritti individuali e democratici dei cittadini sono quasi raddoppiati raggiungendo quasi 7.500 casi, inclusi quelli nei confronti di persone che hanno sfidato il divieto del Governo su barbe, veli e funzioni religiose.
L’11 marzo 2015, Heiner Bieledfeldt, relatore speciale sulla libertà di religione, ha criticato la repressione della Cina in Xinjiang, evidenziando le preoccupazioni per quelle che ha definito storie “inquietanti” di molestie e intimidazioni, “per esempio, intimidazioni durante il Ramadan – ai bambini nelle scuole è stato chiesto di interrompere il loro digiuno”. Ha anche detto che il suo ufficio non ha registrato alcun progresso nella sua richiesta di effettuare una visita ufficiale in Cina. L’ultima volta che è stata accettata è stato nel 2004.
Pechino permette la pratica del protestantesimo solo all’interno del Movimento delle Tre Autonomie (MTA), nato nel 1950 dopo la presa del potere di Mao e l’espulsione dei missionari stranieri e dei leader delle Chiese anche cinesi. Le statistiche ufficiali dicono che in Cina vi sono 10 milioni di protestanti ufficiali, tutti uniti nell’MTA.
Ma, negli ultimi trenta anni, le “chiese domestiche” protestanti sono diventate un fenomeno importante, con oltre 50 milioni di fedeli che si radunano nelle case o altri luoghi privati per pregare, svolgere cerimonie e tenere assemblee. Il loro amore per il libero culto li ha portati a rifiutare le Chiese protestanti ufficiali, colpevoli ai loro occhi di “adorare il partito” piuttosto che Dio. Le autorità cinesi hanno cercato di sopprimere questo movimento incontrollato incarcerando pastori, torturando i credenti e distruggendo case e luoghi di culto. Nel 2012, la Cina ha lanciato una campagna a tutto campo contro le chiese domestiche, i ministri e i fedeli protestanti che dovrebbe essere completata in dieci anni con l’annientamento completo delle chiese domestiche, ha reso noto nell’aprile 2012 la China Aid Association sulla base di fonti e documenti del Partito comunista.
Il Governo ha continuato nella repressione dei cosiddetti “culti”, in particolare nei confronti dei praticanti del Falun Gong, i quali hanno continuato a subire arresti e detenzioni, e vi sono attendibili prove di persone morte a causa di torture e abusi subiti. I praticanti che si rifiutano di abiurare spesso subiscono dure punizioni in carcere, condanne alla rieducazione in campi di lavoro e in campi extra-giudiziari.
Aderenti al Falun Gong che si trovano all’estero affermano che, a partire dalla dura repressione avviata nei loro confronti nel 1999, centinaia di migliaia – se non milioni – di praticanti sono ancora sotto custodia nei campi di lavoro o in prigione, il che farebbe di loro la più grande comunità di prigionieri di coscienza del Paese. Decine di migliaia hanno subito torture per mano della polizia e degli agenti della sicurezza.
Il sito ufficiale del Falun Gong, en.minghui.org, al 30 giugno 2015, ha registrato un totale di 3.858 morti confermate di praticanti in seguito a varie forme di persecuzione dal 1999. Per le difficoltà a ottenere informazioni dalla Cina, è probabile che questo dato sia significativamente più alto.
Le Nazioni Unite
Nell’ottobre 2013, la Cina è stata sottoposta al Riesame Periodico Universale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Il 19 marzo 2014, nella sua risposta alle richieste pervenute, il Governo cinese ha respinto le raccomandazioni volte a: proseguire le riforme verso l’abolizione della pena di morte, tra cui una maggiore trasparenza sul suo utilizzo; pubblicare o rendere disponibili informazioni precise sull’identità e il numero delle persone in attesa di esecuzione e di coloro che sono stati giustiziati; istituire una moratoria sull’applicazione della pena di morte, come primo passo verso la sua abolizione definitiva.
Il 18 dicembre 2014, la Cina ha votato contro la Risoluzione per una Moratoria delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.